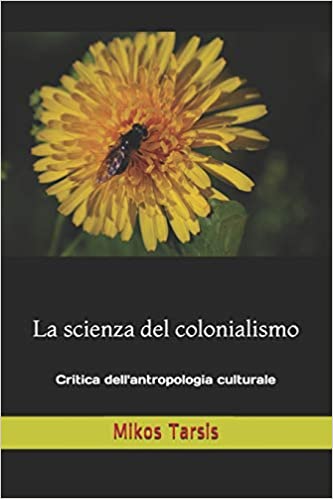
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Piste
di ricerca antropologica
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Tutti i programmi di sviluppo decisi dall'occidente, al fine di indurre le popolazioni del Terzo Mondo (1) a ripercorrere, con l'aiuto delle organizzazioni internazionali, le tappe che hanno portato l'Europa occidentale e gli Stati Uniti al benessere diffuso, si sono rivelati piuttosto fallimentari. Quando sembra che non lo siano, come p.es. in Cina, l'occidente insorge a difendere in tutte le maniere la propria produzione. La regola è “svilupparsi sì, ma fino a un certo punto”.
Di fatto il 10% della popolazione mondiale continua a vivere con meno di due dollari al giorno, secondo le stime della Banca Mondiale (i cui presidenti sono quasi sempre stati nordamericani), la quale è specializzata nel sottovalutare la gravità dei problemi, salvo non abbia bisogno di fare il contrario per venire incontro agli interessi dei grandi potentati che la finanziano.
L'obiettivo, sommamente utopistico, dell'ONU, di eliminare la povertà estrema entro il 2030, si avvale di questi strumenti: 1) vaccini, farmaci e antiparassitari (tutte cose chimiche); 2) internet e telefonia mobile (tutte cose che richiedono una certa competenza intellettuale e una certa disponibilità di risorse economiche ed energetiche); 3) liberalizzazione dei commerci (favorevole soprattutto alle multinazionali)!
Da tempo gli antropologi più intelligenti han capito che la parola “sviluppo”, essendo connessa a indici meramente quantitativi, non può che danneggiare le comunità indigene.
Una prima, significativa, inversione di tendenza sembra provenire dal Kenya. L'attivista politica, ambientalista e biologa. Wangari Muta Maathai (1940-2011) (2), prima donna africana ad aver ricevuto il premio Nobel per la pace, fondò nel 1977 il Green Belt Movement, noto soprattutto per le sue campagne di riforestazione condotte tra gli agricoltori kenioti, che per il 70% sono donne. Grazie a lei sono stati piantati oltre 51 milioni di alberi in Kenya per combattere l'erosione del terreno, causata dal fatto che il governo distribuiva terre statali ai propri protetti, i quali le disboscavano per far posto a grandi piantagioni di tè e caffè.
Il programma si è esteso ad altri 20 paesi africani. Alberi da frutta e da legna venivano piantati attorno alle scuole, alle chiese, ai campi coltivati, fino al punto in cui nacque il Pan African Green Belt Network, che in quindici paesi ha realizzato una cinta verde di quasi 30 milioni di alberi lungo l'Africa subsahariana.
Il movimento combatteva in Kenya anche la corruzione del partito unico anticomunista di Daniel Toroitich arap Moi, presidente dal 1978 al 2002, molto abile nello sfruttare le sempre presenti paure delle piccole tribù dominate dalle grandi. Chiedeva anche la cancellazione del debito estero dei paesi più poveri. Occupò terre pubbliche cedute spesso illegalmente a società straniere, campi da golf costruiti per gli amici del presidente e persino il parco al centro di Nairobi, dove il presidente intendeva costruire un grattacielo e farne la sede del proprio partito. Le campagne di diffamazione, gli arresti e i processi si moltiplicarono. Le donne del movimento cominciarono a preoccupare seriamente il governo, che iniziò una repressione molto forte, suscitando proteste a livello internazionale. La Maathai però diventò vice ministro dell'ambiente e delle risorse naturali. Nel 2004 rilasciò un'intervista-choc in cui sosteneva che il virus dell'AIDS era stato creato da scienziati occidentali per decimare la popolazione africana.
La Maathai ha scritto tre libri:
Solo il vento mi piegherà, Sperling & Kupfer, Milano 2007.
La sfida dell'Africa, Nuovi Mondi, Modena 2010.
La religione della terra, Sperling & Kupfer, Milano 2011.
Un altro progetto da prendere in considerazione è quello dell'ambientalista indiana Vandana Shiva (1952), fondatrice nel 1982 dell'istituto Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy. È stata tra i principali leader dell'International Forum on Globalization, ed è vicepresidente di Slow Food. Ha fondato il movimento Navdanya per poter raccogliere, conservare e coltivare quante più varietà possibili di semi, contro la politica delle multinazionali, che fanno produrre solo i semi più redditizi, oppure quelli modificati geneticamente.
Shiva correla nettamente la povertà del Terzo Mondo agli effetti della globalizzazione. È nettamente contraria alle monocolture delle multinazionali, che incoraggiano i contadini a coltivare raccolti a cosiddetto “alto rendimento”, poiché esse alterano gli equilibri del territorio, minacciano la biodiversità e costringono a usare dosi elevate di insetticidi, fitofarmaci, fertilizzanti chimici (il che avvelena la terra, la insterilisce, provoca la scomparsa di insetti indispensabili per l'impollinazione delle piante). Denuncia l'utilizzo delle riserve di acqua per piante idrovore quali la canna da zucchero e l'eucalipto. Ritiene che gli OGM utilizzati durante la rivoluzione verde indiana, forniti dagli Stati Uniti, abbiano causato una forte perdita di fertilità del suolo e anche un forte indebitamento da parte dei contadini, poiché i costosi semi non si adattano facilmente alle condizioni locali, per cui richiedono più investimenti in sostanze chimiche e irrigazione. Non solo, ma i brevetti di varietà agricole ibride ha consentito alle multinazionali del settore agricolo di appropriarsi di saperi millenari, espropriandone i contadini.
Queste e molte altre sue tesi sono state contestate persino da molti ecologisti, i quali, esattamente come gli economisti borghesi, ritengono che, senza un aumento delle rese basato sull'innovazione agricola e un uso più efficiente della terra, non è possibile rispondere ai problemi di nutrizione del pianeta né, tanto meno, proteggere l'ambiente. Costoro hanno il terrore che si riporti il sistema agricolo (indiano o di altri paesi terzomondiali) a livelli pre-industriali, quelli in cui ci si basava sull'autoconsumo.
Le sue principali pubblicazioni reperibili in lingua italiana:
Terra Madre. Sopravvivere allo Sviluppo, ed. UTET, Torino 2002.
(con Kartikey Shiva), Il pianeta di tutti. Come il capitalismo ha colonizzato la Terra, ed. Feltrinelli, Milano 2019.
Fare la pace con la terra, ed. Feltrinelli, Milano 2011.
(con Lionel Astruc), La terra ha i suoi diritti. La mia lotta di donna per un mondo più giusto, ed. EMI, Bologna 2016.
Il bene comune della terra, ed. Feltrinelli, Milano 2015.
Ritorno alla Terra. La fine dell'ecoimperialismo, ed. Fazi, Roma 2009.
Brevettare la natura, Consorzio Festivalfilosofia, Modena 2012.
Le nuove guerre della globalizzazione. Sementi, acqua e forme di vita, ed. UTET, Torino 2006.
Storia dei semi, ed. Feltrinelli, Milano 2013.
Semi del suicidio. I costi umani dell'ingegneria genetica in agricoltura, ed. Odradek, Roma 2009.
Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio, ed. Feltrinelli, Milano 2015.
Le guerre dell'acqua, ed. Feltrinelli, Milano 2019.
Semi di libertà, ed. Castelvecchi, Roma 2019.
(con Bhushan Patwardhan, Mira Shiva), Cibo e salute. Manuale di resistenza alimentare, ed. Terra Nuova Edizioni, Firenze 2018.
Il mondo del cibo sotto brevetto. Controllare le sementi per governare i popoli, ed. Feltrinelli, Milano 2015.
Il mondo sotto brevetto, ed. Feltrinelli, Milano 2003.
Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura “scientifica”, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1995.
Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari globali, ed. DeriveApprodi, Roma 2004.
Campi di battaglia. Biodiversità e agricoltura industriale, Edizioni Ambiente, Milano 2009.
India spezzata. Diversità e democrazia sotto attacco, ed. Il Saggiatore, Milano 2011.
Dalla parte degli ultimi. Una via per i diritti dei contadini, ed. Slow Food, Bra (CN) 2009.
Biopirateria. Il saccheggio della natura e dei saperi indigeni, ed. CUEN, 1999.
Campi di battaglia, Edizioni Ambiente, Milano 2009.
Un contadino ottantenne del Burkina Faso, Yacouba Sawadogo, che ha diffuso un'antica tecnica agricola per invertire la desertificazione, è stato tra i vincitori, nel 2018, del Premio Nobel Alternativo, istituito in Svezia dalla “Right Livelihood Award Foundation” per omaggiare “persone coraggiose che trovano soluzioni ai problemi globali”. (3) Il premio prevede un contributo di 290.000 euro ed è stato riconosciuto a un uomo che aveva lavorato 40 anni a Yatenga, un'arida provincia del nord del Burkina Faso, per fermare il deserto.
Sawadogo, che aveva già vinto il “Farmers Friend” nel 2013, è riuscito a trasformare la terra sterile in foresta, in grado di concentrare acqua e sostanze nutritive, consentendo così alle colture di resistere alla siccità. Si tratta di una tecnica non convenzionale, chiamata "fosse zaï", basata su un metodo antico che era caduto in disuso, rivalutato a partire dagli anni Ottanta grazie all'insegnamento di Sawadogo e utilizzato per ripristinare migliaia di ettari di terra asciutta e ridurre la fame in Burkina Faso e Niger.
Il Burkina Faso è una zona semi-arida del Sahel al di sotto del deserto del Sahara, dove i cambiamenti climatici e l'uso eccessivo della terra stanno rendendo sempre più difficile coltivare. Nel 2017 piogge irregolari hanno lasciato quasi un milione di persone bisognose di aiuti alimentari in tutto il Paese. Furono questi problemi a indurre Sawadogo a cercare delle soluzioni praticabili.
Più precisamente la tecnica, oggi adottata dalle agenzie di soccorso che lavorano per prevenire la fame nella regione, consiste nelle seguenti operazioni: scavare delle buche, riempirle di foglie, di escrementi animali e di altri concimi che favoriscono non solo la nascita di piante ma anche il riprodursi delle termiti; sono queste ultime che, a loro volta, scavando piccole gallerie, rendono poroso il terreno e aiutano a trattenere l'acqua durante la stagione delle piogge. Infine costruire dei muretti in pietra per trattenere l'acqua. Tutto ciò consente al seme degli alberi piantati di germogliare.
Assistito da un altro agricoltore, Mathieu Ouédraogo, e da 17 figli e 40 nipoti, riuscì a creare a Gourga, suo villaggio natale, una vera e propria foresta di 30 ettari, visibile dal satellite. Lì coltivava mais, sorgo e miglio. Il governo gli espropriò una parte della foresta, tagliando gli alberi e costruendo delle case. Però Yacouba non si è arreso. Ha intentato una battaglia legale, ma soprattutto non ha mai smesso di far crescere nuove piante.
La sua storia è raccontata in un film-documentario del 2010, intitolato The man who stopped the desert (L'uomo che fermò il deserto), vincitore di sette premi cinematografici.
Venanzio Vallerani (1924-2012) è stato un agronomo e zootecnico italiano. Ha messo a punto una strategia d'intervento contro la desertificazione denominata “Vallerani System” per rinverdire con boschi, pascoli, culture agricole e industriali le terre aride e semi-aride del pianeta. Con il “Vallerani System” sono stati lavorati oltre 116.000 ettari fino al 2013 in 13 paesi dell'Africa e dell'Asia.
A Capo Verde, tra il 1984 e il 1987, ebbe modo di osservare le tecniche di rimboschimento attuate nella zona per fermare l'erosione del suolo e garantire alle piante una più elevata possibilità di sopravvivenza grazie alla raccolta e conservazione dell'acqua piovana.
Nel 1987 Vallerani si trovava in Niger per conto della Cooperazione Italiana. Qui, dopo aver osservato le tecniche di coltivazione locali, che prevedevano lo scavo manuale del terreno e il trapianto di piante da vivaio, Vallerani effettuò le prime prove di lavorazione del terreno con un aratro, ottenendo i risultati da lui previsti, ovvero il trattenimento dell'acqua piovana nei solchi realizzati e la germinazione sul posto dei semi arborei. Da questa prima coltivazione sperimentale iniziò a prendere forma l'idea di un nuovo sistema di lavorazione delle terre aride e semiaride.
Nel 1988 ideò il prototipo dei primi aratri pensati per la restaurazione delle terre aride: il Treno e il Delfino.
L'aratro Treno, il primo realizzato da Vallerani nel 1988, era adatto per i terreni pianeggianti e per migliorare le produzioni agricole, riforestare e costruire linee frangivento. Scavava un solco continuo mediamente largo 60 cm, suddiviso da diaframmi, costituiti dal terreno superficiale raschiato da un apposito meccanismo, per evitare lo scorrimento dell'acqua nel solco e favorirne invece l'infiltrazione.
Il Delfino era invece un aratro pensato per scavare semilune nei terreni declivi. Scavava 10/20 semilune o micro-bacini al minuto, unite l'una all'altra dalla traccia di un ripper lunga 2 metri e profonda 50 cm. Le semilune avevano la larghezza media di 60 cm e erano lunghe 5 metri. Anche in presenza di pluviometrie molto basse di 200–500 mm/anno, ogni semiluna era in grado di raccogliere fino a 1.000 litri d'acqua, compresa quella di ruscellamento. I micro-bacini raccolgono la pioggia che cade nelle semilune e il 50% di quella che scorre tra le linee di lavorazione. L'acqua penetra facilmente nelle sacche sotterranee di raccolta dell'acqua e fluisce nelle falde freatiche senza rischi di evaporazione, moltiplicando da 2 a 4 volte l'acqua disponibile per le colture, i pascoli e le piante.
Sempre nel 1988 i due aratri vennero inviati in Niger nell'ambito del progetto della Cooperazione Italiana. In venti giorni di lavorazione, prima delle piogge, furono arati 187 ettari con il Treno e 128 con il Delfino. Le produzioni di sorgo, ch'erano in media 450 kg per ettaro, passarono a 1.800-2.000 kg, la massa foraggiera aumentò notevolmente, le radici delle piante superavano i 120 cm e i costi di lavorazione furono 4-5 volte minori dei costi di progetti analoghi.
L'anno dopo il “Vallerani System” venne presentato alla Fiera Internazionale di Verona, in virtù della quale nacquero varie collaborazioni con organismi internazionali di ricerca e di aiuto allo sviluppo, realizzando progetti di lotta alla desertificazione in numerosi paesi del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia, quali Niger, Burkina Faso, Senegal, Kenya, Sudan, Ciad, Madagascar, Marocco, Tunisia, Siria, Giordania, Egitto e Cina.
Nel 2001 il “Vallerani System” è stato presentato alla Conferenza “Lotta contro la desertificazione” a Ginevra. Nel 2002 la delegazione del governo cinese, che aveva assistito alla presentazione di Ginevra, invitò Vallerani a visitare la Mongolia Interna e le provincie del Gansu, Hebei e Qinghai per studiare la possibilità d'introdurre il suo sistema in quelle zone. A seguito della visita, il governo cinese richiese cinque progetti nelle regioni nord-orientali del Paese.
Nel 2005, all'interno del quadro di cooperazione diretta tra il Ministero dell'ambiente italiano e il Ministero delle foreste cinese, è stato firmato il Progetto per la riforestazione di un'area pilota con l'applicazione del sistema nella Regione Autonoma della Mongolia Interna. I lavori sono iniziati nella contea di Balinzuo, per poi proseguire nel 2006 nella contea di Aqi. Il progetto prevedeva la lavorazione di 1000 ettari, ma, a seguito degli ottimi risultati conseguiti, sono stati aumentati a 3200.
Grazie a questi successi, Venanzio Vallerani è stato nominato Professore Honoris Causa per la prevenzione e la lotta alla desertificazione all'Accademia forestale dell'Inner Mongolia e all'Università di Ulun Beir, consulente speciale dell'Academy for forestry inventory and planning of state forestry administration del Ministero delle foreste cinese ed insignito dal presidente Hu Jintao del “Certificate of Friendship”, la più alta onorificenza conferita dal governo cinese a uno straniero.
Nel corso degli anni gli aratri sono stati modificati per ottimizzarne le prestazioni nei diversi tipi di terreno e nel 2011 è nato il nuovo aratro Delfino, che ha sostituito i precedenti aratri Treno e Delfino, migliorando le qualità tecniche. Peraltro, grazie all'elevata velocità di lavorazione, tra 4 e 8 km/h, l'aratro è in grado di lavorare 1,5-3 ettari/h.
Il Sistema ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti e certificazioni da parte di diversi dicasteri esteri, organizzazioni internazionali e manifestazioni agricolo-cooperativistiche come FAO, CILLS, ICARDA, IFAD, UNESCO, ENEA, MAE, ACACIA...
Capisaldi del sistema di Vallerani erano l'idea di meccanizzare il sistema tradizionale di lavorazione del terreno con buche scavate per la raccolta dell'acqua (zaï) e quella d'introdurre la semina diretta di piante autoctone, sostituendo la pratica del trapianto di piantine da vivaio. Così facendo si permetteva all'apparato radicale delle piante autoctone di mantenere la sua più importante funzione, quella del fittone, con cui raggiungere l'acqua in profondità. L'elevata germinazione e la capacità delle piante di autopropagarsi venivano consentite dall'acqua raccolta nei micro-bacini scavati dall'aratro.
Questo sistema è volto non solo alla preservazione della biodiversità, nel rispetto delle coltivazioni autoctone, ma anche alla coltivazione di piante che, crescendo secondo i naturali tempi di sviluppo e adattandosi subito al terreno e alle condizioni climatiche in cui cresceranno, saranno più vigorose e resistenti, aumentandone così la possibilità di sopravvivenza. Il sistema della semina diretta garantisce nelle piante una elevata capacità di resistenza alle malattie, agli attacchi dei parassiti e di adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza): questo grazie alla maggiore profondità che le radici delle piante a semina diretta sono in grado di raggiungere rispetto a quelle coltivate in vivaio.
La scelta dei terreni per le lavorazioni deve tenere conto di vari fattori (p.es. la pluviometria), per poter calcolare le distanze tra le linee di lavorazione e così raccogliere tutta la pioggia. Maggiore è l'intensità delle precipitazioni, più vicine devono essere le linee di lavorazione. Data la velocità di avanzamento del trattore è conveniente che l'area di lavorazione sia di dimensioni ampie. È importante considerare la compattezza e porosità dei terreni per avere indizi sulla velocità di scorrimento e assorbimento della pioggia. È fondamentale che il terreno non sia eccessivamente pietroso, per evitare danni ai trattori e agli aratri.
Ovviamente vanno coinvolte le popolazioni locali, per renderle partecipi a tutte le fasi della lavorazione e gestire al meglio i risultati ottenuti. A seconda del tipo d'intervento che si desidera fare, la raccolta dei semi e la semina potranno essere fatti direttamente dalle popolazioni locali (eventualmente integrando i semi di piante non più sufficientemente presenti nella zona). I semi devono essere raccolti dalle piante più vigorose al momento della loro maturazione e conservati in modo adeguato. Ideale è lo sterco delle capre e delle pecore: i pastori al momento opportuno faranno mangiare agli animali i semi scrollandoli direttamente dalle piante. Lo sterco raccolto nei recinti dove gli animali passano la notte, contiene i semi e dovrà essere distribuito a spaglio sul bordo dei micro-bacini in modo che, se nella stagione le piogge saranno scarse, nasceranno i semi nel fondo dei micro-bacini; se invece abbondanti, anche quelli nei lati. L'esperienza ha dimostrato che, così facendo, si ha un attecchimento medio di piante nel 95% dei micro-bacini: ciò significa che si avrà una media di 270 buche con dentro almeno una pianta per ettaro lavorato. I semi, elaborati nel processo metabolico degli animali, germogliano più facilmente, favorendo il rapido sviluppo delle piantine, restano protetti dagli animali fino all'arrivo delle piogge e lo sterco che le avvolge apporta importanti sostanze nutritive al terreno.
È necessaria la formazione di una squadra tecnica locale formata da trattoristi, meccanici, responsabile dei lavori agronomici e forestali, personale amministrativo, e di una squadra sociale formata da soggetti locali per stimolare la conoscenza, la motivazione e la partecipazione delle popolazioni dei villaggi alla realizzazione dell'intervento.
Costo medio per ettaro lavorato e seminato: 80-100 € a seconda delle caratteristiche del terreno, delle dimensioni, del prezzo del carburante, del costo della manodopera, del tipo di intervento e delle spese d'importazione e trasporto dell'attrezzatura.
I benefici economici offerti dal “Vallerani System” sono innumerevoli. Tra i principali:
- moltiplicazione da 2 a 4 volte dell'acqua disponibile per le colture, i pascoli e le piante;
- riutilizzo delle terre abbandonate perché dure, compatte e quindi impossibili da lavorare manualmente;
- impiego di manodopera locale e formazione di manodopera specializzata;
- velocità dell'intervento con costi ridotti. Confrontando i costi dei metodi tradizionali di riforestazione basati sul trapianto e il “Vallerani System” fondato sulla semina diretta, si dimostra che quest'ultimo costa mediamente 5 volte di meno e i risultati sono più veloci, validi e duraturi;
Accanto a questi si hanno anche benefici ecologici, tra cui soprattutto la riduzione dell'evaporazione dell'acqua piovana, la ricarica delle falde freatiche e il calo dell'erosione dei terreni.
Julius Kambarage Nyerere (1922-99), padre fondatore della Tanzania (ex Tanganika), figlio di una famiglia di contadini, ebbe un ruolo politico centrale in questo Paese dal 1964 fino al 1985. È considerato una delle maggiori figure storiche del Novecento e una delle due personalità più importanti dell'Africa moderna, anche perché fu uno dei pochi teorici del socialismo africano. Insomma uno dei ‘Padri’ dell'Africa moderna. (4)
Già colonia tedesca, il Tanganika divenne inglese nel 1918, come bottino della prima guerra mondiale, e tale rimase fino al 1961. Una volta al potere, Nyerere istituzionalizzò un sistema di democrazia parlamentare sul modello inglese, mantenendo un atteggiamento collaborativo con la Gran Bretagna e la popolazione bianca residente nel territorio. Il suo governo supportò infatti l'entrata della Tanzania nel Commonwealth, cercò di attirare capitali stranieri siglando accordi bilaterali con numerosi paesi europei, offrì agli investitori privati delle clausole sugli indennizzi in caso di nazionalizzazioni, il diritto di rimpatriare i profitti e una serie di sgravi fiscali. L'agricoltura tradizionale di sussistenza praticata dagli agricoltori africani era ritenuta arretrata e antiscientifica: i modelli produttivi tradizionali – caratterizzati dalla rotazione dei terreni, la policoltura e l'utilizzo di bassi livelli di input – avrebbero dovuti essere migliorati attraverso l'introduzione delle pratiche moderne della coltivazione, soprattutto per sostenere lo sviluppo agroindustriale delle principali risorse del Paese: caffè, tè, cotone, tabacco e anacardi.
La crescita delle cooperative fu enorme: da 172 nel 1952 a 1649 nel 1967 con 3 milioni di aderenti. Ciò permise agli agricoltori africani di emanciparsi dalla dipendenza dagli intermediari asiatici che, fino al momento dell'indipendenza politica, controllavano il commercio interno dei prodotti agricoli.
Tuttavia nel 1967 vi fu una svolta significativa. Constatato che solo le élite locali (gli agrari capitalisti africani nati verso la fine degli anni Cinquanta) avevano tratto beneficio dagli investimenti governativi a favore dell'agricoltura, e che le disparità sociali invece di diminuire erano aumentate, e che si erano verificati numerosi episodi di corruzione e di spreco di fondi pubblici all'interno delle stesse cooperative, tanto da pregiudicare il loro funzionamento più efficiente, Nyerere intraprese un progetto di sviluppo di stampo etico-socialista, annunciato con la Dichiarazione di Arusha del 5 febbraio 1967. A questa svolta contribuirono anche alcuni membri del partito, sempre più in rottura con la linea morbida del suo governo verso gli europei e gli asiatici.
Tre erano i princìpi guida enunciati da Nyerere, cui resterà fedele sino alla fine del suo mandato: 1) il rispetto per la persona umana, da cui il rifiuto di ogni discriminazione, soprattutto razziale; 2) la promozione dell'uguaglianza tra uomini, gruppi e nazioni; 3) il riconoscimento a tutta la popolazione dell'accesso alla terra. Il nuovo Stato (che si dichiarava “non allineato”) era molto eterogeneo nella sua popolazione (ben 128 le etnie) e ovviamente nelle sue lingue, nonché molto squilibrato nella distribuzione delle risorse sul territorio. Il sistema scolastico nel 1961 era quasi inesistente: su 10 milioni di abitanti c'era un solo ingegnere, nove veterinari, 16 medici, nessun magistrato, nessun architetto.
Le cooperative furono poste sotto controllo governativo e i loro leader vennero sostituti con membri del partito. La politica economica del governo iniziò a prendere sempre più la strada del socialismo e i poteri dello Stato furono concentrati nelle mani del premier e dei massimi esponenti del partito. Le nuove politiche economiche si sarebbero concentrate su uno sviluppo rurale utilizzando le risorse nazionali disponibili, in opposizione ai beni importati.
Elemento caratterizzante della suddetta Dichiarazione, che rappresenta il fondamento del “Socialismo Africano”, fu il processo di collettivizzazione del sistema agricolo del paese, cosiddetto “Ujamaa”. (5) Ujamaa è una parola in lingua swahili che significa "famiglia estesa". Una delle caratteristiche di questo concetto è che una persona diviene ciò che è attraverso la comunità locale, fondata su quei valori tradizionali già presenti nei villaggi originari esistenti prima della colonizzazione imperialista. Il ritorno ai costumi e ai metodi di vita e di economia preesistenti all'ingresso del capitalismo nel paese avrebbe condotto, secondo Nyerere, allo Stato ideale.
Per Nyerere “famiglia estesa” significava che ogni individuo è al servizio della comunità. Quindi l'Ujamaa è un concetto che indica una comunità in cui la cooperazione e l'avanzamento collettivo fanno parte del modus vivendi di ogni individuo. Tale ideologia è stata anche descritta come "socialismo rurale". Nell'Ujamaa l'acquisizione personale non era proibita, ma veniva privilegiato il possesso comune delle risorse primarie – la terra anzitutto – dei mezzi di produzione, e una distribuzione più egualitaria della ricchezza prodotta fra i membri della comunità. Nyerere usò questo concetto come base di un progetto di sviluppo nazionale. Insieme al concetto di Uhuru si può capire tutta la politica di Nyerere. Uhuru vuol dire indipendenza, ma anche libertà e le due accezioni verranno usate tanto in politica estera che in politica interna: di qui l'impegno contro il colonialismo e l'apartheid.
La fermezza della politica estera di Nyerere portò la Tanzania a ritirare il proprio ambasciatore da Washington (1964) e a rompere i rapporti diplomatici con Londra, facendo uscire il Paese dal Commonwealth, quando il parlamento inglese accettò il governo minoritario bianco della Rhodesia dopo l'indipendenza (1965). Problemi sorsero anche con la Repubblica federale tedesca, che ostacolava l'unione del Tanganika con Zanzibar (1964), che invece risulterà decisiva per la formazione di un'unica federazione con più di 25 milioni di abitanti e un esercito comune.
Il modello di gestione politica ed economica si può sintetizzare nei seguenti punti:
- La creazione di un sistema monopartitico, con al vertice il Chama Cha Mapinduzi (CCM, ex TANU), allo scopo di rendere coesa la Tanzania (da notare che pur essendo Nyerere cattolico dichiarato, gestiva un partito a maggioranza musulmana). Già con la Costituzione del 1965 il socialismo venne ufficialmente sancito come ideologia fondante del Paese.
- L'istituzionalizzazione dell'uguaglianza sociale, economica e politica tramite la creazione di una democrazia centrale, l'abolizione della discriminazione basata sullo status di nascita e la nazionalizzazione dei settori-chiave dell'economia. In particolare Nyerere cercò di eliminare l'identità etnica dal dibattito politico interno al fine di creare un'identità nazionale nel Paese. Nel 1961 vennero vietate le associazioni basate su interessi tribali o etnici. Anche le associazioni di ispirazione etnica che avevano partecipato alla lotta per l’indipendenza, come la Meru Citizens Union e il Chagga Demcratic Party, furono sciolte. Nel 1963 venne istituito il servizio militare obbligatorio, nel tentativo di forgiare un'identità nazionale basata sulla cittadinanza in opposizione all'etnia.
- Si nazionalizzarono le banche, quasi tutte le industrie, le compagnie di assicurazione, le imprese agricole e il commercio estero gestiti dagli stranieri, centinaia dei quali (soprattutto europei e asiatici) abbandonarono il Paese.
- La villaggizzazione della produzione, ovvero la collettivizzazione di tutte le produzioni locali attraverso l'aggregazione delle popolazioni in villaggi di dimensioni sufficienti per funzionare da poli produttivi autonomi, affrancati dalla dipendenza degli aiuti esterni. Vi era naturalmente il divieto di utilizzare lavoratori salariati nei villaggi, i quali disponevano anche di una scuola elementare e di un centro sanitario gratuiti.
- Per quel che riguarda la cultura e l'istruzione si realizzò una profonda riforma dell'insegnamento, cercando di superare i valori che insistono sulle ineguaglianze e che disprezzano il lavoro manuale. La scuola elementare, gratuita e obbligatoria per tutti, svolgerà un ruolo primario nell'intero ciclo degli studi. Pienamente integrata nella comunità, sarà dotata di un campo di applicazione agricola, che servirà tanto alla formazione che alla sussistenza della scuola stessa. Lo swahili diventa la lingua ufficiale della Tanzania, nella quale Nyerere pronuncerà tutti i suoi discorsi e che sarà un forte strumento di coesione per la popolazione. Attualmente la Tanzania è probabilmente la nazione africana maggiormente autoctona; infatti se oggi si chiede a un giovane l'origine etnica, la risposta è: “Sono tanzaniano”. Nei 25 anni di presidenza Nyerere l'iscrizione alla scuola primaria passò da circa il 30% nel 1970 al 93% del 1983, mentre l'aspettativa di vita aumentò da 44 anni nel 1961 a 51 nel 1985.
Il sistema Ujamaa fallì per vari motivi: il crollo del prezzo di esportazione di alcuni beni (in particolare caffè e canapa), la crisi petrolifera degli anni Settanta (le importazioni di petrolio assorbivano il 60% del valore totale delle importazioni), la mancanza di investimenti dall'estero (il FMI e la Banca Mondiale subordinarono la ripresa degli aiuti alla realizzazione di misure economiche liberiste, volte, cioè, alla riduzione della spesa pubblica), e lo scoppio della guerra con l'Uganda nel 1978, che privò la giovane nazione tanzaniana di molte risorse. Nel 1976 la Tanzania, ch'era stata il maggior esportatore di prodotti agricoli del continente, si trovò ad esserne il principale importatore. La nazionalizzazione venne fatta senza avere personale idoneo a rimpiazzare i manager in fuga. La stessa espulsione dei missionari dalle scuole secondarie avvenne senza avere immediatamente a disposizione insegnanti tanzaniani per sostituirli.
Bisogna inoltre considerare lo sviluppo in senso autoritario e burocratico che ebbero la formazione dei villaggi ujamaa, tanto che le cooperative spontanee vennero chiuse. L'inasprimento dell'ideologia della pianificazione ebbe un impatto molto negativo sulla produzione e, di conseguenza, sulla disponibilità di alimenti. D'altra parte la simbiosi tra partito e Stato porta sempre a una concentrazione di poteri che si traducono nella fusione tra funzioni amministrative e politiche: diventa inevitabile l'instaurarsi di un forte dirigismo che mette in pericolo le basi della democrazia.
Non fu sufficiente obbligare i dirigenti politici e amministrativi a dissociarsi da qualsiasi iniziativa di carattere capitalistico o feudale. Il codice di comportamento prevedeva, infatti, il divieto di ricevere più di uno stipendio, di possedere azioni o essere amministratori di società private, e ovviamente la proprietà di immobili (esclusi quelli di abitazione). Né bastò lanciare una grande campagna di educazione politica in cui si spingeva la popolazione a non restare passiva davanti alla tirannia dei dirigenti, a scrollarsi di dosso l'eredità coloniale e la sottomissione all'autoritarismo. La corruzione dei funzionari pubblici fu una delle cause del fallimento delle riforme economiche.
Inoltre alla fine del 1973 si contavano soltanto 5.628 villaggi con una popolazione complessiva di circa due milioni di individui, cioè il 15% del totale nazionale. A motivo di questo la politica della collettivizzazione delle terre e della produzione – anche per la resistenza degli agricoltori – fu abbandonata in favore della piccola coltivazione, su base individuale, all'interno di un unico grande appezzamento (ma nel 1985 il 93% dei piccoli produttori operava ancora su terreni al di sotto di due ettari). Il governo insistette sul reinsediamento forzato, portando circa 13 milioni di persone, alla fine del 1976, a vivere in quasi 8.000 villaggi. Nello stesso anno le cooperative agricole vennero formalmente abolite, i loro beni confiscati e loro funzioni trasferite ai nuovi villaggi e alle nuove aziende statali. I prezzi delle derrate agricole venivano stabiliti dal governo: il che non fece altro che favorire l'espansione di mercati paralleli e l'aumento dell'inflazione.
Va detto, per essere il più possibile obiettivi, che Nyerere scontò il limite di fondo della cosiddetta “Teoria della dipendenza”, sviluppatasi negli anni Settanta nel Terzo Mondo, in concomitanza con la decolonizzazione e con la convinzione che la civiltà industriale in occidente era cresciuta economicamente grazie al basso costo dell'energia, la quale, non a caso, era presente soprattutto nelle colonie. La comparsa della suddetta teoria avvenne indipendentemente in più zone del pianeta: fu importante nei Caraibi e in Africa, ma generalmente modesta in Asia. Sul piano nazionale essa fornì un'ideologia di sviluppo per un certo numero di regimi: p.es. il Cile di Allende, la Giamaica di Manley e appunto la Tanzania di Nyerere. Senonché è difficile parlare di risultati concreti, quando tale teoria in realtà non ha mai prodotto una propria specifica strategia di sviluppo. Si è andati da una adozione meccanica di modelli sovietici o cinesi, quando lo statalismo industriale e rurale dei Paesi del cosiddetto “socialismo reale” faceva già acqua da tutte le parti, fino a una pedissequa critica degli ostacoli frapposti dai Paesi capitalisti dell'occidente, i quali, pur avendo dovuto rinunciare al colonialismo politico non avevano alcuna intenzione di rinunciare anche a quello economico e finanziario.
Nyerere comunque decise di ritirarsi spontaneamente in occasione delle elezioni presidenziali del 1985, lasciando che il Paese si aprisse al libero mercato sotto la guida di Ali Hassan Mwinyi. Rimase comunque presidente del partito unico fino al 1990. È ancora riconosciuto come il Padre della Nazione. Questo perché dopo di lui il Paese affrontò la successione in condizioni di relativa democrazia: dal 2000 il partito non è più unico.
A motivo del suo “socialismo agrario” le relazioni della Tanzania con i suoi vicini africani (in particolare quelli del nord, Uganda e Kenya) si deteriorarono parecchio nel corso degli anni. Il confine del Kenya, vicino ai paesi occidentali, fu chiuso dal 1977 al 1983. In Uganda, Idi Amin Dada (protetto dagli inglesi, da Israele e dal Sudafrica), che aveva ambizioni di espansione territoriale, incolpò proprio Nyerere per aver ospitato gli oppositori del suo regime. Dopo il colpo di stato con cui Idi Amin Dada rovesciò il governo di Milton Obote, diventando presidente dell'Uganda (1971), Obote e molti suoi sostenitori (che avevano impresso al loro Paese una svolta politica verso sinistra, avendo annunciato l'intenzione di nazionalizzare le proprietà straniere nel paese) trovarono rifugio in Tanzania. L'appoggio tanzaniano a Obote contribuì a inasprire i rapporti politici fra Uganda e Tanzania, già difficili in precedenza. Nel 1972, quando i sostenitori di Obote cercarono di riprendere il potere in Uganda, Amin accusò il presidente tanzaniano Julius Nyerere di essere fra gli organizzatori del tentato colpo di Stato.
L'Uganda attaccò la Tanzania alla fine del 1978 e invase l'area intorno al lago Vittoria. I tanzaniani entrarono in Uganda nel febbraio del 1979. Sapendo di avere di fronte uno degli eserciti meglio preparati dell'intera Africa, i tanzaniani cercarono di evitare lo scontro frontale con le forze nemiche, colpendo invece una serie di obiettivi isolati. La città ugandese di Kampala fu uno di questi obiettivi, e subì la distruzione quasi totale delle sue infrastrutture.
Invece di opporre resistenza, l'esercito ugandese iniziò a ritirarsi piuttosto disordinatamente verso nord, saccheggiando i centri abitati per procurarsi rifornimenti. In sostegno di Amin giunsero le truppe libiche inviate dal colonnello Gheddafi, che si scontrarono con la prima linea tanzaniana a Lukaya, poco a nord della capitale. Dopo aver sbaragliato i libici, l'esercito tanzaniano procedette nella propria avanzata; particolarmente lunghi furono i combattimenti per la conquista di Entebbe, l'aeroporto ugandese costruito su una penisola del lago Vittoria, a circa 40 km dalla capitale Kampala. I tanzaniani, sostenuti anche dai ribelli dell'UNLA (Esercito di liberazione nazionale dell'Uganda), presero nel 1979 la capitale, deponendo Amin, che riparò in Libia. L'ammontare delle vittime causate dal regime di Amin (1971-79) non è mai stato quantificato in maniera precisa. Una stima effettuata dalle organizzazione degli esuli con l'aiuto di Amnesty International, pone il numero a circa mezzo milione.
All'inizio degli anni Sessanta Nyerere fu anche un convinto assertore del Movimento panafricano e collaborò alla fondazione dell'Organizzazione dell'Africa Unita (OUA), insieme ad altri luminari africani, quali Gamal Abdel Nasser dell'Egitto, Sekou Toure della Guinea, Nkame Nkruma del Ghana e Jomo Kenyatta del Kenya.
Fornì la base logistica per numerosi movimenti africani di liberazione, come l'African National Congress (ANC) e il Congresso Pan-Africano (PAC) del Sudafrica, il FRELIMO del Mozambico, il MPLA dell'Angola, lo ZANLA dello Zimbabwe e la SWAPO della Namibia. Dalla metà degli anni Settanta fu leader, insieme al Presidente dello Zambia, Kenneth Kaunda, del "Front Line States", che supportava la campagna per il governo della maggioranza nera in Sudafrica. Sotto la sua influenza si formarono i nuovi dirigenti del continente africano: l'etiope Melles Zenawi, l'eritreo Isayas Afeworki, l'ugandese Yoweri Museveni, il ruandese Paul Kagame, quindi Samora Machel (Mozambico), Robert Mugabe (Zimbabwe), Sam Nujoma (Namibia), Agostino Neto (Angola) e Laurent Kabila (Congo).
Gli sono stati attribuiti alcuni importanti errori politici: p.es. il suo sostegno al colonnello Chukwuemeka Ojukwu durante la guerra civile in Nigeria. Ojukwu era a capo della comunità Igbo, che voleva separarsi dalla Nigeria. Nyerere lo fece perché, durante la guerra in Biafra, credeva che in quel momento i diritti umani della gente Igbo venissero calpestati dal governo nigeriano dell'epoca, e gli sembrava che l'unico modo per risolvere il problema fosse attraverso la secessione del Biafra. Giungere a questa conclusione fu particolarmente difficile per lui, visto il suo dichiarato impegno sulla strada verso l'unità africana.
Lo stesso vale per la seconda repubblica ugandese di Obote. Non è stato per semplice amicizia e cieca lealtà nei confronti di Obote che Nyerere gli concesse il suo tacito sostegno, al di là dei dubbi e delle accuse di sfruttamento da parte di molti ugandiani che conoscevano personalmente la corruzione della prima repubblica di Obote. Il fatto è che dopo le atrocità di Idi Amin e il totale fallimento del governo di Joseph Lule e Godfrey Binaisa, Nyerere credeva sinceramente che Obote fosse la migliore possibilità per la pace e il rispetto dei diritti umani per le persone dell'Uganda. Questo si è poi rivelato un errore. Quando se ne è reso conto, Nyerere non ha obiettato al passaggio del governo nelle mani di Yoweri Museveni.
Nel 1999 i presidenti di Kenya, Uganda e Tanzania si sono incontrati per fondare una comunità economica dell'Africa dell'Est. Gli obiettivi dichiarati di questa e di altre organizzazioni simili includono la creazione di aree di libero scambio, di unioni doganali, di un mercato unico, di una banca centrale e di una valuta comune.
Bisogna tuttavia ammettere che l'agricoltura in Africa (soprattutto nella regione sub-sahariana), entrata in una profonda crisi negli anni Ottanta e Novanta, sembra non essersi più ripresa. Con la Dichiarazione di Maputo (2003), i governi africani si sono impegnati a devolvere il 10% della spesa pubblica al settore agricolo, ponendosi in forte rottura rispetto alle politiche del decennio precedente, ma a tutt'oggi non si sono verificati significativi miglioramenti, e i continui e massicci flussi migratori verso l'Europa attestano i gravi problemi di questo continente. Le grandi produzioni intensive, le politiche agroindustriali a favore dell'esportazione, le politiche di concessione di vaste aree di terra alle imprese estere per la produzione di biocarburante (e non solo) rappresentano un fenomeno estremamente negativo, che minaccia l'accesso alla terra da parte delle popolazioni rurali e rischia di trasformare i piccoli contadini africani in produttori sottopagati di materie prime o in braccianti agricoli senza terra. A tutt'oggi il 41% della popolazione in Africa sub-sahariana vive con meno di due dollari al giorno.
La Tanzania è uno dei numerosi paesi africani nei quali, nonostante la rapida crescita economica, la grande maggioranza della popolazione (circa il 65%) dipende ancora dalle attività agricole per la sopravvivenza; i livelli di povertà e insicurezza alimentare rimangono sensibilmente elevati. Il ventennio di politiche socialiste (1967-1986) ha portato a significativi miglioramenti nell'accesso della popolazione rurale ai servizi sociali, ma non è riuscito a ridurre la povertà. (6) D'altra parte molte popolazioni rurali africane vogliono continuare a resistere ai controlli statali di tipo socialistico e ai mercati di tipo capitalistico. Sembrano essere tenacemente attaccate a modelli sociali ed economici precapitalistici e precoloniali, caratterizzati da princìpi solidaristici e cooperativistici che frenano la crescita delle disuguaglianze e la creazione di classi sociali. Questo atteggiamento non favorisce certamente lo “sviluppo” come lo si intende nelle società industriali (capitalistiche o socialistiche che siano), ma non sta forse in questo la loro originalità?
Hosea Jaffe (1921-2014) era uno di quegli economisti di sinistra che diceva pane al pane e vino al vino. Non so quanti suoi colleghi contemporanei sostengano che va recuperata la società primitiva, quella pre-schiavistica, al fine di ritrovare l'uguaglianza e la democrazia “moderne”. Di sicuro non v'è nessuno tra quelli borghesi e si farà fatica a trovarne persino qualcuno tra quelli marxisti.
Lui p.es. negava una cosa che per il marxismo (e forse questa è una delle tante ragioni che ha indotto la Jaca Book a pubblicare molti suoi libri) è sempre stata considerata un dogma: la necessità di una qualsivoglia transizione a un livello superiore di civiltà, sia quella dal comunismo primitivo allo schiavismo, che quella dal feudalesimo al capitalismo. È proprio sul concetto di “necessità” che non voleva sentir ragioni.
Di tutta la civiltà europea, a partire dalla nascita dello schiavismo come stile di vita, Jaffe non salvava nulla. Per lui la più grande disgrazia dell'umanità è stata la distruzione del comunismo primitivo. Non solo, ma, pur dichiarandosi marxista (che oggi in occidente è come dire “alieno”), egli aveva sottoposto a dura critica i classici del marxismo, soprattutto là dove ritenevano “arretrati” i popoli non-europei, giustificando così il colonialismo occidentale, al fine appunto di poter parlare di “necessaria transizione al socialismo”.
Secondo lui con la nascita dell'imperialismo (verso la fine dell'Ottocento) è andato irrimediabilmente distrutto il comunismo primitivo a livello planetario. En passant potremmo aggiungere a questa tesi incontrovertibile la seguente considerazione: l'imperialismo (oggi chiamato globalismo) riproduce la stessa percezione unitaria del pianeta che avevano gli uomini primitivi, che si sentivano liberi di esplorarlo e di popolarlo come volevano, ma con la fondamentale diversità che oggi, per avere questa consapevolezza, bisogna essere proprietari di capitali. Ci siamo emancipati dallo schiavismo solo nel senso che abbiamo acquisito una libertà personale di tipo giuridico, cioè formale, mentre in quella economica siamo sempre rimasti “schiavi” di qualcuno.
Al tempo di Marx – scrive Jaffe nel suo Era necessario il capitalismo? (Jaca Book, Milano 2010) – l'ultima esperienza di comunismo primitivo era quella della obščina russa (che poi, in realtà, era una forma edulcorata di feudalesimo, in quanto il vero comunismo primitivo poteva al massimo trovarsi in qualche tribù misconosciuta, ridotta di numero e dispersa in quelle zone non appetibili o non ancora debitamente sfruttate dal grande capitale, cioè dell'Africa, dell'Asia, del Sudamerica o dell'Oceania).
Hosea Jaffe è uno di quegli economisti radicali che sostiene che senza lo sfruttamento di questo comunismo primitivo non sarebbe mai nato il capitalismo. In tal senso fa le pulci allo stesso Marx, il quale non affermò mai espressamente che l'accumulazione originaria del capitalismo fu una conseguenza diretta del colonialismo. Nel Capitale infatti il colonialismo è indubbiamente visto come elemento che favorì la nascita del capitalismo, ma non è visto come fattore determinante in prima istanza.
Jaffe invece, per sostenere la sua tesi, anticipa il colonialismo all'epoca delle crociate, cioè lo fa risalire ad almeno mezzo millennio prima della nascita della rivoluzione industriale, sicché questa poté avvenire proprio perché le “casse per gli investimenti” erano già piene di uno sfruttamento intensivo e plurisecolare.
Gli si può dar torto? Sì, ma a condizione di dargli ragione quando equipara le crociate a una forma di colonialismo. Tuttavia per far nascere il capitalismo non basta il colonialismo. Se fosse così facile, non si spiega perché il “capitale” (nell'accezione borghese) abbia dovuto impiegare mezzo millennio prima di nascere; e meno ancora si spiega perché, passato questo mezzo millennio, le prime due grandi nazioni colonialiste europee, il Portogallo e soprattutto la Spagna, non siano mai diventate capitalistiche (in senso industriale o finanziario), se non dopo un altro mezzo millennio, con molta fatica e, per giunta, quando i loro imperi coloniali non esistevano più.
Per diventare capitalisti ci vuole una mentalità, una cultura molto particolare, che non avevano neanche i Romani, che pur avevano creato una società mercantile e coloniale molto più evoluta, molto più centralizzata e organizzata di quella europea esistente al tempo delle crociate.
Ci vuole una mentalità che faccia della libertà formale (giuridica) il criterio dei rapporti umani, che anzitutto vogliono essere “produttivi”, basati sulla “quantità” delle merci. Questa non è una cosa semplice, poiché viene più istintivo trattare il perdente, il nullatenente o l'insolvente alla stregua di uno schiavo. Per ritenere necessaria una mediazione giuridica tra oppresso e oppressore, occorre compiere un salto di qualità.
Certo anche i Romani avevano il diritto, ma da esso erano totalmente esclusi gli schiavi. Il concetto di “persona” non lo si applicava allo schiavo, e anche quando la legislazione chiedeva agli schiavisti di non eccedere nelle punizioni, al massimo imponeva una sanzione amministrativa.
C'è voluto il cristianesimo e la cultura “barbara” per umanizzare il rapporto di schiavitù, trasformandolo in rapporto servile. Ma questo a Jaffe non interessa, e neppure al marxismo è mai interessato. È vano chiedergli di fare un'analisi di questa cultura: il suo discorso è meramente strutturale, ponendosi, in questo, sulla falsariga di quello vetero-marxista. L'unica “cultura” che vede è quella ideologica che ha favorito l'abolizione formale della schiavitù per trasformare il colonialismo in un imperialismo, modernizzando, per così dire, il razzismo.
A suo dire l'Europa occidentale ha conosciuto solo esperienze di schiavismo e di razzismo (almeno a partire dai Greci), fatto salvo il periodo altomedievale, dominato da popolazioni extraeuropee, che al massimo conoscevano un “dispotismo comunitario”. L'Europa cioè sarebbe passata da una forma di schiavismo all'altra, diffondendolo come un virus in tutto il pianeta. I due principali eredi di questo schiavismo sono stati gli Usa e il Giappone.
Trattare o discutere con questi tre poli dell'imperialismo è fatica sprecata. Il loro obiettivo è quello di dominare il mondo. Semmai – scrive Jaffe che, in questo, la pensa come Samir Amin – ci si deve chiedere quale sia il modo migliore per difendersi da questi sistemi neoschiavistici. Jaffe infatti contesta sia Marx che Engels là dove ritengono che il capitalismo, pur con tutte le sue aberrazioni, costituisce un prodotto “necessario” della storia, propedeutico alla nascita del socialismo.
Jaffe sostiene che per realizzare il socialismo non c'era affatto bisogno del capitalismo, anche perché, là dove questo s'è imposto, non s'è mai verificata alcuna transizione socialista, come invece è accaduto in alcuni paesi poveri e colonizzati, ovvero negli anelli più deboli del sistema mondiale borghese.
Pensare dunque che il capitalismo possa aiutare a realizzare il socialismo è pura follia. Infatti – scriveva Jaffe – persino il proletariato industriale dell'occidente è co-responsabile dello sfruttamento del Terzo Mondo, e se dovesse scoppiare una guerra contro qualche paese colonizzato o addirittura un conflitto mondiale, assai difficilmente esso la trasformerebbe – come già chiedeva Lenin nel corso del primo conflitto mondiale – in una guerra civile contro i propri governi nazionali.
Più che cercare rapporti di collaborazione con l'occidente, il Terzo Mondo dovrebbe organizzarsi in maniera autonoma, riducendo al massimo i propri rapporti di dipendenza neocoloniale.
Per Hosea Jaffe il vizio di fondo dell'economia mondiale sta nel voler vivere sulle spalle altrui, cioè sta nel colonialismo, che India e Cina, p.es., non hanno mai praticato, pur conoscendo lo schiavismo. In tal senso la fine del capitalismo e del colonialismo non necessariamente dovrà comportare la fine dell'industrializzazione, ma solo un diverso modo di gestirla.
Se avesse però fatto un discorso “culturale” e avesse ripensato i rapporti tra uomo e natura, Jaffe avrebbe dovuto ammettere che anche “l'industrializzazione della produzione” è un concetto che va superato. E si sarebbe forse risparmiato l'ingenuità di credere che un paese come la Cina, una volta appreso l'uso della libertà giuridica nella maniera fittizia dell'occidente, non sia destinata a diventare una potenza imperialistica. Per il governo pseudo-comunista di questo Paese la gestione dei capitali deve essere strategica e non individualistica, e per poterlo essere efficacemente, occorre l'intervento dirigistico dello Stato e del partito unico. Lo Stato non può essere al servizio dei capitali più di quanto questi non debbano esserlo nei confronti dello stesso Stato.
Se John Zerzan avesse ragione, dovremmo dire che della vita non abbiamo capito niente. Per fortuna però che è un anarchico e che, come tutti gli anarchici, presenta dei lati estremistici che lo rendono poco credibile. Ciò senza nulla togliere al fatto che molte delle sue idee “primitiviste” siano tutt'altro che assurde. Ci riferiamo qui al 1° capitolo del libro Primitivo attuale, ed. Stampa Alternativa, Viterbo 2015 (prima edizione del 2004). Il titolo originale è Elements of Refusal. Il suo discepolo più significativo in Italia è Enrico Manicardi, il cui libro, prefato dallo stesso Zerzan, è un'autentica bibbia dell'anarco-primitivismo: Liberi dalla civiltà: spunti per una critica radicale ai fondamenti della civilizzazione: dominio, cultura, paura, economia, tecnologia, ed. Mimesis, Milano 2010. Ma di loro bisogna anche leggersi Nostra nemica civiltà: frammenti di resistenza anarchica alla civilizzazione, ed. Mimesis, Milano 2018.
L'estremismo di Zerzan, d'altra parte, è comprensibile. Come può non esserlo un uomo nato negli Stati Uniti del XX sec.? Questa nazione è una costola dell'Europa borghese sorta nel XVI sec., quel secolo in cui Marx fa decollare il moderno capitalismo. Ed è una costola puritana, cioè calvinista, quel ramo del protestantesimo che meglio s'è adattato e che, nel contempo, meglio ha favorito lo sviluppo del capitalismo manifatturiero.
Il cittadino medio americano risente profondamente di questa cultura, soprattutto se è di origine europea. Ne sono stati condizionati anche i neri provenienti dall'Africa, in quanto, dopo la loro liberazione giuridica dalla schiavitù, non sono mai riusciti a creare un'alternativa al capitalismo, neppure teorica. E ne sono condizionati oggi gli immigrati provenienti dal Sudamerica o dalla Cina o da qualunque altro paese, che sono convinti di trovare negli Usa una sicura possibilità di riscatto. Chi mette in discussione il valore del free market rischia di porsi appunto come un estremista, uno che non accetta l'idea di vivere nel paese più “democratico” del mondo, l'unico autorizzato a esportare ovunque, anche con la forza delle armi, la propria idea di “libertà”.
Le uniche in grado di contestare il capitalismo in maniera “naturale” avrebbero potuto essere le 500 tribù o nazioni indiane, anteriori alla colonizzazione europea, ma oggi i sopravvissuti vivono relegati nelle riserve, in procinto di scomparire definitivamente. Soltanto con quei nativi si può parlare, a buon diritto, in quel continente, di una tradizione pacifica, ambientalistica, priva di conflitti di classe o di irriducibili antagonismi sociali (cosa che non si può certo fare con gli Inca, i Maya e gli Aztechi). Una qualunque opposizione al capitalismo che non tenesse conto della loro plurimillenaria tradizione, non potrebbe non cadere in atteggiamenti estremistici.
Ecco perché John Zerzan è inevitabilmente un estremista. Non può sapere, per esperienza, che cosa sia “naturale” e che cosa no: lo deve imparare, facendo inevitabilmente degli errori, come tutti noi europei. A suo merito va il fatto che comunque ci sta provando, prendendo le cose seriamente. Un americano, che presume d'avere la consapevolezza della necessità inderogabile di superare i limiti strutturali del capitalismo, non può far leva su una memoria perduta (neppure quando osanna il paleolitico superiore), ma soltanto su un desiderio represso. Zerzan vuole essere se stesso in una società che fa di tutto per impedirglielo, in maniera diretta o indiretta.
Ora però vediamo quali sono gli aspetti ch'egli, nel primo capitolo del testo in oggetto, sottopone a una critica così radicale che un qualunque compromesso con le sue idee risulta impossibile. Generalmente egli si sforza di trovare una risposta a questa domanda fondamentale: “esiste un criterio oggettivo per stabilire quando un'azione umana può essere considerata naturale?”. La risposta ch'egli dà è sempre la stessa: “è la natura che deve deciderlo”. Sulla base di questa risposta egli avvicina l'uomo al mondo animale. Ciò significa che il meglio di sé l'uomo lo dà quando si affida all'istinto, ai sensi, al rapporto diretto, personale, con le cose, con l'ambiente, senza mediazioni artificiose di alcun genere. Di qui il rifiuto dei linguaggi simbolici, delle astrazioni, delle misurazioni matematiche e persino delle rappresentazioni artistiche.
Zerzan non rifiuta soltanto – come tutti gli anarchici – l'organizzazione statuale (che implica gerarchia e burocrazia) e le concezioni religiose o metafisiche dell'esistenza, ma anche tutto quanto ha caratterizzato il sorgere della civiltà, ivi inclusa l'agricoltura e la domesticazione degli animali. In questo sembra essere particolarmente radicale, salvo poi contraddirsi quando decide di scrivere libri su libri, nei quali, peraltro, esprime sempre gli stessi concetti.
L'errore di fondo, nella sua impostazione generale dell'alternativa che propone, sta proprio nel non rendersi conto che l'essere umano non è esattamente un “ente di natura”. L'essere umano rappresenta la natura che ha preso consapevolezza di sé. Sotto questo aspetto è impossibile paragonarlo strettamente agli animali. Nell'essere umano vi è qualcosa che in nessun animale si può riscontrare: è la libertà di coscienza. Per tutto il resto si può parlare di differenze di forme, di grado, d'intensità, soprattutto in relazione all'uso dei sensi, dell'intelligenza, del linguaggio, dell'affettività, ecc.
Tuttavia, quando l'uomo esercita la libertà di coscienza, tutte le differenze di tipo quantitativo si trasformano immediatamente in differenze di tipo qualitativo e diventano abissali. Se si accetta l'idea che, in nome della libertà di coscienza, le differenze tra mondo umano e mondo naturale possono diventare incolmabili, non è più possibile affidare alla sola natura il compito esclusivo di decidere quale sia il criterio oggettivo per stabilire quando un'azione umana è naturale. L'unico criterio possibile può essere stabilito, in ultima istanza, soltanto dallo stesso essere umano. Al massimo si può aggiungere: in maniera conforme alle esigenze riproduttive della natura.
Detto altrimenti: la capacità autonoma che l'uomo ha di gestire l'ambiente non può porsi in un'insanabile contrasto con le esigenze della natura, ma non può neppure lasciarsi determinare completamente da queste esigenze. La natura infatti è un ambiente dal quale noi non possiamo prescindere, e non tanto perché ci precede nel tempo, quanto perché essa è parte organica dell'essere umano. Ci è strutturale fin nel più profondo di noi stessi. Ma questo non significa che si sia costretti a fare ciò che è stato da essa prestabilito. In maniera aprioristica (cioè indipendentemente da qualunque considerazione), all'uomo non si può rifiutare alcuna esperienza. Non esistono cose che in sé non si possono fare. Semplicemente l'uomo deve chiedersi, nel mentre decide di farle, se esse sono compatibili con le esigenze o le leggi della natura.
La natura può offrire un criterio oggettivo con cui stabilire se un'azione sia giusta o sbagliata, ma, in ultima istanza, è l'uomo che deve deciderlo, appunto perché è dotato di libertà di coscienza. L'uomo è tenuto a prendere delle decisioni, mentre negli animali si tratta semplicemente di adattarsi alla mutevolezza delle circostanze. La loro intelligenza si basa unicamente sugli istinti e sull'uso delle percezioni sensibili. Non si pongono mai il problema di come modificare l'ambiente.
Negli esseri umani l'adattamento è sicuramente una componente fondamentale della loro personalità, ma in loro è presente anche il desiderio di modificare la realtà. L'essere umano sa di poterlo fare, quindi, in ultima istanza, egli deve rendere conto solo a se stesso di ciò che fa. Infatti è una sua specifica responsabilità (che non può appartenere a nessun altro) se dalle sue azioni si ricavano conseguenze dannose per l'ambiente.
Tutto questo per dire che porre la nascita delle civiltà, cioè l'inizio dell'involuzione dell'umanità, in un periodo in cui l'essere umano scopriva l'agricoltura e l'allevamento, è sbagliato. Opporre i cacciatori-raccoglitori agli agricoltori e allevatori non ha alcun senso se l'opposizione viene presa in sé e per sé. Anche perché gli stessi cacciatori potrebbero essere visti in opposizione ai raccoglitori: chi ha dato all'uomo il diritto di uccidere gli animali?
L'atto della “produzione” è connaturato all'uomo e, se vogliamo, alla stessa natura. Non si può demonizzarlo solo perché, ad un certo punto della storia umana, esso ha comportato la devastazione dell'ambiente e la creazione di rapporti sociali innaturali. L'uomo deve semplicemente capire quando la sua “produzione” entra in conflitto con se stesso e con le esigenze riproduttive della natura.
Negare all'uomo il diritto alla “produzione” significa ridurlo automaticamente al livello dell'animale. La genuinità o autenticità della natura umana non sta tanto nel mantenersi integra, così com'era ai primordi dell'umanità, secondo le leggi di natura, che pur hanno indubbiamente un carattere di universalità e di necessità, ma sta nello svilupparsi rispettando le condizioni della propria umanità, che non possono certo essere contraddittorie con le leggi della natura. La coscienza umana ha l'obbligo di conformarsi alle leggi di natura, ma ha pure il privilegio di sentirsi superiore a queste stesse leggi, in quanto appunto ne rappresenta il livello di autoconsapevolezza.
Là dove c'è sviluppo o progresso nella consapevolezza di sé, non può mancare la memoria, altra fondamentale facoltà umana, la cui utilità è però recisamente negata da Zerzan. Egli infatti, come se vivesse in un mondo animale, accetta solo il presente, senza rendersi conto che, se esistesse solo il presente, il pensiero sarebbe poverissimo, avendo una memoria molto corta. Tutto sarebbe funzionale alla soddisfazione di bisogni immediati, irriflessi. Di nuovo ricadremmo nell'istintività animalesca, la cui memoria assomiglia alla RAM dei computer, la quale serve, in maniera provvisoria, per far funzionare al meglio il sistema operativo e i vari programmi, e di cui noi ci lamentiamo sempre, perché sembra non bastare mai, soprattutto quando si vogliono usare più programmi contemporaneamente.
La memoria degli animali è in funzione delle percezioni sensoriali che si attivano in un dato momento. Non è una memoria su cui si possono fare dei ragionamenti in assenza di un determinato contesto spazio-temporale. Argo, il cane di Ulisse, che lo riconobbe dopo vent'anni di assenza e che, al rivederlo, per l'emozione morì, aveva conservato, in un angolo remoto della sua memoria, il ricordo percettivo del suo padrone, ma per vent'anni questo ricordo non l'aveva affatto usato, semplicemente perché non ne avvertiva il bisogno. Ecco perché la differenza tra essere umano e animale è abissale. Anche Penelope non vedeva Ulisse da un ventennio, ma la sua ansia, la sua angoscia, il suo struggimento interiore erano di ben altra natura. Semmai si potrebbe discutere se Ulisse provasse gli stessi sentimenti della moglie, preso com'era ad affermare il proprio egocentrismo guerrafondaio, nemico mortale dei Troiani e sprezzante di tutte le tradizioni pre-schiavistiche.
L'analisi di Zerzan è superficiale anche per questo motivo: tutto quello che nega (agricoltura, allevamento, linguaggio, simboli, tempo, arte, religione, numero, proprietà privata, divisione del lavoro, ecc.) non viene da lui differenziato nel suo sviluppo storico. Tutto viene infilato in un unico sacco, come se ogni singola cosa si fosse sviluppata contemporaneamente alle altre. E inevitabilmente le rende intercambiabili, sovrapponibili, come se un elemento potesse essere causa immediata dell'altro e viceversa. Contrappone il paleolitico al neolitico senza rendersi conto che la civiltà schiavistica è nata soltanto con la scoperta dei metalli, cioè alla fine del neolitico.
Si legga ora questa frase, per rendersi conto di quanto sia difficoltosa l'analisi storica di Zerzan: “solo con l'emergere della ricchezza sotto forma di granaglie immagazzinabili presero forma le divisioni in gradi della manodopera e delle classi sociali” (p. 25). In realtà non sarebbe stata possibile una produzione urbana finalizzata, in maniera precipua, all'accumulo di eccedenze in assenza di una determinata stratificazione sociale. In ambito urbano la raccolta delle eccedenze non apparteneva mai ai produttori, bensì alle autorità, siano esse religiose o civili.
La civiltà non nasce con l'eccedenza, poiché è del tutto naturale pensare a una scorta di viveri da utilizzare nei momenti di magra, altrimenti dovremmo dire che la cicala è più saggia della formica. La civiltà nasce quando questa scorta viene gestita da chi non l'ha prodotta, soprattutto con intenzioni minacciose o ricattatorie nei confronti dei produttori, al fine di aumentare il proprio potere; il tutto avvolto in giustificazioni ideologiche (per lo più mistiche) di cui il potere si serve per autolegittimarsi. Atteggiamenti di questo genere si riscontrano all'interno di contesti urbanizzati, cioè là dove è possibile costruire i palazzi o i templi del potere.
La cultura cattolica ha portato Zerzan a credere che l'unico momento felice dell'uomo sia stato quello edenico, cioè quando viveva come raccoglitore (non certo però come cacciatore!) all'interno delle foreste, senza conoscere ancora la fatica del lavoro. Ora, indubbiamente la fuoriuscita dalle foreste e l'accesso alle savane deve aver reso la vita più difficile (non foss'altro perché – questa volta sì! – il raccoglitore doveva diventare anche cacciatore), ma non si può far coincidere l'inizio della proprietà privata o quello dell'agricoltura con la rinuncia (forzata o voluta) alla vita arboricola. Prima che il cacciatore si trasformasse in allevatore e il raccoglitore in orticoltore e poi in agricoltore; prima che allevatori e agricoltori cominciassero a odiarsi spassionatamente per motivi di proprietà, devono essere passate varie migliaia di anni.
Non si può demonizzare l'agricoltura in sé, altrimenti dovremmo farlo anche con l'orticoltura, che prevede il tagliare e bruciare una porzione di foresta per uno sfruttamento temporaneo. Per essere veramente “perfetto” sul piano umano e naturale, l'uomo e la donna dovrebbero limitarsi a raccogliere i frutti spontanei della Terra, cosa che oggi forse non è possibile fare da nessuna parte. Anzi, se anche fosse possibile, ciò di per sé non scongiurerebbe il rischio che si formi una “proprietà privata”. È ingenuo pensare che tale rischio non può sussistere quando si dipende interamente dai frutti della natura o quando tali frutti sono appena sufficienti per sopravvivere. L'idea o l'istinto di privatizzare qualcosa (così ben visibile nei bambini più piccoli) può nascere proprio dal fatto che in natura gli esseri umani sono molto diversi tra loro (e sanno di esserlo), per cui occorre una “intelligenza collettiva” per impedire che tale idea possa concretizzarsi praticamente.
Se per questo non si può neppure considerare la caccia meno “violenta” dell'agricoltura. Finché si cacciano insetti o animali acquatici, il cui cervello non è particolarmente sviluppato, si può anche pensare di non compiere alcuna violenza, ma quando si cominciano a cacciare dei mammiferi, l'uomo non può non chiedersi se non sarebbe il caso di cercare delle alternative. Gli indiani del Nord America quando cacciavano i bisonti provavano sensi di colpa, certamente superiori alle tribù che praticavano l'agricoltura, anche se non avrebbero mai accettato l'idea di ferire madre natura, cioè la terra, con un aratro.
La vita in sé del cacciatore non è più “naturale” di quella dell'agricoltore. L'unica vita davvero naturale è stata quella del raccoglitore di frutti selvatici prodotti dalla natura. L'uomo infatti può servirsi degli animali per il proprio nutrimento, senza bisogno di ucciderli (p. es. il latte dei bovini, il miele delle api, le uova degli uccelli, ecc.), ma quando arriva al punto da ritenere necessario, per la propria sopravvivenza, uccidere taluni animali, non può non arrivare a chiedersi se non sarebbe meglio diventare agricoltori. A meno che non si voglia sostenere il diritto di cibarsi di un animale soltanto quando esso è alla fine naturale dei suoi giorni.
La caccia, come sistema di vita, può essere nata solo per necessità, vivendo in ambienti dove la raccolta dei frutti spontanei della terra era particolarmente difficile; ed è nata osservando che taluni animali si cibavano di altri animali. È difficile comunque pensare che, a parità di condizioni, potendo scegliere tranquillamente tra caccia e agricoltura, l'uomo avrebbe preferito uccidere. È evidente che se per migliaia di anni egli è stato cacciatore, significa che per lui quella era l'unica vera chance che aveva per sopravvivere con relativa sicurezza. Nelle civiltà schiavistiche l'uccisione di taluni animali, a scopi religiosi, era così importante che veniva considerata obbligatoria, a testimonianza che questo rito era il massimo possibile da poter offrire a una divinità, cioè si esercitava una violenza sull'animale sperando di non riceverla da parte dei propri simili, sperando cioè di essere protetti da parte di qualche dio.
Il fatto che l'agricoltura non sia nata in concomitanza con la caccia probabilmente dipese da circostanze contingenti e involontarie. L'agricoltura presuppone una certa abilità, una buona dose di conoscenze della natura, di osservazione diretta e costante di taluni fenomeni e quindi di una permanenza sufficientemente stabile in un determinato territorio. È facile pensare che l'agricoltura sia emersa per venire incontro alle difficoltà della caccia. In ogni caso la nascita dell'agricoltura non può di per sé coincidere con la nascita della proprietà privata. Quando le due cose marciano insieme si è già in presenza delle prime civiltà fluviali, sorte là dove i territori erano impervi a causa delle periodiche esondazioni dei fiumi, le cui acque, per renderle produttive sul piano agricolo, dovevano essere incanalate e bonificate, altrimenti restavano soltanto paludi infestate da insetti. (7)
La civiltà schiavistica non è emersa intorno al villaggio anatolico di Çatal Hüyük o alla città di Gerico, di 9-10.000 anni fa: quelle sono state eccezioni che non hanno fatto testo. Le civiltà schiavistiche vere e proprie sono nate nei luoghi più impervi del pianeta, com'era naturale che fosse, e quindi circa 6.000 anni fa. Inizialmente l'agricoltura, previa bonifica delle paludi e canalizzazione delle acque per l'irrigazione, non ha affatto devastato l'ambiente, ma anzi l'ha migliorato. Le devastazioni sono venute successivamente, quando il potere istituzionale e le classi proprietarie non si accontentavano più di eccedenze minime. Caino non uccide il pastore Abele perché era agricoltore, ma perché si era imposta la proprietà privata; e il mito di Romolo e Remo va spiegato nello stesso modo.
Se si sostiene che “l'agricoltura emerse simultaneamente ai concetti di tempo, linguaggio, numero e arte”, senza precisare a quale contesto agricolo ci si riferisce, si esprime soltanto un pensiero astratto, che storicamente non vuol dir nulla. Una simultaneità del genere è infatti tipica delle civiltà fluviali di 6.000 anni fa. Zerzan parla continuamente di un'agricoltura di 10.000 anni fa, ma a quel tempo non esisteva ancora la proprietà privata, e quindi non poteva esistere, p. es., il numero.
Qui non si vuole contestare il fatto che l'agricoltura delle civiltà fluviali, fondamentalmente basate sulla proprietà privata o statalizzata, comportasse necessariamente un modo diverso, alienato o illusorio, di vivere il tempo, l'arte, il numero, ecc. Qui si vuole semplicemente precisare che tali modi alienati o illusori di vivere certe espressioni dell'intelligenza umana erano determinati non tanto dall'agricoltura in sé quanto piuttosto dalla presenza della proprietà privata. Cioè a partire dal momento in cui si era soltanto raccoglitori di frutti spontanei della foresta sino al momento in cui si è diventati agricoltori coatti, deve essere trascorso un periodo abbastanza lungo, in cui qualunque attività produttiva, in assenza di proprietà privata, veniva tranquillamente tollerata.
Dire che l'agricoltura, in sé, è “l'atto di nascita della produzione”, senza specificare a quale tipo di agricoltura ci si riferisce, è dire cosa senza senso. Tutte le attività umane sono “produttive”, anche quando si raccolgono frutti spontanei della foresta: infatti si devono costruire dei rifugi, ci si deve proteggere da taluni animali, si è in competizione con loro per la raccolta del cibo, ci si deve chiedere quanto tempo occorra perché un determinato cibo si riproduca, se sia davvero commestibile, se possa essere associato ad altri cibi, quanto sia nutriente, e cose del genere.
Anche la caccia è una forma di “produzione di cibo”. Il raccoglitore “produce” cibo sfruttando la riproduzione vegetale della natura, mentre il cacciatore sfrutta quella sessuale degli animali. Entrambi “producono” cibo nel senso che lo “trasformano”. Tutte le cose, in natura, vanno trattate, manipolate, per essere facilmente consumate, digerite, metabolizzate. Si pensi solo all'importanza che ha avuto, ai fini dell'alimentazione, il fuoco. Persino alcuni animali devono preoccuparsi di questa lavorazione (p. es. le api). Se noi mangiassimo come mangia la stragrande maggioranza degli animali, cioè senza rielaborare il cibo che trova, probabilmente avremmo una vita molto più breve.
Quando il raccoglitore si trasforma in agricoltore e il cacciatore in allevatore si assiste soltanto a un'evoluzione nel modo di produrre: non si è ancora in presenza di un dramma, quello appunto della proprietà privata. L'agricoltore non fa che imitare la natura in maniera sistematica, secondo un certo ordine, una certa razionalità. Sono intelligenze diverse, quelle dell'agricoltore e del cacciatore, che non è possibile vedere in alternativa. Quanto meno Zerzan avrebbe dovuto porre una distinzione tra un'agricoltura finalizzata all'autoconsumo e una invece interessata a produrre eccedenze da vendere sul mercato. Anche un'agricoltura intensiva e una estensiva non sono la stessa cosa. Una terra fertilizzata col concime organico e una invece col concime chimico sono completamente diverse. Inoltre non è affatto da escludere che il passaggio epocale non sia stato tanto quello da raccoglitore ad agricoltore quanto piuttosto quello da raccoglitore a cacciatore e, successivamente, quello da cacciatore ad agricoltore e allevatore. Lo stesso raccoglitore può essere diventato cacciatore stando dentro la foresta, anch'egli per necessità, e potrebbe avere iniziato la domesticazione di taluni animali continuando a restare nella foresta. Le transizioni da uno stile di vita a un altro sono state sicuramente molteplici.
L'allevatore è forse un cacciatore sedentario? No, perché le mandrie di bovini e ovini hanno bisogno di pascoli, per cui si deve per forza essere nomadi, perlomeno in momenti particolari dell'anno. L'allevatore è abituato a uccidere animali esattamente come il cacciatore: la differenza sta nel fatto che l'uno si affida alla riproduzione spontanea degli animali; l'altro invece la vuole controllare. Zerzan è assolutamente contrario alla domesticazione degli animali, ma non si rende conto che una vita da raccoglitore è possibile soltanto in una foresta ben fornita, mentre quella del cacciatore presuppone una selvaggina abbondante, che non è certo possibile senza foreste. Peraltro sia dentro che fuori dalle foreste si ha bisogno di un collettivo che faccia da supporto: non sono mai esistiti raccoglitori o cacciatori individuali e tanto meno agricoltori o allevatori individuali.
Quando scrive i suoi libri sembra che Zerzan non abbia nessuno dietro di sé, parla con entusiasmo di cose che non può aver mai visto, usa spesso i racconti degli antropologi, i quali però descrivono esperienze primitive lontanissime dalla sua, anche in senso geografico o temporale. Nel profilo biografico delineato dal curatore del libro è scritto che nella sua vita Zerzan ha fatto i lavori più svariati, per un certo periodo è stato un alcolista, prendeva il sussidio di disoccupazione, vendeva il proprio sangue per campare, e oggi vive in una casa occupata, fa il baby-sitter e talvolta il giardiniere, naturalmente leggendo e scrivendo molto. Una vita del genere cos'ha a che fare con quella dei cacciatori o dei raccoglitori? Non vuole essere “produttivo”, né schiavo di nessuno, ma per vivere ha bisogno della “produzione” altrui. È questo il modo migliore di opporsi al capitalismo? È forse questo l'esempio migliore che ha da offrire l'anarco-primitivismo?
La mentalità anarchica è superficiale proprio per questa ragione: temendo l'abuso della libertà di coscienza, ne vorrebbe ridurre al minimo l'uso. Paradossalmente la mentalità anarchica viene a configurarsi, seppur in forma rovesciata, come quella autoritaria, che pur dice di voler combattere. Probabilmente Zerzan non ha le idee chiare proprio perché fa coincidere “civiltà” con “divisione del lavoro” e non anzitutto e soprattutto con “proprietà privata”. Quest'ultima, per lui, è solo un fenomeno correlato all'altro, quando, in realtà la divisione del lavoro, di per sé, non implica affatto la presenza della proprietà privata. Infatti è la natura stessa che, per ottenere maggiore efficienza, s'incarica di suddividere ruoli e funzioni.
Può forse essere considerato un caso che la riproduzione della specie umana sia un compito più femminile che maschile? Perché tale funzione non è stata resa intercambiabile? Evidentemente la natura voleva attribuire al maschio compiti diversi, più legati alla forza muscolare, alla difesa del territorio, alla protezione della famiglia, alla caccia di animali pericolosi o di una certa stazza e cose del genere. Le donne non andavano a cacciare forse perché erano meno intelligenti o meno astute degli uomini? Non era certo per questo motivo. A parte il fatto che anche le donne cacciavano animali di piccole dimensioni e che, molto probabilmente, sono state proprio loro a “inventare” agricoltura e allevamento (per non parlare della tessitura, della fitoterapia, ecc.), chiediamoci: non è forse vero che se in una battuta di caccia morissero delle donne, il danno sarebbe di molto superiore per la riproduzione fisica della comunità? Comunque sia, è evidente che mentre gli uomini andavano a caccia, qualcuno doveva tenere sotto controllo il villaggio e la prole.
La divisione del lavoro è un fatto del tutto naturale; semmai è innaturale che, in nome di essa, si rivendichino dei diritti ingiustificati, cioè dei privilegi. Cosa, appunto, che gli uomini iniziarono a fare a partire dall'introduzione, nel collettivo di appartenenza, della proprietà privata. La divisione del lavoro esiste anche tra gli animali e nessuno la mette in discussione: basta vedere, ad es., come generalmente sono le leonesse in gruppo, e non i leoni, a cacciare.
L'analisi di Zerzan sull'agricoltura comincia a diventare interessante soltanto quando appare riferita espressamente alle civiltà schiavistiche. È vero che lui fa di tutta l'erba un fascio, paragonando, nell'essenza, le prime civiltà fluviali schiavistiche alle società neolitiche, ma è anche vero che se le sue osservazioni vengono applicate alle sole civiltà schiavistiche, acquistano molta della loro fondatezza, benché fino a un certo punto. Zerzan infatti a partire dal momento in cui è nata l'agricoltura ad oggi vede solo un continuo regresso, peraltro sempre più grave, in ragione della maggiore potenza distruttiva dei mezzi produttivi.
Egli è un estremista e, come tutti gli estremisti, non vede alcuna dialettica nel processo storico. Cioè non vede che dal tempo dello schiavismo ad oggi vi sono state anche delle lotte per ottenere una libertà sempre più significativa. Siccome per lui queste lotte non hanno conseguito un risultato definitivo, vanno considerate, in ultima istanza, del tutto inutili. Così ragiona l'estremista: o tutto o niente. Un ragionamento che si trova anche nel nichilista e in tutti gli individualisti irrazionalistici: non a caso egli apprezza molto Freud e Nietzsche.
Qual è invece il criterio per poter parlare di un'agricoltura ecologicamente sostenibile? Ne esistono almeno quattro.
Si deve produrre anzitutto per l'autoconsumo e non per il mercato. Le eccedenze che si ricavano non devono essere accumulate per essere vendute sul mercato. Naturalmente non si può impedire il baratto delle eccedenze.
La terra va concimata in maniera organica (p.es. col letame o i rifiuti domestici), non chimica. Non è indispensabile rovesciare in profondità le zolle, in quanto anche le erbacce tagliate (o soffocate dalla neve) costituiscono un concime.
La lotta integrata contro gli insetti nocivi (erbivori) va fatta con altri insetti (carnivori) o con l'uso di sostanze non chimiche.
Bisogna praticare la rotazione delle colture, diversificandole periodicamente.
Bisogna non adibire il terreno a una specifica monocultura ma a più colture contemporaneamente (permagricoltura), in grado di stare tra loro in un rapporto sinergico (di difesa reciproca), in quanto fisicamente prossime.
Forse l'agricoltura può non essere sufficiente per la sopravvivenza di una comunità; forse può aiutare anche la raccolta di frutti selvatici in boschi e foreste (se ancora ve ne sono); forse può risultare indispensabile praticare anche l'allevamento (all'aperto, non in capannoni industriali) o la caccia (regolamentata): di sicuro sappiamo che senza agricoltura oggi la vita è impossibile. Dobbiamo semplicemente porre l'agricoltura al servizio di una comunità locale che non preveda la proprietà privata dei mezzi produttivi. In questa maniera si toglierà all'agricoltore l'ansia di non poter ricavare abbastanza reddito dallo sfruttamento capitalistico dei suoi terreni; gli passerà la paura di non avere abbastanza terra, di non avere macchinari avanzati, di non avere sufficiente potere di contrattazione sul prezzo dei suoi prodotti, di non saper fronteggiare la concorrenza e di dover cercare continuamente quale prodotto agricolo sia più conveniente sul mercato. Dobbiamo indurlo a lavorare la terra in maniera biologica, senza preoccuparsi di nulla che riguardi il mercato, neppure della bellezza estetica dei suoi prodotti. (8) Dobbiamo assicurargli che il suo lavoro permetterà un'esistenza dignitosa non solo alla sua famiglia ma anche a quella dell'intera comunità. Questo perché il significato del suo lavoro non starà nel successo mercantile, ma nel fatto che farà parte di un contesto comunitario locale, in cui il lavoro di ciascuno è condizione del benessere di tutti. Sarà appunto questa comunità locale a fargli capire che i suoi prodotti saranno acquistati prima ancora che li coltivi e che non subirà danni colossali se il raccolto, per qualche motivo imponderabile, andrà perduto. La sua produzione sarà pianificata (nella quantità dei beni e nella loro tipologia) dalla stessa comunità che li consumerà.
Per verificare la portata anticapitalistica dell'approccio etnografico in sociologia, nello studio delle realtà marginali urbanizzate, cfr i testi della Scuola di Chicago: Robert Park (1864-1944), Ernest Burgess (1886-1966), Nels Anderson, The Hobo (1923), Frederic Thrasher, The Gang (1927), Louis Wirth, The Ghetto (1928).
Fuori da questa Scuola e sempre negli Stati Uniti sono da vedere i testi dei coniugi Robert e Helen Lynd, Middletown (1929) e Middletown in Transition (1937), quest'ultimo dedicato all'analisi delle trasformazioni sociali conseguenti alla crisi del 1929.
In Europa cfr i testi di Marc Augé: Genio del paganesimo, ed. Bollati Boringhieri, 1982 Torino; Simbolo, funzione, storia: gli interrogativi dell'antropologia, ed. Liguori, 1982 Napoli; Un etnologo nel metrò, ed. Elèuthera, 2005 Milano; Il senso del male: antropologia, storia e sociologia della malattia, ed. Il Saggiatore, 1986 Milano; Ville e tenute. Etnologia della casa di campagna, ed. Eleuthera, 1994 Milano; Non-luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, ed. Elèuthera, 1996 Milano; Il senso degli altri, ed. Bollati Boringhieri, 2000 Torino; Poteri di vita, poteri di morte: introduzione a un'antropologia della repressione, Raffaello Cortina Editore, 2003 Milano; L'antropologia del mondo contemporaneo (con Jean-Paul Colleyn), ed. Eleuthera, Milano 2006; Dialogo di fine millennio: tra antropologia e modernità (con A. Torrenzano), ed. L'Harmattan Italia, 1997 Torino; L'antropologo e il mondo globale, Raffaello Cortina Editore, 2013 Milano; Finzioni di fine secolo. Che cosa succede, ed. Bollati Boringhieri, 2000 Torino; Le forme dell'oblio, ed. Il Saggiatore, 2000 Milano; Il dio oggetto, ed. Meltemi, 2002 Roma; Rovine e macerie. Il senso del tempo, ed. Bollati Boringhieri, 2003 Torino; Perché viviamo?, ed. Meltemi, 2003 Roma; Il mestiere dell'antropologo, ed. Bollati Boringhieri, 2007 Torino; Tra i confini: città, luoghi, integrazioni, ed. Bruno Mondadori, 2007 Milano; Un altro mondo è possibile, Codice edizioni, 2017 Torino; Un etnologo al Bistrot, Raffaello Cortina Editore, 2015 Milano; Il tempo senza età: la vecchiaia non esiste, Raffaello Cortina Editore, 2014 Milano; Futuro, ed. Bollati Boringhieri, 2012 Torino; Per un'antropologia della mobilità, ed. Jaca Book, 2010 Milano; La guerra dei sogni, ed. Eléuthera, Milano 1998; Storie del presente. Per un’antropologia dei mondi contemporanei, ed. Il Saggiatore, Milano 1997.
Augé ha svolto numerose ricerche etnografiche in Africa, soprattutto in Costa d'Avorio e Togo. Dopo la metà degli anni Ottanta ha diversificato i suoi campi di osservazione, effettuando numerosi soggiorni in America Latina e osservando la realtà del mondo contemporaneo nel contesto a lui più vicino: Francia, Italia e Spagna. Nel testo sui Non-luoghi ha focalizzato l'attenzione su alcuni aspetti tipici della società contemporanea metropolitana, quali p.es. il paradossale incremento della solitudine e dell'estraneità nonostante la grande evoluzione dei mass-media e l'incredibile afflusso di persone verso i luoghi più frequentati della società consumistica: aeroporti, alberghi, autostrade, grandi magazzini, ecc.
Naturalmente bisogna fare attenzione a questi miscugli di antropologia, psicologia e sociologia, poiché il fatto di parlare di cose molto concrete, come in genere si fa in queste discipline, non significa che gli studiosi non ritengano la cultura dominante come imprescindibile o che le situazioni di degrado, emarginazione... del sistema non vengano considerate come inevitabili, per le cui soluzioni non si può andare oltre ai meri palliativi. Generalmente anzi gli antropologi hanno comportamenti più risibili dei sociologi e degli psicologi, poiché, mentre questi si pongono chiaramente al servizio del sistema, quelli invece fanno mostra d'essere contrari allo sfruttamento del Terzo e Quarto Mondo, salvo poi trovare dei compromessi che, invece di fare totalmente gli interessi delle comunità indigene, le quali hanno mille volte più ragioni delle migliori intenzioni che gli occidentali possano avere nei loro confronti, le mettono in condizioni ancora più gravi delle precedenti.
Note
(1) Può apparire vetusta la definizione di “Terzo Mondo” dopo il crollo del cosiddetto “socialismo reale”, che, agli occhi degli intellettuali occidentali, appariva come “secondo” rispetto al capitalismo. Se si preferiscono definizioni come “Paesi in via di sviluppo” o “Paesi emergenti” va bene lo stesso, non ci formalizziamo. Difficile però pensare che per questi Paesi, presi nella loro interezza, sia davvero migliorata la loro situazione di “sottosviluppo”, di cui si è parlato sino alla fine degli anni Settanta.
(2) Apparteneva all'etnia kikuyu, le cui ragazze contadine, quando il Kenya era una colonia inglese, non potevano neppure andare a scuola. Ma nel 1971 sarà la prima keniota a ricevere un dottorato e nel 1974 la prima a diventare professore assistente. Il suo cognome aveva una doppia “a” perché il marito, che aveva divorziato da lei, le aveva vietato di usare il cognome acquisito da sposata.
(3) La Fondazione è nata nel 1980, grazie all'iniziativa di Jakob von Uexküll, un tedesco-svedese di origine nobile, parlamentare europeo dei Verdi, che la finanziò con un milione di dollari, vendendo la sua enorme e preziosa collezione di francobolli. Questo perché l'Accademia svedese si era rifiutata di creare una nuova categoria su “Ambiente e Sviluppo”. Oggi però il premio ha assunto una dignità tale da essere attribuito nella stessa sede del Nobel tradizionale, cioè presso il Parlamento svedese, il giorno prima dell'altro, il 9 dicembre di ogni anno. Non sono previste categorie vere e proprie da premiare, come chimica, medicina ecc, ma vengono valutate iniziative in diverse aree: ambiente, conservazione ecologica, tecnologia ed economia alternativa, iniziative a favore delle popolazioni svantaggiate. Il nonno del parlamentare fu il famoso Jakob Johann von Uexküll (1864-1944), biologo, zoologo e filosofo estone, pioniere dell'etologia e uno dei fondatori dell'ecologia, la cui importanza si fece sentire persino sulla fenomenologia, l'ermeneutica e la semiotica.
(4) Altri teorici del socialismo africano furono Amílcar Cabral (Guinea-Bissau e Capo Verde), Kenneth Kaunda (Zambia), Modibo Keïta (Mali), Samora Machel (Mozambico), Nelson Mandela (Sudafrica), Thabo Mbeki (Sudafrica), Albert Luthuli (Sudafrica), Michel Micombero (Burundi), Eduardo Mondlane (Mozambico), Robert Mugabe (Zimbabwe), Sam Nujoma (Namibia), Oginga Odinga (Kenya), Didier Ratsiraka (Madagascar), Jerry Rawlings (Ghana), Thomas Sankara (Burkina Faso), Léopold Sédar Senghor (Senegal), Ahmed Sékou Touré (Guinea).
(5) Alcuni esempi di socialismo africano sono anche l'umanesimo zambiano di Kenneth Kaunda, e il coscienzismo del ghanese Kwame Nkrumah. Sebbene l'interpretazione africana del socialismo fosse piuttosto diversa da quella sovietica, durante la guerra fredda i Paesi africani con governi socialisti furono in genere apertamente schierati con URSS, Cina e Cuba. Solo in rari casi, tuttavia, si ebbero effimeri tentativi di strutturare lo Stato secondo il modello sovietico (alcuni esempi sono quelli dei leader Agostinho Neto, Marien Ngouabi, Kwame Nkrumah e Siad Barre).
(6) Per saperne di più cfr J. Nyerere, Socialismo in Tanzania, ed. Il Mulino, Bologna 1970. La scelta socialista in Etiopia, Somalia e Tanzania (a cura di M. Guadagni), ed. CLUET, Trieste 1979. A. M. Gentili, Il leone e il cacciatore. Storia dell'Africa sub-sahariana. ed. Carocci, Roma 1995. www.wikiwand.com/it/Comunit%C3%A0_economica_africana
(7) In controtendenza rispetto alle città mesopotamiche ed egizie fu la siriana Ebla, che non si arricchì grazie a un fiume. Pur vivendo in un territorio arido e inospitale, ebbe la fortuna di trovarsi in una posizione strategica tra importanti regni dell'antichità, collocati in Mesopotamia, Anatolia, Egitto e Palestina. Cosa che non le impedì d'essere completamente distrutta per ben tre volte.
(8) Lavorare in maniera biologica oggi sostanzialmente vuol dire: praticare la rotazione delle colture; eliminare pesticidi e fertilizzanti chimici o sintetici (e anche gli antibiotici); vietare gli organismi geneticamente modificati; utilizzare il letame e il compost, nonché le specie animali e vegetali resistenti alle malattie e adattate nei secoli all'ambiente; allevare il bestiame all'aria aperta e nutrirlo con foraggio biologico. Oggi peraltro non sono poche le tecniche di lotta integrata contro i parassiti, che riducono drasticamente l'uso dei fitofarmaci.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube