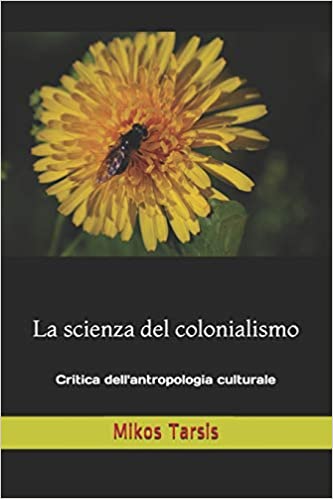
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
L'antropologia economica
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Si parla di “antropologia economica” a partire dal trattato dell'antropologo statunitense di origine ebraica, discepolo di Franz Boas, Jean Melville Herskovits (1895-1963), Economic anthropology: the economic life of primitive peoples, del 1940, (1) anche se già prima di lui Bronis?aw Malinowski e Marcel Mauss avevano messo in dubbio l'universalità del concetto di "homo oeconomicus", nel senso che, studiando le società primitive, non tutto è classificabile in termini di “acquisto e vendita”. Lo stesso Boas aveva dovuto constatare che quando si distruggono volontariamente dei beni per acquisire prestigio, si fa fatica a interpretarli con le categorie del liberismo economico.
Tuttavia fu solo a partire dal suddetto trattato di antropologia economica (frutto di studi sul campo in Benin, Suriname e Trinidad), cui vanno aggiunte le riflessioni anti-capitalistiche di Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg e Harry W. Pearson, alla fine degli anni Cinquanta, nel loro lavoro Traffici e mercati negli antichi imperi: le economie nella storia e nella teoria (ed. Einaudi, Torino 1978), che si aprì un acceso dibattito, principalmente nei settori accademici degli Stati Uniti, tra la corrente “formalista” e quella “sostanzialista” (o “sostantivista”). Il dibattito, durato dal 1957 al 1971, si concluse con una definizione più precisa dello statuto epistemologico dell'antropologia economica, più vicina alle idee sostantivistiche, aventi come punto di riferimento l'opera fondamentale di Polanyi, La grande trasformazione (1944).
I formalisti ritenevano che i concetti base dell'economia politica classica potessero essere applicati anche alle società primitive, in quanto qualunque comportamento economico consiste nell'operare scelte convenienti in presenza di risorse scarse. La convenienza è sempre di carattere personale, basata sull'interesse: l'individuo spiega il sociale, poiché la società non è che una somma di individui. L'obiettivo economico di qualunque società è sempre quello di produrre di più col minimo sforzo (principio di massimizzazione). Il che non vuol dire che un sistema sociale non occidentale debba essere definito “primitivo” o “arretrato”, anche se indubbiamente un'economia primitiva è tale proprio perché non possiede un mercato, una valuta e una tecnologia meccanizzata. Semplicemente ogni sistema deve cercare il suo punto di equilibrio: l'economia non è che una relazione intelligente tra fini e mezzi, in cui l'individuo ha esigenze potenzialmente illimitate, mentre le risorse disponibili non lo sono. La pensavano così non solo Herskovits, ma anche D. M. Goodfellow, R. W. Firth, E. E. LeClair, H. K. Schneider, R. Burling, F. Barth, R. Paine, R. F. Salisbury, B. Epstein, L. Sharp, L. J. Pospíšil...
I sostantivisti (G. Dalton, D. Kaplan, P. Bohannan, C. Arensberg, R. Pearson...) si rifacevano a Polanyi, il quale aveva detto che nell'economia primitiva prevale, come relazione sociale, la reciprocità: p.es. le bande di cacciatori-raccoglitori, organizzate in gruppi parentali, si aiutavano reciprocamente. Al massimo si può essere in presenza di una redistribuzione egualitaria (una sorta di “socialismo statale”) di beni e servizi di cui si fa responsabili un organo centrale nei confronti di una popolazione locale, dopo averli ricevuti da questa stessa popolazione. In entrambi i casi la politica controlla l'economia, cosa che nel capitalismo avviene in maniera inversa. L'economia primitiva è parte organica di un tutto, che pretende d'essere autosufficiente, autoregolato: la presenza di un mercato da cui dipendere avrebbe poco senso. Il sociale ingloba completamente l'economico: le transazioni economiche non possono essere comprese al di fuori degli obblighi sociali. Inoltre la dipendenza nei confronti della natura non può essere messa in discussione. Dunque le differenze tra economia primitiva e industriale non sono di grado ma qualitative. Le tesi sostantiviste furono poi sviluppate da un gruppo di antropologi che le collegò ad aspetti simbolico-culturali e cognitivi per spiegare i fenomeni economici: A. Appadurai, M. Sahlins,, I. Kopytoff, M. Douglas e B. Isherwood.
Uno dei settori in cui l'odierna antropologia può dire qualcosa di interessante al mondo occidentale è quello economico. I vari sistemi di autosussistenza primitivi possono farci capire che il capitalismo non è il modo migliore per garantire un'esistenza sufficientemente equilibrata sul piano materiale. Gli antropologi non devono aver paura di dirlo. A loro spetta il compito di dimostrare che il presente non è migliore del passato solo perché ci è contemporaneo.
Non bisogna anzitutto dimenticare che fino a 10.000 anni fa gli esseri umani di qualsiasi parte del mondo erano cacciatori e raccoglitori. Ci si accontentava delle risorse disponibili, quelle che si vedevano a occhio nudo, perché presenti sulla superficie terrestre o immediatamente sotto (per es. frutta a guscio, bacche, meloni, radici e tuberi, miele, insetti e uova nelle foreste, ecc.). Quando si volevano risorse anche di tipo animale, si andavano a cercare le prede di cui si conoscevano le tracce, che si potevano catturare con relativa destrezza e abilità usando archi e frecce, lance, cerbottane, reti, coltelli, trappole (per gli animali di grosse dimensioni occorreva una battuta di caccia collettiva). Nessuno ha mai detto che nelle foreste la vita fosse facile, ma di sicuro non lo era standosene fuori. Semmai si può accettare l'idea che gli umani frequentassero ambienti diversi a titolo di pura curiosità. Ma era sempre la foresta a garantire la necessaria protezione.
Non si sapeva neanche lontanamente cosa fosse la proprietà privata dei mezzi produttivi: un principio oggi scontato in qualunque diritto costituzionale del mondo. Al massimo una tribù poteva rivendicare su un'area produttiva alcuni diritti d'uso nei confronti di un'altra tribù, ma era difficile che tali diritti venissero rivendicati in maniera assolutamente esclusiva. La proprietà privata anche di una semplice porzione di territorio era inconcepibile. Di regola infatti venivano concesse delle autorizzazioni temporanee agli stranieri (p. es. un gruppo di passaggio), onde evitare qualunque contenzioso che avrebbe potuto implicare degli effetti nocivi. Generalmente anzi si guardava con favore l'ospitalità, in previsione di ottenere, in caso di necessità, il ricambio dell'aiuto prestato.
A dir il vero dai primi ominidi bipedi africani vissuti a partire da circa 4-6 milioni di anni fa sino ai più antichi rappresentanti del genere umano (Homo habilis, Homo erectus, ecc.), si è vissuti di sola raccolta spontanea di frutti selvatici, in quanto il pianeta ne era ricchissimo e la popolazione era scarsa. La caccia è stata introdotta solo dall'Homo sapiens.
Si è passati alla caccia non tanto perché la popolazione era aumentata in maniera considerevole, ma semplicemente perché, ad un certo punto, si era usciti dalle foreste. Paradossalmente la caccia non è avvenuta dove sarebbe stato più facile praticarla, cioè appunto nelle foreste, ma nella prateria o nella savana o nella tundra. L'uomo ha cominciato ad armarsi in un territorio poco praticabile, con scarsa vegetazione, tendenzialmente ostile, altrimenti non ne avrebbe avuto alcun motivo. Negli spazi aperti ha incontrato animali molto veloci o pericolosi, in competizione tra loro, oppure animali di grandi dimensioni, che non avrebbero potuto vivere nelle intricate foreste, e che anzi, essendo erbivori, tendevano a ridurne le dimensioni. I carnivori, mangiandosi gli erbivori, impedivano agli erbivori di mangiarsi le foreste.
La caccia e la raccolta non sono forme di economia produttiva ma acquisitiva (o di prelievo). Tuttavia nella caccia si deve praticare una forma di violenza che può indurre nell'uomo dei sensi di colpa. Finché si poté praticare la sola raccolta, qualunque forma di violenza era impossibile, e non solo perché il cibo era abbondante per tutti, ma anche perché gli animali costituivano per l'uomo una fonte d'insegnamento a livello comportamentale, oltre che un'occasione di svago e di compagnia. Il massimo che gli uomini potevano fare agli animali della foresta era di sottrarre qualche uovo nei nidi di uccelli o del miele alle api. In ogni caso è impossibile immaginare che gli uomini vivessero nelle foreste senza mai poter vedere un fiume, un lago o un mare. Prima di essere stati cacciatori di animali terrestri, dovevano essere stati pescatori. Dai pesci non potevano imparare quasi nulla per la loro vita in superficie, quindi non potevano avvertire sensi di colpa quando si cibavano di molluschi, crostacei o di pesci catturati con reti, fiocine e arpioni.
Perché l'uomo sia uscito da una condizione così favorevole resta un mistero. Di sicuro è sbagliato sostenere che le prime forme di raccolta del cibo siano avvenute nella prateria o nella savana, approfittando della stagione umida o usando, nella stagione secca, un bastone appuntito per cercare tuberi e radici. In questi territori, in cui non ci si può nascondere, se non si caccia, non si può sopravvivere. La raccolta diventa solo un'attività collaterale. Poi col tempo l'uomo arriverà a capire che può addomesticare alcuni animali erbivori, in grado di fornirgli latticini e carne in maniera relativamente tranquilla.
La svolta: agricoltura e allevamento
Tutto cambiò in Medio Oriente circa 10.000 anni fa (dalle coste della Palestina al Golfo Persico, e, più a nord, in Anatolia), quando si cominciò ad addomesticare gli animali (inizialmente capre e pecore) e soprattutto a coltivare alcune piante (frumento, orzo...), trasformando in modo significativo l'ambiente. (2) Nel resto del mondo l'agricoltura s'imporrà tra il 9000-9500 (in Cina e Nuova Guinea) e il 5000-7000 a.C. (Africa occidentale, Centroamerica, Sud Sahara). Il motivo di tale transizione resta poco chiaro, poiché le foreste non erano ancora state distrutte e ai cacciatori la selvaggina non mancava. Che senso aveva lavorare di più e passare a un'alimentazione più povera sul piano qualitativo, molto meno diversificata, anche se più abbondante su quello quantitativo?
I paleoantropologi sostengono che 12.000 anni fa vi fu un cambiamento climatico dopo l'ultima glaciazione, che portò nel Vicino e Medio Oriente a un innalzamento della temperatura, a un incremento delle specie vegetali domesticabili, come p.es. i cereali. (3) E non è da escludere che a tale svolta abbia contribuito l'aumento della popolazione e la graduale estinzione, in quell'area geografica, dei grandi erbivori da cacciare. Sia come sia, resta evidente che nei luoghi dove la caccia è difficoltosa, si deve trovare un'alternativa alla propria sopravvivenza, e questa fu trovata vivendo in maniera stanziale in un territorio che andava profondamente modificato con nuovi strumenti e metodiche lavorative. Il bastone appuntito o la zappetta che prima serviva per trovare tuberi e radici sottoterra o per seminare qualcosa, fu collegato a un aratro, che creava solchi di file parallele ove inserire dei semi per la raccolta di legumi e cereali. All'inizio erano gli stessi uomini a tirare l'aratro, col “sudore della loro fronte” (come recita il Genesi), poi si cominciarono a usare buoi o cavalli. (4) Storicamente è accertato che intorno al 6000 a.C. in Mesopotamia si usavano i buoi per trainare l'aratro. (5)
In questo uso strumentale dell'animale non si può vedere qualcosa di “immorale”, anche perché, nell'arco di un anno, l'aratura veniva fatta una-due volte, a seconda della fertilità del terreno. Il vero lavoro consisteva nella canalizzazione e irrigazione e nel mantenere sgombri da erbacce e parassiti i campi da coltivare o le piante fruttifere. I fossati, per far scorrere bene l'acqua piovana o fluviale o di un pozzo o di un lago artificiale, andavano tenuti puliti e allineati. Una volta terminato l'impianto, che doveva prevedere l'uso di una stalla per gli animali, di un porticato per i mezzi da trasporto, di un granaio o un fienile per i cereali trebbiati, di una attrezzaia per gli strumenti agricoli..., il resto, in maniera prevalente, riguardava la manutenzione (sarchiatura, potatura, concimazione ecc.) e la difesa da eventi climatici sfavorevoli.
Per quanto riguarda la domesticazione degli animali non si sa con precisione se abbia preceduto la scoperta dell'agricoltura o sia stata contestuale ad essa. Là dove il cibo è abbondante, non vi è alcun bisogno di addomesticare gli animali, anche perché gli stessi animali non avvertono l'uomo come un pericolo. L'animale ha cominciato ad aver paura dell'uomo quando l'uomo si è trasformato in cacciatore.
L'uomo non ha mai cercato di addomesticare dei carnivori: quando l'ha fatto col lupo, l'ha trasformato in un cane adatto a proteggere le mandrie, o quando ha cercato di farlo con un felino, ha dovuto prima trasformarlo in un gatto. Nel circo si addomesticano leoni e tigri, ma il domatore non può mai sapere con sicurezza se quando entra in pista non verrà sbranato, anche perché gli animali devono lavorare a digiuno: il cibo è un premio per la loro performance.
L'uomo ha sempre preferito allevare erbivori, con esigenze alimentari poco dispendiose (almeno finché non si è entrati nell'epoca industriale), con un elevato tasso di crescita (possibile anche in cattività), di carattere non aggressivo, non soggetto al panico, in grado di vivere in un branco e di seguire un leader, uomo o animale che sia. Naturalmente col tempo gli allevamenti si sono parecchio diversificati: agli ovini e bovini si sono aggiunti i suini e gli equini, i canidi, i bachi da seta, le api, vari tipi di uccelli, il pollame, i conigli, i cammelli e i dromedari, i lama, gli alpaca, le renne ecc.
Le società pastorali, prive di agricoltura, sono potenzialmente instabili, avendo una base economica piuttosto fragile: il bestiame può essere decimato da una epidemia o razziato, e ha continuamente bisogno di acqua (il che provoca scontri tra tribù o con gli agricoltori). Tra gli antichi pastori la carne e i prodotti caseari potevano assicurare circa il 50% della dieta alimentare: il resto dipendeva da caccia e pesca o dai mercati. Dagli agricoltori potevano procurarsi i cereali e vari manufatti, che potevano essere scambiati col cuoio, il pellame e ovviamente i prodotti caseari.
La pastorizia può essere considerata un sistema ecosostenibile ma non autosufficiente, a meno che non faccia parte di un villaggio di agricoltori, che si preoccuperà di redistribuire i prodotti caseari. Generalmente però le famiglie degli allevatori considerano le loro mandrie di proprietà privata, tanto che questa si eredita per linea di discendenza maschile (presso i pastori Navajo, nel sud-ovest degli Stati Uniti, per linea femminile, ma si tratta di un'eccezione). Persino il corredo domestico è di pertinenza dei capi-famiglia. Solo le aree di pascolo e le vie della transumanza sono regolate da diritti d'uso, codificati in modo informale da tradizioni orali.
Le società pastorali sono acefale, prive di un'autorità centrale e di una stratificazione sociale. Forse questo spiega il motivo per cui nell'ambito della pastorizia in sé non si sono rilevati importanti valenze democratiche nella gestione del sistema di autosussistenza, almeno non così significative come quelle peculiari al mondo della caccia-raccolta e orticoltura. Tutta l'organizzazione pastorale si basa sulla parentela. Evans-Pritchard scrisse che presso i Nuer i membri di una comune discendenza, dopo aver superato la soglia delle dimensioni compatibili con la disponibilità di risorse, si scindevano in due o più gruppi, restando in contatto per le unioni matrimoniali o per alleanze di tipo difensivo.
I pastori nomadi amano la libertà di movimento e non sopportano gli ordini che provengono dall'esterno del loro gruppo. D'altra parte il migliore allevamento è proprio quello estensivo, su ampi spazi, ove gli animali possono pascolare liberamente. Gli effetti positivi di questa attività stanno nel fatto che gli animali mantengono bassa l'erba, liberano il terreno dai rovi, riducono i rischi d'incendio, inoltre mantengono fertile il suolo con le loro deiezioni. Tutto ciò oggi è possibile solo in pochissimi luoghi del pianeta.
Il nomadismo pastorale, con lo spostamento dell'intero villaggio, oggi è piuttosto raro: lo si trova in alcune aree del Medio Oriente e del Nord Africa. In Iran, p. es., i gruppi etnici di Basseri e Qashqai percorrono 480 chilometri per giungere a 5.400 metri sopra il livello del mare. Molto più praticata è invece la transumanza di pochi individui del villaggio con le loro mandrie durante il periodo estivo. I Ciukci, una popolazione di 16.000 abitanti della tundra siberiana nord-orientale (una regione che spesso arriva a 50 gradi sotto zero), sulla costa fanno i pescatori di trichechi e balene, ma all'interno sono pastori di renne. Le greggi non sono “spinte” ma semplicemente “seguite” e, se si separano, devono farlo anche i pastori, vivendo una vita nomade per gran parte dell'anno. Dopo il crollo dell'Urss la produzione di pellicce, connessa all'allevamento delle renne, non è più contemplata nella nuova realtà capitalistica. Poiché non esistono per i Ciukci altre attività produttive, aumenta sempre di più il numero di coloro che sono costretti a emigrare dai loro villaggi natali verso i centri regionali.
Dall'agricoltura allo schiavismo
Dopo la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento la caccia-raccolta sopravvisse solo nelle foreste o in alcune isole, oppure in territori dove l'agricoltura sarebbe stata impossibile, a meno che i mezzi non fossero molto sofisticati. Praticamente da quando è nata l'agricoltura intensiva (del tutto diversa dall'orticoltura, che non è né intensiva né estensiva) l'uomo ha cominciato a dare risposte sempre più sbagliate alle sue domande, fino al punto in cui si è trovato a costruire delle civiltà basate sull'antagonismo sociale. E ogni volta che cambiava civiltà era convinto, in maniera del tutto ingenua, di aver realizzato un vero progresso, cioè di essersi definitivamente liberato dai problemi delle civiltà precedenti.
Tuttavia la principale tragedia dell'umanità non avvenne con l'introduzione dell'agricoltura in sé o dell'allevamento in sé, ma con l'associazione di tali strategie alimentari alla nascita dello schiavismo, che inizialmente fu di tipo statalistico, in complessi tipicamente urbanizzati. Detto altrimenti, la tragedia non avvenne quando si cominciò a scoprire che da una terra lavorata o da certi animali addomesticati si poteva ottenere del cibo abbondante o comunque supplementare, ma quando questa possibilità fu estremizzata, scelta nettamente in alternativa alla caccia e alla raccolta, che sicuramente erano più ecologiche.
D'altra parte tutte le tragedie avvengono sempre quando si passa da qualcosa di sufficientemente naturale a qualcosa di assolutamente artificiale, che viene giustificato con pretesti ideologici (religiosi o mitologici). Si finisce col creare nuove contraddizioni sociali, le cui conseguenze diventano tanto più gravi quanto più si perfezionano gli strumenti con cui dominare la natura. La storia ha dimostrato che le tragedie avvengono quando, invece di restare olistici, si preferisce diventare settoriali, facendo pagare la propria scelta particolare di vita alla natura e alle società che in quel settore (di regola tecnologico) sono più deboli.
I due sistemi di autosussistenza (caccia-raccolta e agricoltura-allevamento) poterono coesistere pacificamente solo perché il pianeta da esplorare era enorme e gli abitanti molto pochi (nel Paleolitico non superavano i 4 milioni di individui), ma quando, circa 6.000 anni fa, si formarono molteplici sistemi schiavistici in competizione tra loro, la Terra cominciò a farsi stretta (soprattutto dal Nilo al Tigri e all'Eufrate), le guerre diventarono la regola e le foreste cominciarono a essere progressivamente smantellate. È stata la continua riduzione delle foreste (territorio privilegiato per la caccia) a portare i due sistemi di sussistenza in forte competizione tra loro, una competizione che successivamente si è estesa anche tra agricoltura e allevamento, soprattutto quando i cacciatori, più soggetti al nomadismo, si trasformarono in allevatori. Finché l'agricoltura venne praticata nelle zone più impervie del pianeta, non costituiva un particolare pericolo, ma quando si cominciò ad abbattere le foreste e i boschi per far posto ai terreni da coltivare o per le esigenze urbane, si scatenò un meccanismo perverso, che ancora oggi sembra non aver fine.
La vita del cacciatore è stata resa impossibile dal fatto che i regimi schiavistici avevano continuamente bisogno di legname per costruire abitazioni urbane e navi militari o mercantili, o macchine da guerra (p.es. per forgiare le spade si usò il legno prima del carbone), per cui le foreste si ridussero sensibilmente. Non dimentichiamo che, stando a calcoli approssimativi, dopo la nascita dell'agricoltura la popolazione mondiale passò dagli 8-15 milioni ai 50 milioni nel 1000 a.C. e ai 250-300 milioni nel I sec. d.C.
Abbiamo detto che all'origine dell'umanità non esisteva neppure la caccia di animali, ma solo la raccolta di tutto ciò che si poteva trovare di commestibile nelle foreste. Solo uscendo da questi luoghi dal clima mite, ricchi di cibo e finendo in luoghi con un clima torrido o rigido, in ogni caso privo di umidità e scarsamente piovoso, oppure in luoghi paludosi, acquitrinosi, malsani, soggetti alle periodiche esondazioni dei fiumi, avrebbe avuto senso “produrre” il cibo lavorando la terra con strumenti tecnici, costruendo canali irrigui e così via.
La transizione a uno stile di vita stanziale, al di fuori delle foreste, sarebbe stata impossibile, nelle zone più impervie del pianeta, senza l'affermazione dell'agricoltura come fonte primaria di sostentamento. In condizioni normali si praticava la caccia e la raccolta, che generalmente erano itineranti: al massimo ci si affidava all'orticoltura, che non richiedeva l'uso dell'aratro, degli animali da tiro, dei mulini per creare le farine, dei forni per cuocerle e tanto meno di schiavi. È anche molto probabile che prima ancora dell'agricoltura, che richiede tecnologia, competenza, lavori faticosi e ben organizzati, sia sorto l'allevamento di animali di piccole dimensioni, facilmente catturabili e gestibili.
In un certo senso potremmo dire che mentre l'agricoltura è una conseguenza estremizzata dell'orticoltura, l'allevamento è invece una conseguenza estremizzata della caccia (probabilmente in un contesto già caratterizzato dalla presenza dell'agricoltura). In entrambi i casi si tratta di una forma di specializzazione di una pratica preesistente, che però ha comportato nuove metodiche e nuovi stili di vita.
In teoria, se la raccolta è stata anteriore alla caccia, dovremmo dire che l'allevamento sia stato posteriore all'agricoltura, ma non è detto che sia avvenuto così. Forse è meglio dire che agricoltura e allevamento sono state due attività costrette a un reciproco condizionamento (salvo il fatto che l'agricoltura richiede un impegno collettivo a vasto raggio; l'allevamento no). Di sicuro dalla semplice raccolta spontanea di frutti selvatici venne fuori l'orticoltura solamente quando la raccolta, dopo essere usciti dalle foreste, non era più sufficiente per sfamarsi. In ogni caso l'orticoltura non richiedeva un impegno gravoso come quello della lavorazione sistematica e collettiva dei terreni, con l'uso di strumenti specifici. L'orticoltura poteva essere praticata ovunque, anche all'interno delle foreste.
L'agricoltura vera e propria aveva invece bisogno di altri spazi (ai danni delle foreste) e soprattutto di altre motivazioni. Essa è già un tentativo di sottomettere la terra con la forza, in maniera continuativa, superando definitivamente le difficoltà di un ambiente ostico, anzi ostile, dove non è così facile procurarsi il cibo e dove è facile ammalarsi. Senza agricoltura non sarebbe mai nata né la proprietà privata né lo Stato, preposto a difendere tale proprietà.
Una volta usciti dalle foreste si può forse pensare che possa apparire più facile essere allevatori itineranti che agricoltori stanziali, ma entrambe le specializzazioni richiedono una certa competenza, una certa abilità. Non a caso esse costituiscono la prima vera divisione sociale del lavoro. L'allevatore deve essere capace di produrre latte e formaggio: il resto glielo dà l'animale in maniera spontanea (uova, lana..., ma anche, dopo averlo ucciso, corna, pelle, midollo, ossa...).
Tuttavia, là dove la selvaggina è molto abbondante non ha senso fare l'allevatore. Prima dell'arrivo degli europei i nativi nordamericani non furono mai né allevatori né agricoltori, salvo eccezioni, e non vivevano nelle foreste ma nelle praterie, praticando caccia e raccolta. Nei territori stepposi della Russia non era certo una rarità che gli uomini passassero dall'agricoltura all'allevamento, ritenendo quest'ultimo assai più conveniente in quegli immensi spazi dove ci si poteva spostare da un luogo all'altro, senza dar fastidio agli interessi degli agricoltori.
Probabilmente il primo grande conflitto sociale, che diede una svolta all'umanità, non fu quello tra agricoltori e cacciatori ma quello tra agricoltori e allevatori, cioè tra stanzialità e nomadismo, tra necessità di campi chiusi e di campi aperti. Il bestiame ha bisogno di campi liberi, non recintati. Là dove vige l'agricoltura è certamente possibile la domesticazione degli animali, ma l'agricoltore usa animali di piccole dimensioni e, se anche grandi, in numero molto limitato, proprio perché considera l'allevamento un'attività secondaria. Buoi e cavalli possono tornare utili per l'aratro o per i mezzi di trasporto, ma chi pensa di fare l'allevatore di mestiere, lo fa per commerciare i suoi prodotti. Esattamente come chi si dedica all'agricoltura, che è un sistema in grado di offrire un certo surplus alimentare.
Che il metodo di caccia e raccolta sia efficiente è dimostrato dal fatto che, nonostante mezzo millennio di colonialismo occidentale, viene praticato ancora oggi, con tutte le difficoltà dovute al fatto che le multinazionali sono interessate alla deforestazione per vendere legno pregiato e per altri motivi di business immediato.
L'efficienza deve avere un valore non solo tecnico-materiale ma anche etico-sociale; e, da questo punto di vista, è importante non avere un surplus da vendere, poiché è proprio questo che può generare disuguaglianze sociali. (6) Là dove si producono sistematicamente delle eccedenze alimentari è facile che gruppi familiari-parentali-clanici finiscano con l'acquisire maggiore prestigio rispetto ad altri gruppi: basta una diversa forza fisica o strategia lavorativa o una particolare ricchezza del suolo. Non solo, ma quando alcune persone acquisiscono, per qualche ragione contingente, uno status più elevato, mutano le regole della condivisione all'interno del medesimo gruppo. Se l'orticoltura diventa l'anticamera dell'agricoltura intensiva e permanente, è facile la formazione delle città e una progressiva discriminazione sociale. È vero che ci sono volute migliaia di anni prima di passare dal bastone appuntino e dalla zappetta all'aratro, ma una volta compiuta tale transizione, non si è più tornati indietro.
Nondimeno riteniamo sia sbagliato sostenere che la società agricola, basata sui ruoli distinti di sovrani, funzionari, soldati e sacerdoti sia nata in zone dove si potevano coltivare facilmente i cereali. Se davvero vi fosse stata questa facilità, non vi sarebbe stata alcuna stratificazione sociale: non sarebbe stata tollerata. Uomini e donne provenivano da un mondo (quello dei cacciatori-raccoglitori) in cui si era organizzati per piccole bande, prive di capi riconosciuti, di funzionari amministrativi e della figura sociale del soldato: non si aveva motivo di pensare a duri scontri armati. Nell'ambito di una medesima tribù, in un medesimo territorio, non avrebbe potuto esserci un'evoluzione così innovativa senza una certa resistenza sociale.
Le città dovevano per forza formarsi in luoghi impervi e inospitali, quasi spopolati, assai poco praticabili se lasciati a se stessi. In queste città si portò alle sue estreme conseguenze una pratica che già si conosceva, l'orticoltura itinerante, trasformandola in agricoltura stanziale, sistematica, basata prevalentemente sui cereali, al fine di ottenere un surplus significativo. Senza un aratro e senza una sicura irrigazione su canali geometrici, costruiti collettivamente e faticosamente, mantenuti diligentemente, ciò sarebbe stato impossibile.
Quindi possiamo dire che in presenza dell'orticoltura poteva anche esserci l'allevamento di animali domestici, ma non era in forma specializzata. Invece là dove è presente l'agricoltura, di sicuro è presente, in maniera separata, anche l'allevamento specializzato, e i conflitti tra i due sistemi di sussistenza sono inevitabili, come documentano i classici miti di Caino e Abele o di Romolo e Remo. Peraltro l'allevamento del bestiame era un'occupazione maschile, quindi non è da escludere che il patriarcato abbia avuto origini in questo ambiente.
Finché si pratica la raccolta, la caccia, l'orticoltura e l'allevamento di piccoli animali, limitati numericamente, non c'è alcun bisogno di passare all'agricoltura intensiva né all'allevamento specializzato. Cioè non c'è bisogno di arrivare a una situazione in cui si è costretti a vendere dei prodotti per arricchirsi. Il che non significa che i cacciatori e orticoltori, potendo restare liberamente tali, non barattassero i loro prodotti coi pastori. L'importante, per tutti, era affermare il principio che non si doveva dipendere dal mercato per la propria sussistenza.
La nascita dello schiavismo va addebitata all'agricoltura intensiva, che rappresenta una violenza nei confronti della natura; e l'allevamento specializzato, pur essendo itinerante, quindi meno impattante sulla natura, è una conseguenza del fatto che l'agricoltura intensiva, associata a uno sviluppo urbanistico, è in grado di creare un mercato. Chi fa l'allevatore di mestiere è un individualista che ha bisogno di vendere i suoi prodotti, possibilmente per arricchirsi. L'allevatore può anche praticare il baratto con l'agricoltore, ma in genere chi baratta le eccedenze con quest'ultimo è il cacciatore. Semmai l'allevatore ha bisogno di comprare dall'agricoltore il mangime per gli animali. Ecco perché chi pensa di fare solo l'allevatore ha bisogno di un mercato monetario.
I limiti delle società industrializzate
Dal punto di vista economico qualunque sistema antagonistico (schiavismo, servaggio, capitalismo e socialismo), sia in forma privata che statale, rappresenta un abisso rispetto al sistema di autosussistenza del mondo primitivo, soprattutto rispetto a quello basato su caccia e raccolta.
Le differenze sarebbero forti anche se il sistema basato su agricoltura e allevamento non avesse conosciuto la proprietà privata o statale dei mezzi produttivi. Personalmente infatti tendiamo a non credere che la pratica dell'agricoltura e dell'allevamento comporti necessariamente l'introduzione dell'antagonismo sociale nelle relazioni umane, anche se il passo dovette essere breve (storicamente di circa 3-4 mila anni).
L'agricoltura costituisce senza dubbio una violenza quotidiana alla natura. E l'allevamento lo è nei confronti degli animali. L'allevamento priva l'animale della sua libertà sin dalla nascita, trasforma la sua specifica natura, i suoi comportamenti istintivi... Anche la caccia, ovviamente, costituisce una forma di violenza, ma non ha il carattere della sistematicità quotidiana, né l'esigenza di realizzare un surplus produttivo da barattare o da vendere sul mercato. Il cacciatore primitivo non aveva armi con cui potesse portare all'estinzione una determinata specie animale, né aveva conoscenze con cui potesse crearne di nuove. Non selezionava una specie a scapito di altre. Rispettava tutta la diversità biologica che trovava in natura, sapendo bene che, così facendo, garantiva meglio la sopravvivenza alla propria comunità d'appartenenza.
Dunque, sotto questo aspetto una comunità indigena si sarebbe trovata agli antipodi nei confronti di qualunque altra formazione sociale, inclusa quella socialistica, almeno per come questa si è sviluppata a partire dal socialismo utopistico. Un socialismo basato sull'industrializzazione o sulla gestione statalistica della società (come fu quello dell'Europa orientale) o connotato in maniera mercantile (come l'attuale cinese), non ha nulla a che vedere con l'economia autogestionale del mondo primitivo. L'unico comunismo esistito nella storia è quello precedente alla nascita dello schiavismo, che è durato centinaia di migliaia di anni.
Il mondo primitivo ha subìto dei colpi demolitori a partire dallo schiavismo, ma quelli mortali li sta subendo da quando si è sviluppato il capitalismo a livello mondiale. Infatti il capitalismo non stabilisce solo un uso diverso dei mezzi di lavoro tipici delle civiltà schiavili e feudali, ma ne crea di nuovi, infinitamente più potenti, in grado di sconvolgere qualunque equilibrio naturale su tutto il pianeta, in un tempo relativamente breve.
Di fronte all'efficacia devastante di questi mezzi tecnici, neppure il socialismo (utopistico e scientifico, riformistico e rivoluzionario) è stato capace di trovare delle alternative convincenti. Ci si è illusi che bastasse socializzare o statalizzare la proprietà dei mezzi produttivi. Volendo continuare a usare una tecnologia incompatibile con le esigenze riproduttive della natura, l'umanità si è infilata in un vicolo cieco dal quale non riesce a uscire in alcuna maniera. Eppure la cosiddetta “produzione alimentare” è esistita per meno dell'1% del tempo che l'homo sapiens ha trascorso sulla Terra. Prima si era vissuto di sola “acquisizione”, muovendosi liberamente su vasti territori, senza confini imposti da Stati sovrani. La stessa attuale “borghesia” vuole agire su mercati di livello internazionale per incrementare il proprio business, non riconoscendo confini di sorta. Piuttosto è la “piccola borghesia” che chiede il rispetto dei “confini geografici” quando avverte i fenomeni migratori come una minaccia al proprio benessere.
Oggi abbiamo creato degli agglomerati urbani così imponenti, dei mezzi di trasporto così capienti e veloci, delle armi così distruttive, degli strumenti lavorativi così onnipotenti che una qualunque società che ne fosse priva verrebbe guardata con pietà e commiserazione; verrebbe giudicata una pura assurdità se il suo modello fosse prospettato per il futuro.
Ecco perché non può esistere alcuna possibilità d'intesa con le ultime comunità primitive rimaste sul pianeta: o sono loro ad adeguarsi o la loro sorte è segnata. Dovrebbero accadere degli eventi epocali di portata così catastrofica da far pensare a una sorta di “apocalisse”, ma anche in quel caso i sopravvissuti, per ripristinare le condizioni di vita dell'uomo originario, dovrebbero rinunciare consapevolmente alle conoscenze scientifiche che possiedono. E chi mai farebbe una cosa del genere se non costretto da circostanze esterne ed estreme? E quali condizioni potrebbero essere così cogenti, così costrittive da indurre l'uomo a ritenere le proprie conoscenze scientifiche del tutto inutili ai fini della propria sopravvivenza? Lo schiavismo romano fu superato dalle orde barbariche provenienti dall'Asia. Ma l'attuale capitalismo, diffuso su tutto il pianeta, da quali “orde barbariche” potrebbe essere abbattuto?
Le popolazioni che soffrono maggiormente gli effetti del “globalismo” sembra che non abbiano altra intenzione che quella di abitare le città del sistema capitalistico, come se non avessero alcuna alternativa da proporre. Manca l'intelligenza delle cose con cui opporsi a dei processi giudicati irreversibili. L'alternativa non è più “o socialismo o barbarie”, ma “o primitivismo antico o barbarie moderna”. Infatti, anche là dove il socialismo si è realizzato, le tribù primitive sono sempre state penalizzate: non ci sarà stato un genocidio come quello borghese, ma pressioni a cambiare stile di vita sicuramente sì.
Per poter apprezzare il mondo primitivo dovremmo rinunciare alle acquisizioni tecnologiche della moderna rivoluzione scientifica, ma, siccome non siamo disposti a farlo, neppure quando gli effetti deleteri della scienza sulla natura sono sotto gli occhi di tutti, non ci resta che attendere qualcosa di profondamente traumatico, che, con una forza invincibile, costringa l'umanità intera a ripensare se stessa, soprattutto che induca quell'enorme maggioranza di popolazioni colonizzate a ribellarsi a chi le sfrutta da mezzo millennio.
Noi occidentali non siamo più in grado di comprendere, neppure se ci avvalessimo di tutte le scienze teoriche che abbiamo elaborato, il significato di ciò che abbiamo superato da migliaia di anni e che consideriamo irrimediabilmente perduto. Ancora oggi guardiamo con ammirazione, relativamente al nostro passato, le grandi costruzioni degli imperi schiavistici, restando indifferenti alla semplicità della vita nelle foreste. Quando nel vangelo di Matteo 18,1-5 veniva detto che “se non si diventa come bambini, non si può entrare nel regno dei cieli”, si voleva appunto dire che se non si torna a vivere nella semplicità dell'uomo primitivo, la civiltà non ci porterà da nessuna parte.
Essere contro la tecnologia non vuol dire assumere atteggiamenti ideologici o unilaterali. Significa soltanto che bisogna chiedersi quale tipo di tecnologia usare per permettere alla natura di riprodursi agevolmente. Non possiamo usare la tecnologia che ci pare, pensando che, in caso di disastro ambientale, abbiamo sempre la possibilità di trasferirci altrove. L'uomo deve sentirsi responsabile nei confronti della natura là dove fisicamente, territorialmente vive in essa e con essa. Purtroppo però, da quando abbiamo scoperto nuovi continenti, questa responsabilità l'abbiamo perduta. Anzi, ci siamo ancora più convinti che l'enorme estensione del pianeta ci avrebbe autorizzati ad avere nei confronti della natura qualunque atteggiamento arbitrario: di qui p.es. l'enorme inquinamento di tutti i mari.
Ecco perché diciamo che in attesa di un disastro ambientale di rilevanza mondiale, da obbligarci a cambiare stile di vita, dovremmo addestrarci a vivere nella maniera più parsimoniosa possibile, allontanandoci dalle città, recuperando il valore della terra, il contatto diretto con gli animali, aiutando la natura a crescere attorno a noi, contestando radicalmente chi sta portando l'umanità alla catastrofe.
Finché l'agricoltura rimase orticoltura, non si associò allo schiavismo o al servaggio. Là dove esistono istituzioni pubbliche che impongono ai contadini di produrre per una città, di sicuro è presente una discriminazione sociale, uno sfruttamento del lavoro altrui. Se vogliamo, persino l'attività venatoria, essendo condotta prevalentemente dagli uomini, rischiava di creare delle discriminazioni di genere, se le donne non contribuivano attivamente con la raccolta del cibo o appunto con l'orticoltura.
Le donne dei cacciatori dovevano cominciare a pensare a come difendersi dai rischi di una subordinazione sessuale. Infatti, se una donna si aspetta di ricevere il cibo dall'uomo e si limita a cucinarlo, oltre che naturalmente ad allevare figli, è facile ch'essa veda diminuire la propria mobilità e a considerare la vita domestica e la riproduzione sessuale come le uniche vere attività che la distinguono dall'uomo. Quindi, se volevano conservare una certa uguaglianza sociale, le donne dovevano o partecipare in qualche modo alla caccia, oppure procurare il cibo in altra maniera. Non a caso tra i boscimani !Kung San i cacciatori più capaci possono avere più mogli, mentre il diritto di eredità segue, in generale, la linea paterna, benché, per ottenere una moglie, l'uomo debba chiederla alla madre di lei, provvedendo per più di un anno a procurare selvaggina alla sua famiglia.
L'orticoltore (in genere la donna) non utilizza in modo intensivo né la terra, né il lavoro, né gli attrezzi agricoli, e non prevede l'uso di capitali da investire, né quindi una produzione mercantile. Non pratica, in forma associata, i lavori di canalizzazione e irrigazione tipici delle società schiavistiche. Non accumula, in grandi magazzini, il prodotto ottenuto, sia perché l'attività tradizionale per sfamarsi (caccia e raccolta) non viene mai abbandonata, sia perché le comunità dei cacciatori e orticoltori non sono mai molto grandi. Peraltro il sistema di caccia e raccolta, che è il più antico modo conosciuto di procurarsi il cibo e che condividiamo con gli altri primati, non si trasforma necessariamente in orticoltura, poiché questa richiede una certa competenza e conoscenza del territorio.
Le piccole comunità dei cacciatori e raccoglitori erano l'ideale per vivere l'uguaglianza sociale e la democrazia. Questo anche perché non ha alcun senso essere in tanti quando poi non ci si conosce di persona. I rapporti sociali servono per eliminare l'isolamento, la solitudine, le manifestazioni alienanti tipiche dell'individualismo, ma per vivere in un contesto sociale bastano i rapporti di parentela o di associazione. Non c'è bisogno di costruire una grande città, dove pochi comandano e molti obbediscono, e dove i sentimenti di estraneazione e di frustrazione, quando non incanalati in forme di protesta sociale o politica, inducono a compiere azioni umanamente riprovevoli. Un socialismo davvero democratico dovrebbe prevedere la fine degli agglomerati urbani, il superamento della spersonalizzazione, della burocratizzazione dei rapporti umani.
Anche nel caso in cui una città fosse suddivisa in tanti piccoli quartieri, i cui cittadini fossero del tutto indipendenti nel decidere le soluzioni migliori per le esigenze del loro quartiere di appartenenza, resta il fatto che nessun cittadino è in grado di provvedere direttamente alla propria alimentazione. Può farlo tramite specifiche aziende o imprese, relativamente all'abitazione, al vestiario, al rifornimento idrico (con pozzi o dighe), ma la produzione del cibo avviene in un territorio extra-urbano. Il punto di mediazione tra vita rurale e vita urbana è il mercato, ove si acquista quasi qualunque cosa. Anche nel caso in cui un mercato “borghese” non esistesse e i prodotti venissero distribuiti attraverso una serie di magazzini, non si riuscirebbe comunque a risolvere il problema della separazione strutturale tra città e campagna. Anzi, spesso il cibo proviene da luoghi molto distanti dalla città in cui si vive: viene prodotto in maniera artificiale, raccolto ancora immaturo, con poche sostanze nutritive; per conservarlo nel tempo si usano agenti chimici, e i mezzi usati per imballarlo e per trasferirlo nelle grandi città sono nocivi all'ambiente naturale. La città, insomma, dipende dalla campagna, anche se è la città che impone alla campagna la tipologia dei prodotti e i prezzi di mercato.
Un socialismo davvero democratico, molto diverso da quelle parodie e mistificazioni fino ad oggi realizzate, deve prevedere una vita in campagna e con un'agricoltura non intensiva. Qualunque forma di estremizzazione del lavoro porta alla carestia, a improvvise epidemie e pandemie, alla desertificazione, all'antagonismo sociale, alla necessità di vendere prodotti sui mercati, all'impoverimento delle facoltà intellettuali... Le regioni caratterizzate in modo significativo dall'orticoltura si trovano da millenni nell'Africa subsahariana, nell'Asia meridionale e sud-orientale, nel Pacifico, nell'America centro-meridionale e nei Caraibi. Quanto tempo hanno durato le esperienze del socialismo industrializzato e statale? Poche decine di anni!
Per praticare l'orticoltura non serve neppure l'aratro: bastano, come strumenti principali, una zappetta, un semplice bastone appuntito, oltre naturalmente ai cesti per trasportare i semi e le derrate. È solo nel mondo dell'agricoltura vera e propria, quando si riuscirà a produrre oggetti in ferro, che vi sono la vanga, la falce e il falcetto, la roncola, il setaccio, il rastrello, il forcale e tanti altri strumenti resi obsoleti da una incessante modernizzazione industriale, fatta di macchine più o meno automatiche, che producono molto di più in molto meno tempo, grazie anche all'uso di fertilizzanti chimici.
Nell'orticoltura il lavoro manuale non era particolarmente faticoso e per l'irrigazione ci si affidava generalmente alle piogge. Naturalmente il lavoro dell'orticoltore richiedeva più tempo di quello del cacciatore, ma permetteva di ottenere molto di più: mais, fagioli, miglio, sorgo, igname, svariate specie di radici e di tuberi, bacche, meloni, frutta a guscio, miele...
Presso le comunità indigene dedite alla caccia, gli orticoltori non coltivavano i campi in modo permanente, ma li lasciavano a riposo per periodi di tempo di durata variabile. Si tagliava un piccolo appezzamento boschivo o forestale, oppure, più semplicemente, si appiccava il fuoco a un piccolo lotto di terra incolto, eliminando le piante infestanti e i parassiti. Con la cenere ottenuta lo si concimava, dopodiché veniva seminato con cereali, legumi, tuberi, radici, ortaggi, erbe e fiori commestibili, ecc. In genere il terreno veniva usato per uno o due anni, poi veniva abbandonato, lasciando che tornasse allo stato originario. (7) In attesa di poterlo riutilizzare, la comunità si trasferiva altrove, provvedendo a tagliare e bruciare un nuovo terreno. L'infertilità era impossibile. Generalmente come combustibile si usava il legno, che è rinnovabile, se si lascia alla natura il tempo di rigenerarsi.
Non esisteva neppure una vera e propria divisione del lavoro, se non a livelli minimi, quelli stabiliti da fattori oggettivi, come il sesso e l'età. Anzi, presso le popolazioni che abitano le zone temperate l'orticoltura viene praticata indifferentemente da uomini e donne: gli uomini pulivano il terreno col fuoco, ma per la semina e la raccolta erano impegnate anche le donne. Solo la caccia di animali di grandi dimensioni coinvolgeva gli uomini, ma la selvaggina di questo tipo, non molto frequente, forniva una piccola parte della dieta dei cacciatori-raccoglitori nelle zone temperate, a meno che non si vivesse in quelle circumpolari.
Si dice anche che la preparazione del cibo fosse riservata alle donne, ma è anche vero che in alcune tribù gli uomini si prendevano il diritto di coltivare alimenti di prestigio da dedicare a feste o banchetti rituali. Non esisteva una regola comune: al massimo si può pensare che l'unico fattore oggettivo, prevalentemente usato, in condizioni normali, come criterio per l'assegnazione di tutti i compiti fosse l'età. P. es. gli elementi più anziani che restavano nell'accampamento, costruendo strumenti per cacciare e accudendo i bambini, mentre gli altri uomini andavano a caccia.
Al tempo precoloniale, presso gli Irochesi (sei nazioni che dovevano rinnovare di continuo un patto di non belligeranza per poter esistere tranquillamente), erano le donne che coltivavano il granoturco e ne gestivano la distribuzione, e da questo alimento dipendeva se gli uomini potessero andare in guerra o no. In comunità basate sull'autosussistenza è facile che la distribuzione pubblica delle derrate alimentari finisca con l'attribuire alle donne un certo status. D'altra parte erano loro che garantivano la riproduzione del collettivo.
L'orticoltura non era che un'agricoltura itinerante con rotazione integrale dei terreni usati, la cui grandezza media non superava l'ettaro: un misura sufficiente per il sostentamento di una famiglia di 5-8 persone per un anno. Il che non implicava di necessità lo spostamento dell'intero villaggio, che generalmente non andava mai oltre le 200-250 persone. Tra i Kuikuru della foresta tropicale sudamericana un villaggio di 150 abitanti è rimasto nello stesso luogo per 90 anni. Essendo le loro abitazioni piuttosto solide, preferivano raggiungere a piedi le loro coltivazioni (prevalentemente di manioca). Invece coloro che praticavano l'orticoltura sulle colline pedemontane delle Ande peruviane, in micro-villaggi di circa 30 individui, preferivano, nei loro spostamenti, ricostruire in toto le loro piccole e semplici abitazioni. Gli indiani nordamericani, che praticavano solo caccia e raccolta, smontavano le loro tende in pochi minuti, quando si mettevano a seguire i percorsi delle mandrie selvatiche di bufali. Si sono comportati così per migliaia di anni.
Il sistema di caccia-raccolta e orticoltura può durare un tempo indefinito, in quanto ecologicamente sostenibile. In un'isola del gruppo Andamane, North Sentinel, nel Golfo del Bengala (India), un centinaio di Sentinelesi o Andamanesi vivono da più di 55.000 anni in totale isolamento dal resto del mondo. Si crede siano discendenti diretti delle prime popolazioni umane arrivate dall'Africa. Oggi gli ultimi rimasti sono oltre 300.000 e continuano a vivere di caccia, pesca e raccolta. I matrimoni sono combinati dai familiari, poiché si ritiene che questo sia il modo migliore per evitare conflitti sociali, ma praticano anche lo scambio dei doni. La direzione della società è affidata esclusivamente agli anziani.
In queste comunità le esigenze economiche sono minime e minimo è l'impegno lavorativo per soddisfarle. Vi sono società di cacciatori-raccoglitori che dedicano solo cinque ore alla settimana per trovare il cibo e per fabbricare e riparare i loro attrezzi da lavoro. Hanno molto tempo libero da dedicare al racconto di storie, miti e leggende e alla produzione di oggetti artistici. Nel suo libro L'economia nell'età della pietra, M. Sahlins, contraddicendo quanto sosteneva M. J. Herskovits a proposito degli Aborigeni australiani, affermava che i primitivi dedicavano pochissimo tempo al lavoro per procurarsi il cibo, e che non per questo erano miseri. Semplicemente si accontentavano dello stretto necessario, dedicando gran parte del loro tempo alla famiglia, agli svaghi, al riposo, all'arte...
Nei primi anni Sessanta alcuni antropologi si accorsero che la struttura ossea degli Ju/'hoansi, in relazione all'età e allo stato di salute, era molto simile a quella della popolazione nordamericana d'inizio Novecento. Le malattie infettive o le patologie da invecchiamento (come per es. l'artrite) erano poco diffuse; quelle degenerative e mentali del tutto assenti. (8)
D'altra parte è da tempo noto che soltanto con la nascita dell'agricoltura si sviluppano le malattie infettive, e per una serie di ragioni: la densità abitativa è straordinariamente aumentata, per cui qualunque malattia si diffonde molto velocemente e ampiamente; la sedentarietà obbliga a convivere coi propri rifiuti (germi e microbi si diffondono nelle acque); se si fa crescere un'unica specie vegetale, si diffondono più facilmente insetti, funghi e virus; il cibo stoccato nei silos può essere attaccato da topi, insetti e muffe; l'apertura di rotte commerciali finalizzate allo smercio di prodotti agricoli ha favorito il diffondersi delle malattie; molte malattie infettive provengono direttamente dagli animali allevati: vaiolo (cammelli e bovini), tbc (bovini), morbillo (bovini), colera (frutti di mare), pertosse (maiale, cane), lebbra (bufalo indiano), difterite (bovini), influenze e raffreddori di varia natura (cavallo, maiale, anatre). L'influenza pandemica del 1918, che eliminò dal 3 al 5% della popolazione mondiale, derivò probabilmente dalla innaturale vicinanza di anatre e maiali per la macellazione. Non è certamente un caso che gli umani abbiano in comune 65 malattie coi cani, 50 coi bovini, 45 con pecore e capre, 42 coi suini. Degli oltre 1.400 patogeni umani documentati, il 64% è di origine animale.
Dovendo quindi scegliere tra orticoltura e agricoltura, è evidente che sarebbe da preferire la prima. Ancora oggi l'orticoltura è di fondamentale importanza per tutta una serie di coltivazioni: piante medicinali, piante da frutto, ortaggi, piante aromatiche, piante ornamentali, alghe, ecc. Gli orticoltori delle zone tropicali e pluviali coltivano dozzine di specie vegetali simultaneamente. Oggi è del tutto normale vedere l'orticoltura occuparsi anche di conservazione delle specie vegetali, di ristrutturazione paesaggistica, di progettazione e manutenzione di giardini, di ibridazione e creazione varietale, di gestione di collezioni di interesse botanico e cura di orti botanici, ecc.
Tuttavia le cose non sono così semplici come sembrano, a causa soprattutto delle abitudini acquisite nell'arco di migliaia di anni. È ingenuo infatti pensare che si possa tornare indietro come se nulla fosse successo. La transizione a uno stile di vita umano e naturale sarà un processo lungo e faticoso. Al momento sarebbe già molto se avessimo consapevolezza della sua necessità.
Gli svantaggi dell'agricoltura
I primi sistemi agricoli, pienamente documentati, risalgono al Neolitico e si trovano in Medio Oriente. Oggi si trovano ovunque vi sia della terra da coltivare. Sono co-responsabili della desertificazione del pianeta, soprattutto da quando l'uso della chimica ha fatto il suo ingresso in agricoltura, trasformandola in una risorsa meramente commerciale. (9) Molti degli attuali deserti sono stati causati da fiorenti civiltà e non da conseguenze climatiche: il Sahara, p.es., si è formato in 10.000 anni. Ecco perché è insensato fare antropologia senza impegnarsi a favore dell'ecologia.
In Anatolia, nella provincia turca di Konya, si trova uno dei siti più antichi del neolitico, quello di Çatal Hüyük, di 13,5 ettari, sorto accanto a una palude e continuamente ricostruito lungo una sequenza di 18 livelli stratigrafici, che vanno dal 7400 al 5700 a.C. ca. Aveva una popolazione media di circa 6.000 abitanti e durò circa 1.500 anni.
La stranezza di questo villaggio agro-pastorale è l'assenza di aperture verso l'esterno, nonché di porte a livello del terreno. Praticamente le case, di altezze diverse, fatte di mattoni di fango, erano affiancate o addossate l'una all'altra e ci si spostava utilizzando i tetti, dove si trovava l'ingresso principale. La circolazione e gran parte delle attività domestiche avvenivano al livello delle terrazze. Si è pensato che ciò servisse per difendersi dagli animali selvatici e da eventuali incursioni di popolazioni confinanti, ma resta oscuro il livello di conflittualità tra le diverse comunità dell'epoca. L'unica via d'accesso all'intero complesso era fornita da scale che potevano facilmente essere ritirate in caso di pericolo.
Ogni abitazione era divisa in due stanze. Quella più grande aveva al centro un focolare rotondo e delle piattaforme elevate per dormire; in un angolo c'era un forno per cuocere il pane. La stanza più piccola era una dispensa per conservare il cibo: tra una casa e l'altra c'erano dei cortili usati come stalle per capre e pecore. Gli abitanti cacciavano bovini selvatici, ma anche lupi, volpi e leopardi. Coltivavano grano, orzo, piselli... Sapevano filare e tessere la lana. Commerciavano l'ossidiana a lunga distanza. Molto sentito era il culto dei morti.
Non meno interessante è il sito mesopotamico di Çayönü (Turchia meridionale), che si pensa sia stato abitato ininterrottamente all'incirca dall'8250 a.C. al 5000 a.C. Fino al 6000 a. C. la comunità si sosteneva con la “caccia e raccolta”, oltre alla coltivazione di legumi, lenticchie, vecce e farro; poi invece si preferì alla caccia l'allevamento di pecore e capre.
Il villaggio mostra le prime tracce di lavorazione dei metalli, benché resti sconosciuta la fusione. Sono stati ritrovati ben 35 utensili di rame, molti di più che in qualunque altro sito archeologico precedente il 4500 a.C.
Da Çayönü giungono anche le più antiche tracce di tessitura del Vicino Oriente: sono state ritrovate fibre intrecciate di lino. Si usavano anche la malachite, l'ossidiana e le conchiglie marine, a dimostrazione di una certa attività artigianale-mercantile. E si conosceva la ceramica, importata dall'estero. Proprio in questo sito si è accertata una certa discriminazione di ceto dovuta al fatto che nel quartiere nord vivevano, in grandi case, le persone più agiate, mentre quello sud era abitato dal popolo, che abitava case piccole.
La prima cultura urbana d'Europa oggi è definita quella di Cucuteni-Trypillia, del tardo neolitico, che fiorì fra il 5500 a.C. e 2750 a.C. circa nella regione del Dnestr-Dnepr dell'attuale Romania, Moldavia e Ucraina. I Trypiliani costruirono le più grandi città in Europa, ognuna di esse con 10.000 o 15.000 persone. Gli insediamenti venivano bruciati ogni 60-80 anni, quando la cultura si spostava altrove. Qui siamo in presenza di una sorta di “socialismo statale”, antecedente alla formazione dello schiavismo, ma successivo al “comunismo primordiale”. Vi sono chiare tracce di agricoltura, allevamento del bestiame, uso della ceramica, del rame e della religione.
Da parte di alcuni linguisti e di alcuni archeologi (tra cui Otto Schrader, Vere Gordon Childe, Marija Gimbutas) i proto-indoeuropei (nomadi guerrieri di origine caucasica) provengono dalle steppe pontico-caspiche. In particolare la Gimbutas (che unì l'archeologia alla linguistica) arrivò a dire che in Europa si sarebbero fusi elementi di un sistema matriarcale-egualitario con una cultura patriarcale-gerarchica portata dagli indoeuropei nell'età del bronzo, che, per quanto riguarda l'Europa, si estende dal 3500 a.C. al 1200 a.C. circa. (10)
A partire dalla nascita dell'agricoltura gli strumenti produttivi hanno subìto un costante processo di perfezionamento, poiché si è fatta della lavorazione della terra la principale fonte dell'alimentazione, ovviamente senza escludere quella proveniente dagli allevamenti: il tutto sulla base degli scambi monetari sul mercato, che, a partire dal capitalismo, hanno subissato quelli basati sull'autoconsumo e sul baratto delle eccedenze.
La differenza fondamentale dall'orticoltura è che il lotto agricolo è coltivato in maniera permanente, per cui per ottenere ogni anno sufficienti derrate alimentari occorre un aratro che vada in profondità (un tempo trainato da buoi o da cavalli), una costante irrigazione (priva di sali dannosi) e una sicura e abbondante fertilizzazione (un tempo fatta col letame degli stessi animali). Si tratta di una strategia intensiva, che richiede grande impegno lavorativo (soprattutto nella fase iniziale dell'impianto e nella sua manutenzione) e una periodica rotazione delle colture (biennale o triennale) per non compromettere la fertilità del terreno.
Il passaggio dall'orticoltura all'agricoltura non è stato affatto spontaneo, proprio per una questione di mentalità, di stile di vita. Là dove è possibile la raccolta, e poi la caccia, si considera l'orticoltura come un'attività integrativa; questa diventa prevalente solo quando la caccia è poco fruttuosa. L'agricoltura invece è un'attività primaria, conseguente al fatto che l'attività venatoria non è più praticabile come un tempo, e la preoccupazione principale è quella di acquisire delle eccedenze.
Inizialmente, infatti, l'agricoltura si diffonde dove la vita sarebbe stata molto difficoltosa, a causa delle periodiche esondazioni dei fiumi (non a caso le prime civiltà furono “fluviali”). L'agricoltura richiede la costruzione di canali per l'irrigazione artificiale. Se si coltiva in collina, occorre necessariamente il terrazzamento, che è un modo ingegnoso di far scorrere l'acqua sfruttando la forza di gravità. Deve comunque esserci una sorgente o una falda acquifera permanente: al limite è sufficiente l'acqua potabile di un pozzo.
Le famiglie dedite all'agricoltura erano composte di molti elementi. La proprietà della terra poteva appartenere all'intero villaggio, ma col tempo apparterrà ai clan e poi alle singole famiglie patriarcali. La privatizzazione della terra, associata allo sviluppo dello schiavismo o del servaggio (privati o statalizzati), diventerà tanto più importante quanto più si svilupperanno le città-stato, i regni e gli imperi. In ogni caso si trattava di una proprietà che non poteva essere violata dagli allevatori, le cui mandrie avrebbero devastato le colture, né poteva essere una proprietà violata da altri soggetti pubblici o privati. Certo, può essere esistita un'agricoltura che per molto tempo non si sia associata ad alcuna formazione sociale antagonistica, ma è indubbio che tra agricoltura intensiva e schiavismo ad un certo punto s'impone una reciproca influenza.
L'agricoltura intensiva ha una resa produttiva, a lungo termine, per singola area coltivata, superiore a quella dell'orticoltura, e certamente arricchisce di più rispetto al sistema di caccia e raccolta, che non prevede l'uso quotidiano della compravendita. Oggi, per porre rimedio ai disastri dovuti all'introduzione massiccia dei fertilizzanti chimici, avvenuta verso la metà del XX sec. (negli Stati Uniti già negli anni Venti), si sta cercando di adottare dei fertilizzanti organici, che sono un mix di sostanze vegetali, animali e minerali.
Il circolo vizioso che crea l'agricoltura è che, aumentando il surplus disponibile, cresce anche la popolazione, la quale avrà bisogno di sempre maggiori terre da coltivare. A un certo punto s'innesca un meccanismo automatico che risulta essere assai poco controllabile. La popolazione finisce col crescere molto più in fretta delle risorse disponibili. Per soddisfare le sue maggiori esigenze si è costretti a ricorrere a metodiche lavorative sempre più perfezionate, sempre più intensive. Si ottengono rese maggiori, ma a costi imprevisti: fossi, canali e risaie possono diventare focolai di malattie ed epidemie; le foreste vengono abbattute per far posto alle coltivazioni, quindi vi è perdita di diversità alimentare (botanica e faunistica), senza considerare che la deforestazione, rendendo il clima più caldo, mina la regolarità delle piogge, aumenta l'infertilità dei terreni, nonché la velenosità delle falde acquifere e degli stessi prodotti coltivati. Oltre a ciò si creano condizioni tali per cui diventa necessaria una svolta politicamente autoritaria, con cui ci si illude di risolvere tutti questi problemi.
Non è certamente un caso che le prime forme di servitù nascano quando esiste una certa competizione tra clan nel cercare di ottenere un surplus significativo da una difficile coltivazione della terra (i problemi maggiori sono sempre quelli relativi alla gestione delle risorse idriche, alla diversa tipologia dei terreni, al rispetto dei confini). Quando poi ci si convince che per poter beneficiare collettivamente di questo surplus, occorre controllarlo in ambienti indipendenti dalle comunità rurali di villaggio, cioè in ambienti urbani, il gioco è fatto. In condizioni ambientali ostili, dove deve prevalere la coltivazione di poche fondamentali derrate, copiose e sicure, la gestione dei magazzini o dei depositi che le contengono può indurre a credere nella necessità di un potere superiore, con cui assicurare a tutti il minimo vitale ed evitare la carestia. La distribuzione del cibo può diventare occasione per creare discriminazioni sociali, per far nascere ceti privilegiati. Se attorno ai grandi magazzini del surplus si insediano degli operatori preposti non solo all'inventario delle derrate, al calcolo della ripartizione, ma anche alla loro protezione fisica, ecco che la burocrazia viene affiancata da un servizio d'ordine, poliziesco. Se poi si pensa che una parte del surplus può essere venduta per acquistare merci che non si possono produrre per questioni ambientali o climatiche, e che, per questo motivo, danno prestigio a chi le possiede, ecco che si formano i primi elementi per trasformare l'agglomerato urbano, separato fisicamente dalla campagna o comunque dagli agricoltori che la lavorano, in una città-stato, che può anche diventare un regno e perfino un impero.
Lo ripetiamo quindi con convinzione: l'agricoltura in sé non produce schiavismo, ma non può esserci schiavismo senza agricoltura intensiva, che costituisce una forma di violenza sistematica nei confronti della terra, bisognosa di riposo per rigenerarsi. Il principale disastro dell'umanità è stato proprio quello di voler vivere molto al di sopra di ciò che la natura può offrire. Si sono volute creare delle civiltà enormemente dissipative, le quali, per essere tenute in piedi, richiedono enormi risorse naturali e lavorative. Si pensi solo al fatto che le attuali città, anche quelle più piccole, sono dei cantieri edili costantemente aperti: la manutenzione efficiente di ciò che si è costruito è il problema principale di ogni giorno.
Si è passati da un sistema produttivo a un altro, senza rendersi conto che quello agricolo ha la caratteristica d'essere molto più “energivoro” del precedente (senza poi considerare che, di fronte agli imprevisti, come una grandinata, un'invasione d'insetti, una siccità..., l'agricoltura sembra essere molto più fragile di altri sistemi produttivi). La capacità d'essere umani e naturali è andata tanto più scemando quanto più è aumentata la ricerca di fonti produttive con cui rendere l'esistenza più comoda e sicura. E oggi, dopo aver ottenuto effetti opposti a quelli desiderati, siamo arrivati a un punto in cui tornare indietro sembra essere del tutto impossibile, non solo perché non esistono più le condizioni che permettevano tranquillamente la caccia e la raccolta spontanea del cibo, ma anche perché, qualora esistessero, non sapremmo come utilizzarle, avendo totalmente perduto le adeguate competenze.
Oggi, l'unico modo per cercare di uscire da questo meccanismo infernale è quello di consumare il meno possibile, puntando decisamente sulla ricerca di metodiche che favoriscono la progressiva uscita dai mercati, adottando cioè tutte le forme possibili di autoproduzione e autoconsumo. Occorre non solo prevedere un progressivo trasferimento della popolazione dalla città alla campagna, ma anche pianificare una riforestazione del pianeta, eliminando nel più breve tempo possibile tutto ciò che la natura non è in grado di smaltire in un tempo relativamente breve. (11)
Soprattutto bisogna togliersi dalla testa l'idea di poter realizzare tutte queste cose senza prima aver rovesciato i governi che favoriscono i grandi capitali, cioè senza prima aver espropriato tutti coloro che hanno privatizzato la proprietà dei mezzi produttivi per esigenze puramente mercantili. Bisogna anche rinunciare all'idea di poter utilizzare tutta la tecnologia creata dai sistemi antagonistici. Non è assolutamente vero che la tecnologia dipende dall'uso che se ne fa. Quella moderna ha la proprietà specifica di devastare l'ambiente a prescindere da chi e da come la gestisce. Un mezzo di lavoro, per essere ecologico, dev'essere costruito da chi lo usa per la propria sopravvivenza e autoriproduzione.
La concezione primitiva del lavoro
A partire dal 1963 l'antropologo canadese Richard Borshay Lee (12) condusse degli studi su un gruppo di 30 boscimani (!Kung San) che cacciavano nell'arido altopiano del Kalahari. Si era accorto che in due giorni e mezzo di lavoro alla settimana si procuravano una gamma di cibi completa anche rispetto agli standard europei, con un adeguato apporto calorico e proteico, proveniente dalla carne degli animali uccisi e da un vegetale molto presente nella loro alimentazione: la noce di mongongo. Le donne partorivano non più di tre figli (la metà della media africana): non praticavano né l'aborto né l'infanticidio, ma usavano come contraccettivo naturale il prolungamento dell'allattamento al seno.
Tuttavia la loro situazione non era affatto idilliaca. Infatti un altro antropologo, Marshall D. Sahlins, si accorse ch'erano stati costretti a un'economia di sola caccia e raccolta a causa delle pressioni esercitate dai pastori Bantu, con cui mantenevano scambi. Ogni volta che i !Kung San cercavano di insediarsi in zone più fertili o ricche di acqua, ne venivano scacciati, anche dagli agricoltori. Eppure per 20.000 anni non erano vissuti isolati.
Resta il fatto che dedicavano poco tempo a procurarsi il cibo. Forse perché le risorse disponibili erano abbondanti? No, semplicemente perché avevano una concezione del lavoro molto diversa da quella capitalistica, occidentale o asiatica che sia. (13) Nelle società egualitarie la forza-lavoro non viene acquisita tramite denaro o usando la forza, ma si basa su rapporti di parentela o associativa in cui vige l'aiuto reciproco. Non può esserci una divisione del lavoro troppo marcata, né un'attività artigianale troppo specializzata.
Su questo bisognerebbe riflettere parecchio, anche per darsi dei criteri sufficientemente validi ai fini della costruzione del futuro socialismo democratico. In effetti la specializzazione produttiva (che all'inizio, nelle città, era di tipo professionale-artigianale) ha indubbiamente il vantaggio di favorire il commercio, ma toglie la possibilità, anzi, la necessità di saper fare di tutto, che è la regola fondamentale della democrazia economica. Peraltro bisognerà fare molta attenzione al fatto che chi pratica un lavoro specializzato può arricchirsi velocemente e acquisire delle posizioni egemoniche.
Certo, è possibile che uno si specializzi in ciò che gli piace di più. Ma è un errore coltivare esigenze troppo individuali: la mente si ottunde nel proprio settorialismo, perde di elasticità nei confronti dei problemi della vita in generale, si chiude nei confronti del diverso. Tutti devono saper fare tutto: questa la regola fondamentale di un'esistenza normale. Il che non vuol dire che nello stesso momento tutti devono fare le stesse cose, ma solo che, in caso di necessità, si deve poter trovare sempre qualcuno in grado di fare una determinata attività. Questo dà grande sicurezza al collettivo.
L'ideale quindi non è la specializzazione, ma la diversificazione degli apprendimenti. Dovrebbero essere bandite tutte le forme di estremizzazione del lavoro, cioè le mansioni unilaterali, quelle che nella storia del genere umano hanno sempre indicato la presenza di una qualche discriminazione sociale. Occorrerà evitare non solo le specializzazioni particolari, ma anche l'attribuzione unilaterale di lavori monotoni, ripetitivi alle stesse persone o alle stesse categorie di persone. Per ovviare a ciò è sufficiente mettere in atto la turnazione delle responsabilità. Tutto diventa più leggero se la fatica viene equamente distribuita. Occorrerà creare un sistema in cui il lavoro venga vissuto come una forma di soddisfazione personale, in grado di favorire le relazioni sociali, la realizzazione di progetti comuni, l'acquisizione di nuove competenze, la verifica dell'utilità delle competenze apprese...
Il lavoro serve per risolvere problemi, propri o altrui, per soddisfare esigenze personali e collettive: non può essere una condanna imposta dall'esterno, né può avere come finalità l'accumulo di beni e capitali. Lavorare per ottenere un surplus da vendere sul mercato significa condannarsi a una vita da schiavi. Il lavoro non può portare allo sfinimento delle forze fisiche e/o intellettuali, non può indurre la persona a cercare altrove il senso della propria vita, non può essere fonte di stress o di frustrazione, non può indurre a comportamenti alienanti o violenti. E, d'altra parte, tutte queste forme negative dell'esistere non possono essere provocate neppure dalla mancanza di lavoro. Sia che si lavori, sia che non si lavori, nei momenti in cui si fa qualcosa o non la si fa, la vita deve sempre restare “umana e naturale”. Se le esigenze economiche prendono il sopravvento sui rapporti sociali, persino sui rapporti naturali con le cose, sulle proprie esigenze espressive, il risultato è che non si lavora più per vivere, ma si vive per lavorare. Tutto si trasforma. La libertà personale viene sacrificata sull'altare di ciò che viene sbandierato da qualche imbonitore come sicurezza generale, come forza collettiva, in grado d'imporsi su chi non ha adottato gli stessi criteri.
Insomma il senso della vita non può essere dato dal lavoro, come il non-senso della vita non può essere dato dalla mancanza di lavoro. Ciò che occorre è l'esperienza del collettivo in cui si vive. È solo questa esperienza, vissuta in autonomia, che può decidere, collegialmente, quando e come lavorare. Bisogna sottrarre con decisione all'individuo singolo o a un'entità astratta (come p.es. il Mercato o lo Stato), il diritto di decidere per gli altri. Persino nel rapporto genitori/figli i genitori devono sapere che i figli appartengono all'intera comunità, per cui tutti sono tenuti a farli crescere nel migliore dei modi.
Che cosa salvare dell'industrializzazione?
Ci sono state delle conseguenze positive nello sviluppo industriale di epoca moderna? Ovviamente la domanda è retorica, in quanto non ve ne sono state, ma se un antropologo se la pone e comincia a trovare delle risposte affermative – come in genere succede nei manuali scolastici, che vogliono sempre essere politicamente corretti – è inutile poi andare a cercare nella scienza antropologica una contestazione convincente dell'attuale globalismo. A fronte delle comodità e del benessere riscontrabile in tante nazioni del Primo Mondo, sarà impossibile trovare delle motivazioni, se non di tipo moralistico, per sostenere che le comunità indigene meritano d'essere salvate.
Detto altrimenti: un antropologo non dovrebbe avere difficoltà a sostenere che, per quanto riguardo la tutela ambientale, il mondo primitivo era sicuramente migliore di quello moderno. Se invece inizia a dire che oggi la durata della vita media è molto più elevata (il che, detto così, non vuol dire nulla, in quanto va guardata la qualità della vita), o che si produce di più in un tempo minore (come se la qualità della vita potesse dipendere da indici meramente quantitativi), o che esistono i diritti civili e sociali e altre amenità del genere, è evidente che, dovendo scegliere quale sistema buttare giù della torre per perpetuare la specie, non impiegherebbe molto tempo a prendere la sua decisione.
Questo per dire che la storia non va guardata come un processo evoluzionistico, in base al quale ciò che viene dopo, nonostante alcuni evidenti limiti, è sempre migliore di ciò che esisteva prima. È sbagliato pensare che ciò che esisteva prima, se al genere umano fosse piaciuto, sarebbe rimasto inalterato. La storia non funziona secondo parametri deterministici, proprio perché gli esseri umani sono dotati di libertà di coscienza.
Se davvero il capitalismo ritiene d'essere il miglior sistema economico di tutti i tempi, dovrebbe smetterla di usare il criterio dello sfruttamento del lavoro altrui per garantire il benessere economico, poiché, con questo criterio, il benessere viene garantito solo a un'infima minoranza.
Dunque, bisognerebbe limitarsi a dire che la storia è fatta di formazioni sociali all'interno delle quali, mediante un determinato modo di produzione, si è cercato di risolvere un problema di una certa gravità, quello della sopravvivenza, che coi metodi tradizionali appariva ingestibile. Detto questo, bisogna poi verificare, caso per caso, senza fare alcuna generalizzazione, se le soluzioni trovate hanno davvero risolto il problema, o se invece si sono limitate ad affrontarlo usando mezzi e metodi diversi. Se una vera soluzione non vi è stata, per tutti i componenti della società, allora, per correttezza, bisognerebbe dire che una formazione sociale non può essere considerata migliore di un'altra, solo perché è venuta dopo o solo perché, venendo dopo, ha potuto utilizzare mezzi e metodi più moderni.
Il tribunale della storia ci chiederà se effettivamente abbiamo risolto i nostri problemi più gravi, e se l'abbiamo fatto per tutti, nessuno escluso. Quando tutti sono soddisfatti, è impossibile che i mezzi e i metodi siano sbagliati.
Ovviamente gli esseri umani si trovano a vivere in condizioni che non dipendono dalla loro volontà. Tuttavia, siccome non sono animali, dipende dalla loro coscienza se accettarle o no. Che questa coscienza possa essere esercitata, è dimostrato appunto dal fatto che nella storia vi sono stati molteplici modi di vivere l'esistenza. Prima o poi il genere umano, guardando retrospettivamente tutto ciò che avrà fatto nella storia, dovrà poter dire quali sono state le condizioni esistenziali che gli avevano permesso di risolvere con sicurezza i principali problemi della sua vita. Tale sicurezza possiamo anche considerarla “relativa”, poiché la sfida contro le difficoltà della vita appartiene alla psicologia umana; l'importante è che la volontà d'impegnarsi per risolvere i problemi non venga ostacolata da chi pretende di possedere il monopolio dei mezzi produttivi.
Ora, per non apparire troppo astratti con questi discorsi filosofici, diciamo che il principale problema da risolvere per l'essere umano è quello di trovare il modo di sentirsi libero. Sotto questo aspetto non ha alcun senso dire che ci si sente liberi solo perché si vive più a lungo, si produce di più in meno tempo, si possiede la democrazia rappresentativa, una carta costituzionale e altre piacevolezze del genere. Gli esseri umani sono tenuti a popolare l'intero universo, e devono sapere con esattezza a quali condizioni possono farlo, nel rispetto delle loro caratteristiche umane e naturali, in maniera tale che nessuno si senta discriminato per qualche motivo. Tali caratteristiche non sono scritte da nessuna parte. Si scoprono soltanto in un dialogo alla pari, in cui ognuno sia libero di dire quello che pensa.
Qui vorremmo concludere questo lungo capitolo sull'antropologia economica facendo questa semplice osservazione. Oggi, quando si parla di questo settore specifico dell'antropologia, sarebbe bene non tenerla mai separata da nessun discorso di tipo ecologico o ambientalistico. Gli ecologisti, infatti, devono arrivare alla conclusione che non c'è modo di “salvare l'ambiente” se non recuperando gli stili di vita dei primitivi, di cui gli antropologi sono adeguatamente a conoscenza.
Tutto quello che di ecologico viene fatto nell'ambito del capitalismo è, in ultima istanza, soltanto un palliativo. Il problema ecologico ha cominciato a imporsi, alla coscienza collettiva, a partire dagli anni Ottanta, soprattutto con la grande distribuzione organizzata, a livello nazionale, di prodotti in plastica o plastificati. Nel decennio precedente non lo si avvertiva come un problema che sarebbe potuto diventare gravissimo nel giro di così poco tempo, al punto da sfuggire a un vero controllo.
Purtroppo dagli anni Ottanta ad oggi la situazione mondiale non ha fatto che peggiorare. La raccolta differenziata dei rifiuti, il riciclaggio, il compostaggio, il divieto di produrre plastiche “usa e getta”, i pannelli solari, le pale eoliche, la geotermia, l'uso del metano e del gpl e altre soluzioni del genere si sono rivelati soltanto nella loro pochezza: sono una goccia nel mare. La nostra civiltà, fondamentalmente basata sugli idrocarburi, sulla chimica e sui materiali radioattivi, sta letteralmente devastando l'ambiente, compromettendo l'esistenza dello stesso genere umano. Ecco perché un qualunque antropologo, se non è anche un convinto ecologista, favorevole a soluzioni primitiviste, che risolvano il problema alla radice, è meglio che cambi mestiere.
Note
(1) Strano che il volume non sia mai stato tradotto in lingua italiana, poiché, dopo la seconda guerra mondiale, questo padre dell'antropologia afroamericana perorò pubblicamente la causa dell'indipendenza africana dal colonialismo, attaccando i politici statunitensi per la loro visione dell'Africa come oggetto della strategia della guerra fredda. Di lui si trova soltanto Il mito del passato negro (ed. Vallecchi, Firenze 1974), in cui respinge l'idea che gli afroamericani abbiano perso ogni traccia del loro passato quando furono presi dall'Africa e ridotti in schiavitù in America. Ha inoltre precisato il significato del “relativismo culturale”, negando la necessità di un evoluzionismo dai sistemi sociali tribali a quelli occidentali (cfr Man and His Works): in ciò era assai polemico con l'antropologia inglese interessata all'Africa. La sua “Biblioteca Melville J. Herskovits”, fondata nel 1954 nella Northwestern University, è la più grande collezione libraria al mondo specializzata sull'Africa: contiene oltre 260.000 volumi rilegati, tra cui 5.000 libri rari, oltre 3.000 periodici, riviste e giornali, raccolte di archivi e manoscritti, 15.000 libri in 300 lingue africane diverse, ampie raccolte di mappe, poster, video e fotografie. Fu criticato apertamente da Edward Franklin Frazier (1894-1962), il più importante sociologo afroamericano del Novecento, perché secondo lui i neri americani avevano definitivamente perduto le tracce della loro cultura africana. Considerarli culturalmente diversi non faceva che fornire un'ulteriore motivazione alle politiche segregazioniste che si stavano combattendo.
(2) Le coltivazioni di mais, manioca e patate si svilupparono in modo indipendente 3-4.000 anni dopo nelle Americhe.
(3) Durante questa glaciazione i livelli dei mari si abbassarono di oltre 120 metri. Alla fine di questa glaciazione seguì un periodo tardiglaciale, in cui la temperatura e le precipitazioni raggiunsero gradualmente i valori attuali (inizio Olocene 11.700 anni fa).
(4) Nel mondo antico e altomedievale l'aratro era “leggero”, di legno, privo di ruote, trainato da un bue, dotato di una punta in legno che rompeva la terra spostandola di lato, senza però rovesciarla. All'attrezzo in legno si aggiunsero poi sia una pala affilata in ferro, detta vomere, che penetra in profondità e taglia orizzontalmente la zolla di terra; sia una lama perpendicolare al suolo per il taglio verticale della terra, detta coltro. L'aratro leggero tracciava un solco poco profondo ed era adatto all'aratura dei terreni sabbiosi, asciutti e friabili dell'area mediterranea. La rotazione delle colture era biennale. Le terre dell'Europa nordica, dense di radici e sassi quando venivano sottratte alle foreste, umide e pesanti quand'erano sottratte alle paludi, si poterono dissodare solo quando i contadini, a partire dall'XI sec., ebbero un aratro “pesante”, a versoio, per andare in profondità e rovesciare la zolla tagliata dal vomere e dal coltro. Occorrevano da due a otto buoi, oppure si usavano i cavalli ferrati con collare rigido. La rotazione era triennale. Nel Medioevo si diffondono anche i mulini ad acqua e a vento, in sostituzione di quelli azionati da animali o schiavi.
(5) Sulla Mesopotamia sono fondamentali gli studi di Jean Bottéro.
(6) Il che non vuol dire che qualunque tipo di “surplus” sia in sé da evitare: anche nel Paleolitico si sapevano conservare le eccedenze di carne affumicata.
(7) In talune aree densamente popolate di Papua Nuova Guinea il terreno viene coltivato per 2-3 anni, quindi messo a riposo per un periodo di 3-5 anni e infine coltivato nuovamente.
(8) Si è calcolato che nel 30000 a.C. gli esseri umani, al momento della morte, avessero soltanto, in media, 2,2 denti in meno, i quali però era già saliti a 3,5 nel 3500 a.C. e a 6,6 in epoca romana.
(9) Per desertificare non occorre neppure la chimica: basta eliminare gli alberi. Ricordiamo tutti la storia del norvegese Erik il Rosso, che fu esiliato dall'Islanda per aver commesso un omicidio. Costretto a salpare con la sua famiglia e i suoi schiavi, si diresse verso una terra di cui aveva sentito parlare, insediandovisi nel 985: la chiamò Grønland ("Terra verde"), perché piena di foreste. Un po' alla volta arrivarono altri coloni e la popolazione raggiunse il numero di 3-5 mila persone. Oggi l'isola è ricoperta da ghiacci per l'83% del suo territorio. Si è sempre pensato che fosse stata una glaciazione a costringere i Vichinghi ad abbandonare la Groenlandia agli inizi del XV secolo. Invece furono proprio loro a desertificare l'isola. Realizzavano le abitazioni e le navi in legno; inoltre disboscavano per far posto ad allevatori di capre, pecore e mucche e agli agricoltori. Quando, in seguito a questo atteggiamento scriteriato, il clima si irrigidì, se ne andarono tutti. D'altra parte avevano una cultura diversa da quella degli Inuit, i quali erano abituati a vivere nei ghiacci (ancora oggi sono circa il 90% della popolazione).
(10) I testi più importanti della grande studiosa della mitologia, Marija Gimbutas, tradotti in italiano, sono i seguenti: I Baltici, ed. Il Saggiatore, Milano 1967; Le dee e gli dei dell'antica Europa: 6500-3500 a.C.: miti e immagini del culto, ed. Stampa alternativa, Viterbo 2016; La civiltà della dea, ed. Stampa alternativa/Nuovi equilibri, Viterbo 2012-2013; Le dee viventi, ed. Medusa, Milano 2005; Il linguaggio della dea, ed. Venexia, Roma 2008.
(11) In Costa Rica, p.es., il progetto di riforestazione, che si realizzerà entro il 2021, prevede che il paese immetterà nell'atmosfera tanto CO? quanto le sue foreste riusciranno a riassorbire. Già adesso le operazioni si svolgono in zone deforestate e con terreni poco fertili, a causa dell'impatto umano, utilizzate precedentemente per l'agricoltura intensiva (riso in prima istanza) e l'allevamento di bestiame: 200 volontari piantano 3.000 alberi al giorno (le specie sono autoctone). Tuttavia proprio in questo Paese, di cui noi importiamo gli ananas, vi è un'espansione senza controllo delle monocolture estensive e delle fumigazioni con pesticidi in prossimità di centri abitati, scuole e ospedali. Il Costa Rica vanta il record mondiale nel consumo di pesticidi per ettaro (18,2kg/ha). Secondo quanto riporta il Servizio fitosanitario dello Stato, durante il 2017 sono stati importati 18,6 milioni di chilogrammi di principi attivi, una tonnellata in più dell'anno precedente. E non vi sono norme che ne regolamentino l'uso. Peraltro proprio da questo Paese, attraverso le rotte commerciali di Rotterdam, è giunto il parassita detto xylella che, una volta entrato nel Salento (2012-13), sta seccando la stragrande maggioranza degli ulivi.
(12) Curiosamente di questo antropologo non è stato tradotto nulla in italiano.
(13) Gli Yir-Yoront australiani, della penisola di Cape York, non distinguono neppure linguisticamente le parole “lavoro” e “gioco”. Loro distinguono gli esseri umani in due gruppi: ordinari (reali) e ultraterreni (i propri antenati, gli spiriti malvagi e quelli antecedenti al tempo primordiale della Creazione). Per estensione metaforica i bianchi rientrano nella categoria dei “vagabondi” con intento malevolo, cioè non sarebbero esseri “reali” veri e propri.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube