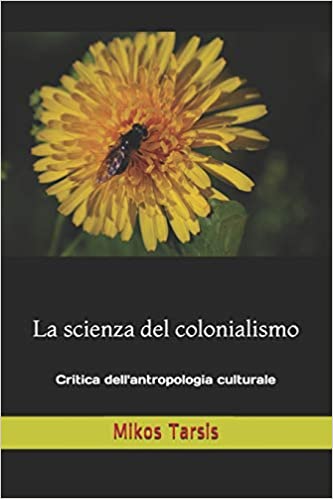
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Quale insegnamento dal mito ebraico della caduta?
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Abbiamo già analizzato il racconto del Genesi relativo al cosiddetto “peccato originale” nel testo La colpa originaria. Analisi della caduta (ed. Amazon). Qui vogliamo riprendere l'argomento perché, leggendo il testo di Enrico Manicardi, Liberi dalla civiltà: spunti per una critica radicale ai fondamenti della civilizzazione: dominio, cultura, paura, economia, tecnologia (ed. Mimesis, Milano 2010), vi sono affermazioni che riteniamo inesatte.
Scrive l'autore: “con l'avvento della deificazione monoteista (la religione giudaica e poi giudaico-cristiana) venne ratificato il principio secondo cui la natura non è della natura ma dell'umanità, alla quale viene consegnata direttamente da Dio” (p. 26).
Per contestare questa affermazione sarebbe sufficiente rimandare al nostro suddetto libro, di cui possiamo ridurre a poche righe la tesi principale. Il racconto della caduta indica la transizione da una vita arboricola, in cui ci si limitava a raccogliere i frutti selvatici della foresta, a una vita venatoria e agricola, al di fuori della foresta. La tentazione, cui si cedette, fu quella di ottenere di più con più facilità. Quindi – siccome il racconto non può essere stato scritto oltre il X sec. a.C. – si può tranquillamente presumere che l'autore sapesse benissimo che tale transizione fosse avvenuta molto tempo prima, di cui nessuno poteva avere memoria. Il serpente stava appunto a significare che al di fuori della foresta s'era già imposta la civiltà schiavistica.
Oltre a ciò possiamo aggiungere altre puntualizzazioni. 1) La cultura ebraica più antica rappresentò il rifiuto dello schiavismo (egizio e babilonese), che trovava nel politeismo la propria legittimazione, e là dove non c'è schiavismo non c'è sfruttamento della natura. 2) Il popolo d'Israele, diviso in dodici tribù, scelse di vivere liberamente, per un certo tempo, nel deserto, piuttosto che stare sottomesso nelle città egizie, facenti parte di un regno assolutistico. 3) Quando, nel XVIII sec. a.C., Abramo lasciò la terra di Ur (Bassa Mesopotamia, dominata dai Sumeri) apparteneva a un'importante tribù di allevatori, guidata dal padre Terah. È quindi probabile che la sua dipartita rappresenti un conflitto tra allevatori e agricoltori, all'interno del quale sono gli agricoltori a considerare la terra come una loro proprietà privata. 4) Rispetto al politeismo dominante all'epoca dell'ebraismo antico, il monoteismo di Mosè, Abramo ecc. appariva in realtà come una forma di “ateismo”, cioè – diremmo oggi – come una forma superiore di consapevolezza dell'identità umana. 5) Nel racconto del Genesi è scritto che i progenitori dovevano semplicemente “custodire” o “gestire” la foresta (il bosco, l'eden), non “dominarla”. Non si parla affatto di “lavoro produttivo” come l'intendiamo oggi. 6) Il rapporto dei progenitori con gli animali è amichevole, di compagnia, non di addomesticamento e di sfruttamento. Adamo “parla” con gli animali, anche se si rende conto che non hanno la proprietà d'essere “umani”; soltanto quando esce dalla foresta, inizia l'attività venatoria.
Qui però vogliamo parlare d'altro, anche perché ci troviamo in un contesto antropologico. Il mito ebraico della caduta ci insegna qualcosa di fondamentale importanza: la differenza tra uomo e natura sta proprio nella libertà di coscienza, che la natura non può possedere, essendo determinata da leggi necessarie e inviolabili. La colpa originaria non è opera di qualche animale: tutti gli animali sono costretti a vivere in maniera istintiva, seguendo la loro natura, salvo adattarsi, per quanto possibile, al mutare degli ambienti esterni. E non può essere neppure considerata un fatto casuale, determinato da eventi imponderabili, essendo invece frutto di una scelta di volontà, non condizionata da fattori esterni. Il motivo per cui sia stata presa una decisione del genere ci resta ignoto. Sappiamo solo che l'uscita dalle foreste ha cambiato completamente l'atteggiamento degli esseri umani nei confronti della natura, che da amichevole è diventato sempre più aggressivo. L'anarco-primitivismo contrappone la figura del cacciatore-raccoglitore a quella dell'agricoltore-allevatore, ma anche il cacciatore ha un atteggiamento aggressivo nei confronti degli animali.
L'uomo non può essere ridotto a “ente di natura” stricto sensu. Non è un animale incapace di produrre “cultura”. Non è vero che la “cultura” è un di più rispetto alla sua essenza naturale, di cui, volendo, potrebbe anche fare a meno. Natura e Cultura s'influenzano a vicenda: ridurre una a vantaggio dell'altra, porta a impoverire entrambe. Non è possibile circoscrivere il comportamento umano a qualcosa di istintuale solo perché, concedendo la libertà di pensare, si corre il rischio di danneggiare la natura. È assurdo pensare che la natura possa dettare all'uomo qualunque tipo di comportamento. L'essere umano conosce un libero arbitrio, una facoltà di scelta, una libertà di decisione che la natura non conosce. Il rapporto uomo-natura non è meccanico, basato su leggi oggettive e adeguamenti automatici, ma è dialettico, come è giusto che sia tra due partner che si devono rispettare nella reciproca diversità. L'influenza reciproca dovrebbe essere paritetica.
Bisogna quindi fare attenzione alla seguente dicotomia, evitando di dare risposte unilaterali: la natura ha un significato in sé, indipendente dalla volontà umana, oppure il suo significato è soltanto quello che le dà l'uomo? Ovvero, se la natura ha un significato indipendente dalla volontà umana, può l'uomo modificarlo? Dalla risposta che si dà a queste domande, si può capire se si dà più importanza alla natura o all'uomo, o se i due soggetti hanno pari importanza.
Ora, che la natura abbia un significato oggettivo, indipendente dalla volontà umana, è determinato dal semplice fatto ch'essa, su questo pianeta, precede, e di molto, la comparsa del genere umano. Al momento sembra più essere l'uomo ad aver bisogno della natura che non il contrario. La natura è il contesto preliminare in cui noi possiamo dare un significato alle cose. È il contenitore dei nostri contenuti: non possono essercene altri su questo pianeta. Probabilmente sarà così anche quando popoleremo l'intero universo: cambierà soltanto la percezione del tempo e forse la tipologia e l'uso dei mezzi, che dovrà adeguarsi a una nuova condizione vitale, meno legata a bisogni di ordine fisico e più a bisogni di ordine energetico.
Non ha alcun senso pensare di popolare l'universo costruendo pianeti del tutto artificiali, in cui la presenza della natura è irrilevante. Noi abbiamo bisogno di pensare che nell'universo, in maniera oggettiva, esiste qualcosa che non dipende da noi, anche se su questa cosa possiamo intervenire attivamente, producendo appunto “cultura”. L'essere umano è un ente di natura che si distingue dall'animale solo per il fatto che è dotato di libertà di coscienza, che è una delle leggi fondamentali dell'universo, quella che appunto lo rende “umano”. L'uomo e la donna sono gli unici “animali” in grado di prendere decisioni che vanno al di là degli istinti.
Dunque, le leggi della natura possono essere modificate? Sì, ma fino a un certo punto. Oltre un limite prefissato le conseguenze ricadono negativamente sulla stessa vita umana. Il vero problema è: come si può stabilire qual è questo limite? È il contesto della natura che lo stabilisce: non esiste un criterio astratto. La natura ha soltanto bisogno di riprodursi agevolmente, di rigenerarsi autonomamente, secondo i propri ritmi e tempi (che coincidono, in generale, con le sue stagioni climatiche). L'uomo ha facoltà di agire all'interno di queste precise esigenze. Può fare tutto ciò che vuole, ma non fino al punto da far perdere alla natura la propria autonomia, la propria identità.
La natura ci è data in forma spontanea, poiché ci precede nel tempo. Possiamo modificarla secondo le nostre esigenze, secondo la nostra coscienza, ma solo in riferimento a ciò che ci è permesso di fare. È proprio la consapevolezza dei limiti che ci garantisce la libertà. Per esempio, sul nostro pianeta, dove l'esistenza umana, salvo pochissime eccezioni, non supera il secolo di vita, non ha alcun senso che l'uomo produca delle cose che vanno oltre la propria esistenza. Siccome tutte le cose sono destinate ad avere una fine, sarebbe bene limitarsi a usare o quelle che la natura mette a disposizione, le quali possono andare anche oltre la nostra esistenza, oppure quelle che non superano il tempo della nostra esistenza.
Noi possiamo usare la pietra delle montagne, l'acqua degli oceani, i frutti e la legna delle foreste, ma non dovremmo creare centrali nucleari la cui durata va ben oltre l'esistenza di chi le crea. Questo perché chi crea qualcosa ha la responsabilità di non lasciare, a chi verrà dopo, dei rifiuti non riciclabili, in tempi ragionevoli, dalla natura. Il tempo necessario perché il 50% degli atomi di un elemento radioattivo si sia disintegrato, è enorme: per il plutonio si parla di oltre 24.000 anni; per l'uranio-238 di circa 4,5 miliardi di anni! Peraltro le centrali nucleari hanno un limite di vita operativa prefissato, al termine del quale devono essere smantellate. Le loro scorie invece saranno indistruttibili. Quando si va in vacanza alloggiando in un albergo, ci viene chiesto di lasciare la stanza così come ci era stata consegnata, salvo pagare un supplemento per la sua pulizia, che verrà fatta in giornata.
Se abbiamo prodotto cose che superano la durata media dell'esistenza di un essere umano, esse andrebbero sepolte con noi, in maniera tale che la natura si incaricherà di riciclarle secondo i suoi tempi. Se pensiamo di poter derogare a questo principio, la desertificazione è assicurata. Noi possiamo lasciare in eredità ai nostri figli talune cose che loro possono continuare a utilizzare, ma devono esser loro a deciderlo, visto che avranno il compito di smaltirle. La trasmissione di oggetti di generazione in generazione ha senso solo se le condizioni di vita e di lavoro restano uguali. Ma questo come può essere deciso a priori?
Per poterlo decidere a priori non dovrebbe esistere alcun progresso tecnologico, almeno non così grande da stravolgere completamente lo stile di vita. Sotto questo aspetto dovremmo porci una domanda fondamentale: qual è la tecnologia che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli? Anche qui la risposta è una sola: è quella che la natura è in grado di riciclare in un tempo ragionevole, tale per cui non venga compromessa la sua necessità riproduttiva. Quindi è solo la decisione comune di un collettivo locale che può decidere quale tecnologia usare in maniera tale che l'ambiente circostante non abbia da soffrire.
Infatti, per prendere una decisione la più possibile oculata, occorre che la comunità viva in un territorio circoscritto, in cui tutti sono responsabili, dai più piccoli ai più anziani. Se la comunità sa che, dopo aver inquinato un ambiente, può tranquillamente trasferirsi in un altro, non potrà mai assumere un atteggiamento responsabile nei confronti della natura. Quindi solo la comunità locale può decidere quale tecnologia usare, e come usarla, in un contesto geograficamente limitato. Tutto quello che va oltre queste esigenze locali o territoriali, va guardato con sospetto.
In via del tutto generale dovremmo dire che l'unica tecnologia che possiamo usare è quella che noi stessi siamo in grado di creare e di riparare quando si danneggia, o di riciclare quando si logora in maniera tale da non essere più riparabile. Questa è la vera scienza.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube