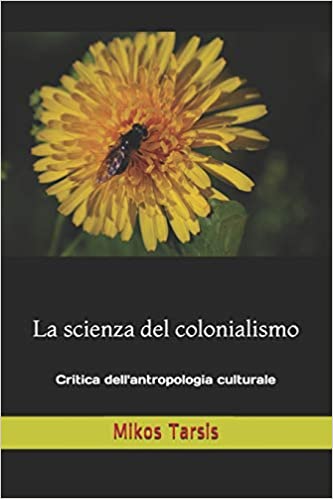
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
L'antropologia italiana
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
L'antropologia italiana è nata nel 1869 con la cattedra universitaria di Antropologia fisica, tenuta a Firenze dal medico fisiologo e neurologo, nonché deputato e senatore sotto il Regno d'Italia, Paolo Mantegazza (1831-1910), che aveva fondato il primo laboratorio di patologia sperimentale in Europa. Cominciò a interessarsi di etno-antropologia in seguito a un viaggio compiuto in Sudamerica, tant'è che nel 1870, sempre a Firenze, fondò il Museo etno-antropologico.
L'anno dopo invece fondò, insieme a Felice Finzi, la prima Società italiana di antropologia ed etnologia, nonché la rivista “Archivio per l'antropologia e l'etnologia”, che affrontò temi riguardanti non solo il Mezzogiorno italiano, ma anche l'Africa orientale colonizzata dai governi nazionali. (1)
Mantegazza fu uno dei primi divulgatori delle teorie evoluzionistiche in Italia: nel periodo 1868-75 era persino in corrispondenza con Darwin. Il suo romanzo, L'anno 3000: sogno (1897), viene considerato uno dei precursori ottocenteschi della fantascienza italiana. Le sue ricerche contribuirono all'affermazione dell'antropologia intesa come “storia naturale dell'uomo”. Dedicò due libri di etno-antropologia all'India, nel 1884 e nel 1886.
Fra il 1870 e il 1890 compì varie spedizioni scientifiche in regioni allora poco conosciute. In Argentina, in Paraguay e in Bolivia è attualmente riconosciuto come un autore classico. Durante la sua permanenza in America Latina venne in contatto con alcune popolazioni che usavano foglie di coca: ciò lo indusse a studiare gli effetti di questa sostanza sia a livello digestivo che nervoso. Il suo interesse scientifico per le droghe lo portò a pubblicare un trattato che a quel tempo fece epoca: Quadri della natura umana. Feste ed ebbrezze.
Un viaggio intorno al globo tra il 1865 e il 1868 e la fondazione della Società Italiana di Antropologia e Etnologia nel 1871 furono i “potenti incentivi” per la passione etnoantropologica anche di un amico e collaboratore di Mantegazza per un quarantennio: Enrico Hillyer Giglioli, che infatti fu il vicedirettore della suddetta Società e assiduo contributore all'Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia. In quanto zoologo di professione fondò invece a Firenze la Collezione Centrale degli Animali Vertebrati Italiani: una straordinaria documentazione della fauna d'Italia, che arriverà ad annoverare quasi 35.000 esemplari appartenenti a 1235 della 1250 specie al tempo note per l’Italia.
L'antropologia fisica o biologica era chiaramente evoluzionistica e positivistica (vi aderì anche Cesare Lombroso), e durante il periodo fascista molti suoi esponenti collaborarono alla stesura del “Manifesto della Razza” (1938), venendo incontro alle richieste dei nazisti che col regime aveva stipulato il Patto d'acciaio.
Il trasferimento della capitale da Firenze a Roma favorì la fondazione in questa città della Società Romana di Antropologia (1893) (2), grazie all'impegno dell'accademico Giuseppe Sergi (1841-1936), che aveva tenuto una cattedra di Antropologia nella Facoltà bolognese di Lettere. La sua fama scientifica è legata soprattutto allo studio dei tipi umani fossili e al grande lavoro di classificazione antropologica, per il quale, fra l'altro, si avvalse di un metodo di valutazione della morfologia del cranio da lui ideato e descritto nell'opera L'uomo, secondo le origini, l'antichità, le variazioni e la distribuzione geografica (1911).
A dir il vero già nel biennio 1875-76 l'accademico di paleoetnologia Luigi Pigorini (1842-1925) aveva fondato con Chierici e Strobel il “Bullettino di Paletnologia Italiana” e il Museo Preistorico Etnografico di Roma, che oggi porta il suo nome e che, formato da due parti distinte: sezione etnografica e sezione preistorica, è entrato a far parte dal 2016 del Museo delle Civiltà, in cui sono confluiti il Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci, il Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari e il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo. Nel 1877 Pigorini ottenne la prima cattedra di Paletnologia dell'Università di Roma, di cui fu titolare per circa 40 anni.
Il distacco della etno-antropologia (che resta impregnata di elementi evoluzionistici) dall'antropologia fisico-biologica avviene nei primi anni del Novecento. L'etnografo, naturalista ed esploratore Lamberto Loria (1855-1913), dopo aver riempito i musei di Roma, Firenze, Genova e Modena con oggetti acquistati in Africa, Asia e Melanesia (solo in Nuova Guinea soggiornò per circa sette anni), cominciò, verso il 1905, a interessarsi di demologia italiana, visitando Circello nel Sannio. Fece suo l'oggetto d'interesse del cattedratico e medico palermitano di Demopsicologia Giuseppe Pitrè (1841-1916), a capo degli studi delle tradizioni popolari (folkloristiche), che lo videro impegnato per 40 anni. (3)
Loria era convinto che le classi subalterne delle società “civili”, per i loro modi di vita e la loro cultura, fossero simili ai “primitivi”, per cui meritavano d'essere studiate. Sicché per un quinquennio egli guidò un'équipe di ricercatori, inviati in tutte le regioni italiane al fine di raccogliere del materiale etnografico, che poi si rivelò così cospicuo da poter realizzare nel 1906 il Museo delle Arti e Tradizioni popolari a Roma. Dopodiché, nel 1910, insieme allo storico Francesco Baldisseroni e all'antropologo fisico Aldobrandino Mochi, allievo di Mantegazza, fondò la Società di Etnografia italiana, e si fece promotore, nel 1911, del primo Congresso di Etnografia, a Roma, all'interno del quale però si consumò la rottura tra gli antropologi fisici (che pretendevano d'essere scientifici come gli studiosi delle scienze naturali) e gli etnologi veri e propri, che si consideravano “umanistici”.
Tuttavia la disgrazia maggiore dell'etnologia italiana non fu affatto determinata da tale rottura, che, anzi, fu un utile chiarimento di posizioni, bensì dall'influenza idealistica della cultura crociano-gentiliana. In particolare Croce poneva i popoli primitivi al di fuori del processo morale e spirituale della storia, per cui, secondo lui, l'etnologia non aveva necessità di svilupparsi, tant'è che la prima cattedra di Etnologia s'impose a Roma solo nel 1967.
Per non pochi anni l'etnologia si è interessata solo di religioni, grazie all'influenza del sacerdote cattolico Wilhelm Schmidt (1868-1954), direttore del Museo Missionario Etnologico, fondato a Roma nel 1927 (oggi è una sezione dei Musei Vaticani). Era un leader della Scuola etnologica viennese: nel 1906 aveva fondato la rivista “Anthropos”, e nel 1931 l'Istituto Anthropos, che esistono ancora oggi. Rifiutava l'evoluzionismo a favore delle tesi diffusionistiche (4), che sfruttò in maniera confessionale, anche con l'appoggio di padre Agostino Gemelli, il quale, quando si istituì la prima cattedra di Etno-antropologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'aveva destinata a mons. Giovanni Guariglia, non prima che si facesse una solida competenza presso la scuola viennese di Schmidt. (5)
Dal 1912 al 1954 Schmidt pubblicò i 12 volumi de L'origine dell'idea di Dio, cercando di sostenere, sulla scia dell'antropologo scozzese Andrew Lang (The Making of Religion, 1898), l'idea che le popolazioni più antiche della Terra (p.es. i Pigmei africani) erano, allo stesso tempo, cacciatori-raccoglitori e monoteisti (Urreligion); e che solo in un secondo momento si sarebbe formata una degenerazione dell'umanità, fautrice di culti magico-sciamanici, animistico-totemici e politeistici, ideati dalle civiltà agricolo-pastorali. Il Vaticano era entusiasta di questa teoria.
Schmidt in realtà non aveva detto nulla di straordinario per i credenti; la novità stava nel fatto che aveva cercato di trovare conferme sul piano antropologico. Infatti, per molti secoli, volendo restare fedeli alla Bibbia, si era voluto credere che l'umanità, alle sue origini, avesse avuto fede in un'unica divinità (grazie a una “rivelazione”) e che solo dopo il peccato originale essa sarebbe involuta verso la credenza in più divinità, salvo poi tornare al monoteismo (Jahvismo ebraico, Cristianesimo, Islamismo), in virtù dell'intervento di soggetti eccezionali, come Mosè, Cristo e Maometto.
Tale concezione però aveva cominciato a entrare in crisi durante l'Illuminismo, per effetto dei primi studi sulle religioni dei cosiddetti “selvaggi”, i quali apparivano più animisti, feticisti e politeisti che monoteisti. La cosa fu confermata dal positivismo e dall'evoluzionismo. Il racconto della Bibbia veniva insomma negato alle radici. Senonché, grazie alla ricerca etnologica, si venne a scoprire, presso popolazioni fortemente primitive, la credenza in un “essere supremo”: fu questo fatto che portò Schmidt a formulare la tesi forzosa dell'Urmonotheismus.
Questa posizione fu vivacemente contestata dallo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni (1883-1959) in una serie di libri di notevole spessore. (6) Egli introdusse per primo nel mondo accademico italiano la disciplina di Storia delle religioni, adottando il “metodo storico-comparativo”. Fu il fondatore della Scuola italiana di Storia delle religioni negli anni Venti e della rivista scientifica “Studi e materiali di storia delle religioni” nel 1925. La sua Scuola di perfezionamento in Scienze Etnologiche era nettamente in polemica con gli allievi di Schmidt, ma rifiutava anche il funzionalismo di Malinowski e di Radcliffe-Brown.
La sua tesi, in sostanza, si riduceva a questo: in tutte le società la presenza dell'essere supremo è contrastata da altre entità spirituali. L'essere supremo è preminente ma non unico ed esclusivo. Schmidt confonde ricerca scientifica e teologia, cioè l'idea di “essere supremo” con quella del “dio monoteistico”. Il monoteismo è una realtà religiosa recente, realizzata come atto polemico nei confronti del politeismo. Anche nel libretto, L'essere supremo nelle religioni primitive, del 1957, conferma questa posizione. L'idea di dio nelle religioni primitive non è un'idea apriori e indipendente dai contesti storici. Esiste solo storicamente e varia a seconda del tipo di società, tant'è che nelle primitive civiltà agricole coincideva con la Madre Terra, la quale nutre gli esseri umani gratuitamente; nelle civiltà pastorali è invece il Padre celeste, poiché dal cielo proviene la pioggia che fa nascere e crescere l'erba necessaria al pascolo degli armenti e alla vita degli esseri umani; nelle civiltà della caccia è il Signore degli animali, poiché da lui dipende le cattura della selvaggina, e così via.
A partire dai suoi studi, verso la metà degli anni Cinquanta, la teoria del monoteismo primordiale venne respinta en bloc negli ambienti accademici non confessionali, costringendo i sostenitori della “Scuola di Vienna” di Schmidt a riformularla parzialmente. Arrivarono infatti a dire che le culture antiche non avrebbero conosciuto un “vero monoteismo”, ma solo una forma di “teismo originale” (Ur-Theismus, contrapposto all'animismo non teistico). Esse avrebbero avuto un concetto di “Dio Supremo” e non tanto di “Dio unico”.
In Italia, fino agli anni Sessanta del XX sec., col termine “antropologia” si è sempre inteso qualcosa di “fisico-scientifico”, mentre gli aspetti più propriamente socio-umanistico-culturali venivano riservati all'etnologia. La denominazione “antropologia culturale”, già presente all'estero, fu importata da un allievo di Pettazzoni, Tullio Tentori (1920-2003), che aveva studiato a Chicago con Robert Redfield. (7)
Nel 1950 Tentori vinse un concorso ministeriale per l'unico posto di etnologo disponibile, e iniziò un progetto di ricerca sulle orme dei lavori di Ernesto De Martino, riguardante la realtà di Matera. Durante tale ricerca iniziò una collaborazione col sociologo austriaco Friederich Friedmann, che lo porterà ad impegnarsi per far rifluire nella realtà accademica italiana l'approccio dell'antropologia culturale di tradizione statunitense. In Italia, fino ad allora, tale settore di studi veniva denominato “etnologia”, seguendo la tradizione di studi francese, ch'era abbastanza autoreferenziale rispetto alle altre scuole dominanti internazionali.
Momento topico di questa battaglia fu il 1º Convegno Italiano di Scienze Sociali a Milano nel 1958, dove, insieme ad altri studiosi, egli presentò il documento Appunti per un memorandum sull'antropologia culturale, in cui delineava l'impianto teorico di una disciplina da inserire negli ordinamenti universitari.
Tra i fondatori del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari (Roma 1955), che diresse fino al 1972, Tentori ricoprì la carica di presidente dell'Associazione italiana per le scienze etno-antropologiche (1989-92). Lo studioso impostò la direzione del Museo verso un avvicinamento alle discipline demo-etnoantropologiche, con attenzione alla ricerca etnografica più che alla semplice catalogazione di oggetti materiali.
Nel 1969 gli venne conferita una delle prime cattedre italiane in Antropologia culturale, con cui sostenne a livello scientifico l'interdisciplinarità, la lotta al pregiudizio, l'incontro fra culture. Tendeva a usare il termine di “antropologia culturale” per interpretare in maniera critica la società contemporanea e non solo per studiare le società primitive. Tra le sue pubblicazioni più interessanti: Antropologia culturale (1960); Il pregiudizio sociale (1962); Appunti di civiltà indigene dell'America (1968); Scritti antropologici (5 voll., 1970-76); Per una storia del bisogno antropologico (1983); Il rischio della certezza. Pregiudizio, potere, cultura (1987). Di carattere autobiografico Il pensiero è come il vento. Storia di un antropologo (postumo, 2004).
Tuttavia non sarebbe potuto venir fuori uno come Tentori sulla base degli studi del solo Pettazzoni. Egli in realtà si situa sulla scia del napoletano Ernesto De Martino (1908-65), che riprende, nel secondo dopoguerra, le felici osservazioni anti-idealistiche di Antonio Gramsci, dedicate al folclore italiano.
Quattro opere fondamentali, una di Gramsci Osservazioni sul folclore (1950), e tre di De Martino, Naturalismo e storicismo nell'etnologia (1941), Il mondo magico (1948) e La terra del rimorso (1961), segnano uno spartiacque fondamentale tra la vecchia e la nuova etnologia e aprono la strada a una antropologia culturale vera e propria. Per la prima volta si arriva a dire che i popoli colonizzati e le classi subalterne non sono “cose” da analizzare in maniera “naturalistica”; la stessa magia non è un errore concettuale dei primitivi, come volevano Croce e gli evoluzionisti, ma un'espressione dello spirito umano, utilizzato anche contro chi vuol far scomparire la cultura primitiva. Il folclore popolare va visto in antagonismo alla cultura borghese dominante.
I riti popolari aiutano l'uomo a sopportare una sorta di “crisi della presenza” che si avverte nei confronti del “nuovo” che avanza. I comportamenti stereotipati dei riti offrono rassicuranti modelli da seguire, non sono frutto di ignoranza. Il concetto di “spaesamento” risulta strettamente connesso a riti religiosi proprio perché non si sa in quale altro modo affrontare i rischi della vita. Astraendo dalla storia reale in cui agisce il negativo, mito, rito e simbolo diventano un circuito in cui i protagonisti pensano di poter risolvere le loro frustrazioni.
De Martino fu collaboratore di Raffaele Pettazzoni all'Università “La Sapienza” di Roma, nell'ambito della Scuola romana di Storia delle religioni. Come ordinario di Storia delle religioni e di Etnologia, dal 1957 fino alla morte insegnò all'Università di Cagliari, dove ebbe uno stuolo di allievi di grande importanza nelle discipline etno-antropologiche. (8)
Una delle prime cattedre nazionali di Antropologia culturale fu istituita a Bologna nel 1970, alla facoltà di Scienze politiche, tenuta dal docente Bernardo Bernardi (1916-2007), ove rimase sino al 1982; poi egli passò dal 1982 al 1992 a insegnare Etnologia all'Università La Sapienza di Roma. Bernardi aveva studiato con l'antropologo sociale Isaac Schapera a Capetown. Con lui l'antropologia culturale e la demologia si fusero, e si cominciò a rifiutare l'immagine dell'antropologo come mero osservatore obiettivo, in quanto si riteneva impossibile prescindere dal proprio background culturale. L'antropologia culturale diventava una sorta di critica di se stessa.
Gli studi di Bernardi si focalizzano sull'Africa Subsahariana, attraverso ricerche sul campo in Zimbabwe, Kenya ed Etiopia, e soggiorni di studio in numerosi paesi dell'Africa. In particolare gli interessavano le strutture sociali e religiose dei Zesuru e dei Meru. (9)
Agli inizi degli anni Ottanta sul lavoro di De Martino s'innestano lo strutturalismo francese, la semiotica, l'antropologia interpretativa e post-moderna. Oggi, in Italia, col termine “antropologia” s'intendono le “Discipline demo-etno-antropologiche”, secondo la formulazione data da un grande cultore di Lévi-Strauss, il socialista Alberto Cirese (1921-2011), il quale voleva far capire che per una nazione priva di colonie come l'Italia e totalmente estranea al concetto germanico di “stirpe”, sarebbe stato opportuno interessarsi delle tante culture popolari pre-unitarie, molto più importanti delle società indigene extra-europee, che venivano riservate all'etnologia vera e propria. Il primo Congresso dell'Antropologia culturale delle Società complesse è stato tenuto nel 1987.
Cirese studiò presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Roma e con R. Pettazzoni alla Scuola di perfezionamento in Scienze etnologiche, e svolse attività di assistente volontario presso la cattedra di Etnologia (1953-1957), collaborando anche con Ernesto de Martino. La carriera accademica si avviò con l'abilitazione alla libera docenza in Letteratura delle tradizioni popolari, ottenuta nel 1956. A partire dall'anno successivo fu chiamato alla cattedra di Storia delle tradizioni popolari all'Università di Cagliari, ove rimarrà fino al 1972, insegnandovi anche Antropologia culturale e guidando, con Ernesto de Martino e Clara Gallini (1931-2017), l'importante Scuola antropologica di Cagliari. Tra il 1968 e il 1972 coordina il lavoro di quaranta ricercatori che, per conto della Discoteca di Stato, effettuano la prima rilevazione di “tradizioni orali non cantate” (fiabe, leggende, aneddoti, indovinelli, proverbi, ecc.) che documenta tutto il territorio italiano. Dopo Cagliari, Cirese passa a insegnare Antropologia culturale prima a Siena, dal 1972 al 1974, e poi a Roma, dal 1973 al 1991. A Roma è anche il primo coordinatore del dottorato in Scienze etnoantropologiche, istituito nel 1988. (10)
Tuttavia oggi l'antropologia italiana (11) non studia più le società contadino-pastorali, ma le realtà urbanizzate, con tutti i loro problemi: flussi migratori, multiculturalismo, etnicità e identità locali, forme di marginalizzazione, ecc. Sembra non avere un approccio olistico, ma settoriale, specifico, come quello di Boas e di Malinowski. Prevale la tendenza a considerare limitata tanto la scienza quanto la non-scienza, per cui il miglior approccio scientifico è quello di non avere pretese di obiettività. (12)
Differenze tra evoluzionismo e diffusionismo
In campo antropologico l'evoluzionismo classico era di matrice positivistica, in quanto sosteneva che ogni società (in autonomia o perché “aiutata” da quelle più avanzate) deve attraversare gli stessi stadi evolutivi di quella occidentale (giudicata la più sviluppata), in quanto esiste una unità psichica del genere umano. Sicché si può prevedere una classificazione delle società sulla base del grado di evoluzione raggiunto: selvaggio, barbarico e civile. Lungo un percorso evolutivo unico, uguale per tutti, esistono dei gruppi umani più arretrati, che tuttavia si svilupperanno col tempo, essendo anch'essi in grado di creare innovazioni (ipotesi poligenetica). Si tratta soltanto di avere pazienza e di favorirli col colonialismo. Tuttavia negli anni Quaranta-Cinquanta, dopo il disastro della II guerra mondiale, il neoevoluzionismo arrivò ad ammettere delle linee di sviluppo multiple e parallele, lungo le quali ogni società passerebbe attraverso vari stadi di complessità, senza dover per forza seguire un percorso unico, quello occidentale.
Il diffusionismo invece è una teoria antropologica sorta alla fine del XIX sec. e affermatasi nei primi decenni del successivo sulla base della “teoria delle migrazioni”, ideata del geografo tedesco Friedrich Ratzel (1884-1904), il quale, non credendo nell'unità psichica del genere umano, predicata dagli evoluzionisti, pensava la cultura in termini di migrazioni e conquiste (quindi da un centro a più periferie). La cultura si afferma attraverso conflitti in cui i popoli culturalmente più avanzati conquistano quelli più deboli e impongono la loro cultura, salvo essere soppiantati da altri popoli con culture ancora più forti. Quindi aspetti culturali simili si ritrovavano in zone diverse del pianeta semplicemente perché, partiti da alcune aree specifiche (p.es. l'Egitto dei faraoni), si sono poi propagati geograficamente, attraverso commerci, conflitti bellici o migrazioni dei popoli. Ad esempio la cultura dell'arco con le frecce soppianta quella della lancia. Questo perché le grandi invenzioni vengono fatte una sola volta e poi si diffondono attraverso le migrazioni o per imitazione. Solo alcune società sono in grado di produrre cultura: le altre si limitano a riceverla dall'esterno.
Sia gli evoluzionisti che i diffusionisti non mettevano in discussione che l'Europa occidentale fosse la culla della civiltà più avanzata.
Note
(1) Sull'Etiopia vedi le opere di Vinigi Grottarelli (1912-92).
(2) Ora si chiama Istituto Italiano di Antropologia.
(3) Fondatore e condirettore dell'“Archivio per lo studio delle tradizioni popolari” (33 volumi, 1880-1906), Pitrè compilò la prima esauriente bibliografia del folklore italiano, Bibliografia delle tradizioni popolari d'Italia (1894), che conteneva oltre 6.000 voci. Curò anche la pubblicazione delle Curiosità popolari tradizionali in 16 volumi (1885-1899). La sua opera più monumentale resta comunque la Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane (1872-1913), una raccolta del folklore siciliano in 25 volumi con varie sezioni dedicate ai canti popolari, ai racconti, ai proverbi, alle leggende, ai giochi, ai costumi, ecc., tutto riportato fedelmente in dialetto. La ricchezza delle raccolte di Pitrè resta ineguagliata: il volume dedicato ai giochi infantili, ad es., ne descrive più di trecento, per ognuno dei quali sono registrate le varianti sia siciliane che italiane. Con lui nasce il termine “demologia”. Lo studioso di folklore, E. Tang Kristensen (1843-1929), originario dello Jütland, fu non meno prolifico del Pitrè: infatti pubblicò più di 30.000 pagine di materiale (circa 79 volumi) comprendente 3.000 canti popolari, 1.000 melodie, 2.700 racconti popolari e 25.000 storie e leggende.
(4) Alla fine di questo capitolo viene spiegata la differenza tra evoluzionisti e diffusionisti.
(5) A dir il vero la passione principale di Schmidt era la linguistica. I suoi primi lavori furono dedicati alle lingue Mon-Khmer del sud-est asiatico, nonché alle lingue dell'Oceania e dell'Australia. Nel 1906 arrivò a ipotizzare l'esistenza della superfamiglia linguistica delle Lingue austriche, che riunirebbe i gruppi linguistici austronesiano e austroasiatico. Schmidt riuscì a dimostrare che le lingue Mon-Khmer hanno collegamenti interni con altre lingue dei mari del sud. Tuttavia la sua scoperta non fu accettata dalla maggioranza degli etno-linguistici.
(6) Le opere di Pettazzoni sono sterminate; tra le più recenti ristampate si possono segnalare le seguenti: La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell'Iran, ed. La vita felice, Milano 2015; Saggi di storia delle religioni e di mitologia, ed. Loffredo University Press, Napoli 2013; L'uomo e il suo destino: miti e leggende, ed. UTET, Torino 1990; Il regno dell'uomo: miti e leggende, ed. UTET, Torino 1990; In principio: i miti delle origini, ed. UTET, Torino 1990; Storia delle religioni e mitologia, ed. Mimesis, Milano-Udine 2018; Monoteismo e politeismo: saggi di storia delle religioni, ed. Medusa, Milano 2005; Quando le cose erano vive: miti della natura, ed. UTET, Torino 1991; Tra dei e demoni: miti e leggende, ed. UTET, Torino 1990; Dal caos al cosmo: miti astrali, ed. UTET, Torino 1991; I misteri: saggio di una teoria storico-religiosa, ed. Lionello Giordano, Cosenza 1997. Del tutto trascurate invece le tante opere dedicate al tema della “confessione dei peccati” (cfr quella edita da Forni, Bologna 1970).
(7) Tentori si era laureato nel 1942 con una tesi sulla Religione degli Indiani della California. Il culto di Kuksu diffuso fra le tribù Pomo, Wintu, Maidu, Waffa.
(8) Le opere di De Martino sono molteplici e tutte di un certo spessore culturale. In particolare si segnalano Naturalismo e storicismo nell'etnologia, ed. nuova presso Argo, 1997 Lecce; Il mondo magico: prolegomeni a una storia del magismo, ed. nuova presso Boringhieri, 1973 Torino; Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, ed. nuova Bollati Boringhieri, 2000 Torino; Sud e magia, ed. Feltrinelli, 2002 Milano; La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, 1961 Milano; Furore, simbolo, valore, ed. Feltrinelli, 2002 Milano; Magia e civiltà. Un'antologia critica fondamentale per lo studio del concetto di magia nella civiltà occidentale, ed. Garzanti, 1962 Milano; La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali, ed. Einaudi, 2002 Torino; Scritti minori su religione, marxismo e psicoanalisi, Nuove edizioni romane, 1993 Roma; Storia e metastoria: i fondamenti di una teoria del sacro, ed. Argo, 1995 Lecce; Scritti filosofici, ed. Il Mulino, 2005 Bologna. Cfr anche G. Chiariglione, Il discepolato di Ernesto De Martino, Editrice Petite Plaisance, Pistoia 2019.
(9) Tra i suoi scritti si segnalano Le religioni dei primitivi, Istituto Editoriale Galileo, 1953 Milano; Etnologia e antropologia culturale, ed. Franco Angeli, Milano 1973; Uomo, cultura, società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, ed. Franco Angeli, Milano 2002; Africa meridionale, ed. De Agostini, Milano 1977; I sistemi delle classi d'età. Ordinamenti sociali e politici fondati sull'età, ed. Loescher, Torino 1984; Introduzione allo studio della religione, ed. UTET, Torino 1992; Africa. Tradizione e modernità, ed. Carocci, Roma 1998; Nel nome d'Africa, ed. Franco Angeli, Milano 2001; Africanistica. Le culture orali dell'Africa, ed. Franco Angeli, Milano 2006; Uomo, cultura, società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, ed. Franco Angeli, Milano 2011. Ha collaborato al vol, 5: Religioni dell'America precolombiana e dei popoli indigeni, ed. Laterza, Roma-Bari 1997.
(10) Gli studi di Cirese, in genere, sono molto specifici; tra quelli, a carattere generale, si possono segnalare Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale. ed. Palumbo, 1973 Palermo; Intellettuali, folklore, istinto di classe. Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, ed. Einaudi, 1976 Torino; Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, ed. Einaudi, 1977 Torino; Segnicità fabrilità procreazione. Appunti etnoantropologici, ed. C.I.S.U., 1984 Roma; Dislivelli di cultura e altri discorsi inattuali, ed. Meltemi Editore, 1997 Roma; Il dire e il fare nelle opere dell'uomo, ed. Bibliotheca, 1998 Gaeta; Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e identità locali, ed. Protagon, 2003 Siena. Su di lui cfr Insegnamenti di Alberto Mario Cirese (a cura di P. Clemente e E. Testa), ed. CISU, Roma 2002; Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese (a cura di E. Testa), ed. Olschki, Firenze 2011.
(11) Cfr l'Associazione italiana per le Scienze etno-antropologiche, fondata nel 1991; la Società italiana di Antropologia medica, fondata nel 1998; la Società italiana per la Museografia e i beni demoetnoantropologici, fondata nel 2001; l'Associazione Nazionale Universitaria degli antropologi culturali, fondata nel 2006.
(12) I maggiori studiosi contemporanei sono i seguenti: Alberto M. Cirese, Vittorio Lanternari, Luigi M. Lombardi Satriani, Tullio Tentori, Bernardo Bernardi, Carlo T. Altan, Clara Gallini, Pietro Clemente, Francesco Remotti, Ugo Fabietti, Antonio L. Palmisano (numerosi sono gli specialisti del comitato scientifico della rivista “Dada” di antropologia post-globale curata da quest'ultimo: dadarivista.com). Indispensabile la lettura di E. V. Alliegro, Antropologia italiana: storia e storiografia 1869-1975, ed. SEID, Firenze 2011.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube