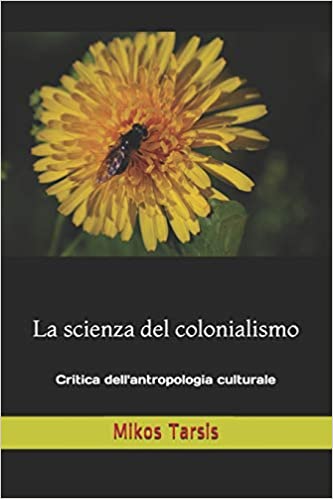
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
L'antropologia strutturale di Lévi-Strauss
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Limitatamente a un discorso introduttivo sul ruolo colonialistico dell'antropologia borghese, occorre spendere due parole anche sulla corrente strutturalistica di Claude Lévi-Strauss, non perché oggi risulti essere un “classico”, quanto perché, nell'arco della lunga vita di questo ricercatore, che ha avuto esperienze dirette del mondo primitivo, la sua opera è diventata monumentale.
Ormai è assodato che tutte le sue analisi poggiano su varie fonti: la linguistica strutturale di Roman Jakobson (che ha mostrato, fra le altre cose, come i costituenti di base del linguaggio umano sono appaiati in gruppi di due: sonori/sordi, gravi/acuti ecc.), la cibernetica di John von Neumann e l'algebra di George Boole (quest'ultimo perché cercava una prova scientifica della cosiddetta “unità psichica universale”), la semiologia saussuriana (che poneva una complementarità tra significante e significato e definiva l'unità minima del suono linguistico, non ulteriormente scomponibile), e la tradizione sociologica di Émile Durkheim (laddove soprattutto questi parla di “rappresentazioni psichiche collettive”, di “indagine empirica” della realtà da esaminare, di stretta correlazione tra fatti sociali, di approccio il più possibile distaccato da parte dell'osservatore, onde evitare l'interferenza dei suoi preconcetti). Il suo modello di antropologo sul campo era quello di Franz Boas.
A partire dalle considerazioni di M. Mauss sul dono egli sviluppa una teoria generale della comunicazione basata su tre piani: scambio delle donne tra i gruppi (relazioni parentali, esogamia), comunicazione dei messaggi linguistici (mitico-totemici), scambio di beni e servizi (economia). Il suo saggio sulle Strutture elementari della parentela (1949) lo portò improvvisamente alla ribalta. Egli identifica nella proibizione dell'incesto e nell'esogamia (matrimonio con individui esterni alla propria famiglia) le costanti universali che segnano il passaggio dal puro stato di natura a una società umana organizzata che si relaziona con l'esterno, con l'altro da sé. La proibizione dell'incesto è dunque il passo fondamentale grazie al quale, per il quale, e soprattutto nel quale, si compie il passaggio dalla natura alla cultura. In un certo senso essa appartiene alla natura, giacché costituisce una condizione generale della cultura (di qui il suo carattere di universalità). Ma in un altro senso essa è già cultura che agisce e impone la propria regola in seno a fenomeni di tipo naturale, indipendenti dalla cultura.
Quando poi scrive Antropologia strutturale (1958), dicendo che l'antropologia occupava un campo della semiologia che la linguistica non aveva rivendicato come proprio, gli si aprirono le porte della carriera accademica. Testualmente scrisse: “la fonologia passa dallo studio dei fenomeni linguistici coscienti a quello della loro infrastruttura inconscia; rifiuta di considerare i termini come entità indipendenti, prendendo invece come base dell'analisi le relazioni tra i termini; introduce la nozione di sistema; infine, mira alla scoperta di leggi generali, sia trovate per induzione, sia dedotte logicamente, il che conferisce loro un carattere assoluto”.
Sempre in quest'ultima opera precisa, con una chiarezza cristallina: “Come i fonemi, i termini di parentela sono elementi di significato; anch'essi acquistano tale significato solo a condizione di integrarsi in sistemi; i sistemi di parentela, come i sistemi fonologici, sono elaborati dall'intelletto allo stadio del pensiero inconscio; infine la ricorrenza, in regioni del mondo tra loro lontane e in società profondamente differenti, di forme di parentela, regole di matrimonio, atteggiamenti ugualmente prescritti tra certi tipi di parenti, ecc., induce a credere che, in entrambi i casi, i fenomeni osservabili risultino dal gioco di leggi generali ma nascoste”. Cioè in pratica le strutture della parentela assomigliano a quelle linguistiche, in quanto non rappresentano qualcosa di cui si è consci e in cui esiste una possibilità di scelta.
Il metodo dello strutturalismo (1) è applicato anche all'analisi del totemismo (Totemismo oggi e Il pensiero selvaggio sono del 1962), lasciando capire chiaramente che nell'essere umano vi sono strutture di pensiero che sfuggono allo scorrere del tempo e alla diversità degli ambienti, per cui chiamare “primitivo”, in senso sprezzante, il pensiero degli indigeni non ha senso. Il pensiero selvaggio non è il pensiero dei selvaggi, bensì un pensiero non ancora “addomesticato”. Si rifà addirittura a Michel de Montaigne (2), a J. J. Rousseau (3) e a H. Bergson per sostenere questa tesi. Gli indigeni hanno semplicemente un pensiero “concreto”, “sensibile”, che nell'uomo occidentale è stato subissato da quello logico-razionale. Sono due modi diversi di vedere la realtà, ma non si possono mettere delle gerarchie di valore, come facevano p.es. J. G. Frazer o L. Lévy-Bruhl.
Secondo Lévi-Strauss il linguaggio, nella sua essenza, nella sua capacità d'essere simbolico-evocativo, nella sua logica di fondo, non può aver subìto alcuna vera evoluzione, ma deve essere venuto alla luce tutto in una volta. Semmai è stata la conoscenza a mettersi in moto lentamente. Gli animali sono enti di natura privi di cultura. Non possono sapere che l'universo è “significativo”. (4) L'essere umano è l'intelligenza delle cose, ma queste sono già intelligenti per conto loro, indipendentemente dalla volontà o dalla percezione umana. Tutto ciò l'animale può solo viverlo in maniera istintiva, senza possibilità di violare alcuna legge, come invece può fare l'essere umano a proprio rischio e pericolo. Il quale però è l'unico essere in grado di decifrare l'essenza della natura.
In tal senso i primitivi hanno lo stesso pensiero logico dei moderni, proprio perché la capacità d'essere razionali appartiene all'essere umano in quanto tale. Essi non stanno in via di mezzo tra natura e civiltà o tra animali e umani. Non sono esseri pre-civilizzati o pre-logici. Semplicemente vivono una forma di civiltà diversa da quella moderna.
Tuttavia, a partire da questo momento, invece di arrivare a dire che i moderni sono i veri “barbari”, almeno da quando hanno originato formazioni sociali antagonistiche, invece di dire che la logica occidentale basata sul sillogismo è del tutto formale e astratta (5), invece di approfondire storicamente il mondo primitivo, al fine di capire quanto il loro stile di vita dipenda davvero da strutture mentali predefinite o anche da condizionamenti sociali (dovuti p.es. al colonialismo europeo), Lévi-Strauss inizia a dedicarsi allo studio della mitologia primitiva, nella speranza di poter approfondire l'idea di “strutture psichiche e mentali inconsce”, strutturalmente predefinite. Un tema, questo, che sul versante psichico si ritrova in Freud (6) e Jung, mentre su quello cognitivo è tipico della prima Critica kantiana.
Il presupposto da cui parte è del tutto formale, checché lui stesso abbia più volte affermato che lo strutturalismo non era un formalismo (7): ogni esperienza è caratterizzata da una struttura logica, condizione della sua conoscibilità, anche se questa si forma in maniera per lo più inconscia. Tale struttura è formata da coppie di opposti che interagiscono tra loro, creando un equilibrio. L'opposizione binaria è rappresentabile algebricamente e, nella sua struttura, resta invariabile nel tempo e nello spazio.
Gli studi sul mito sono enormi: i quattro volumi di Mitologica I (Il crudo e il cotto, 1964), II (Dal miele alle ceneri, 1966), III (L'origine delle buone maniere a tavola, 1968) e IV (L'uomo nudo, 1971), detti “grandi Mitologiche”, cui seguiranno altri tre volumi, detti “piccole Mitologiche” (1976, 1985, 1991), rappresentano la più grande valorizzazione, mai tentata prima, del patrimonio culturale delle piccole e minacciate società di cacciatori e raccoglitori dell'Amazzonia. Prima di questi lavori non veniva riconosciuta ai miti primitivi una struttura logica; anzi, venendo giudicati per lo più incomprensibili, a causa delle loro astruserie, generalmente venivano trascurati dagli antropologi. (8)
Lévi-Strauss fa capire chiaramente che l'analisi del mito può procedere come quella del linguaggio, nel senso che le unità semantiche separate a base ricorrente (mitemi) acquistano una super-significazione solo quando vengono combinate alla fine dell'analisi. Ciò che più importa è capire le regole di trasformazione e combinazione dei vari mitemi. Il modello usato per riunificare le suddette unità è diverso da quello per selezionarle: questo perché ogni mito possiede più significati (linguistici e meta-linguistici), anzi, possono esistere più versioni dello stesso mito, da considerarsi tutte valide, proprio perché il mito non è collegato alla storia (semmai il mito di una tribù può essere collegato a un mito di una tribù limitrofa).
La struttura del mito ha una dialettica simile a quella hegeliana di tesi-antitesi-sintesi, al punto che non sono i singoli termini che contano, ma le relazioni tra loro. Bisogna solo cercare di capire quali sono gli elementi di opposizione e di mediazione. Il mito ha lo scopo di rendere accettabile una realtà contraddittoria. “I miti – afferma Lévi-Strauss – non ci dicono nulla che ci informi sull'ordinamento dell'universo, sulla natura del reale, sull'origine dell'uomo o del suo destino. Non possiamo sperare da essi nessuna concessione metafisica […]. Per contro, i miti ci insegnano tante cose sulle società da cui provengono, ci aiutano a evidenziare il meccanismo più profondo del loro funzionamento, chiariscono l'esistenza di credenze, costumi, istituzioni di cui non riuscivamo in un primo momento a comprendere la connessione; infine, ed è la cosa più importante, ci permettono di cogliere certe modalità operative dello spirito, così stabili nel corso dei secoli e così generalmente diffuse per vastissime zone da potersi considerare basilari” (L'uomo nudo, ed. Il Saggiatore, Milano 1974).
Lévi-Strauss era in grado di stabilire, analizzando varie centinaia di miti, la logica delle loro qualità sensibili (crudo/cotto, fresco/putrido ecc.), la logica delle loro forme (vuoto/pieno, contenente/contenuto), la logica delle loro relazioni (congiunzione/disgiunzione), nonché il principio di trasformazione, che permette di collegare il mito a tutta una serie di versioni antecedenti o a un insieme di versioni estranee, attraverso una serie di operazioni formali (omologia, simmetria, inversione, correlazione, isomorfismo). Un lavoro assolutamente incredibile, non meno faticoso di quello che fece Kant nella prima Critica, quando andò a cercare le regole formali del pensiero logico, indipendenti dalle circostanze di spazio-tempo. Lévi-Strauss diceva che l'attività mentale è determinata da costrizioni indipendenti da qualunque infrastruttura materiale, anche se quest'ultima può decidere il contenuto specifico da comunicare. In effetti nella sua antropologia si ha sempre l'impressione che egli usi determinate categorie alla maniera kantiana ma mettendole in relazione tra loro alla maniera hegeliana.
A detta di Lévi-Strauss, la struttura di un mito non è molto diversa da quella delle fiabe analizzate da Propp. (9) Vi è una situazione di partenza abbastanza statica, che in un passaggio successivo si complica, fino a creare una crisi che rischia di bloccare il processo, essendo gli elementi opposti apparentemente inconciliabili. Ma poi avviene il colpo di scena finale, in cui tutto si ricompone. La struttura formale è qualcosa di oggettivo: 1) sta nella classificazione della tipologia degli elementi opposti, 2) rimane inalterata a dispetto di tutte le traduzioni che si possono fare; 3) non può essere interpretata in chiave psicologica, cioè soggettiva, né in chiave meramente sociologica, poiché la compatibilità tra le strutture è un presupposto di partenza, non qualcosa che potrebbe anche non verificarsi. La raffigurazione plastica ch'egli fornisce per spiegare il mito è quella della struttura a sfoglie, che viene in superficie a mo' di spirale, attraverso un processo di ripetizione in cui gli elementi fondanti possono cambiare, ma sempre in maniera concatenata. Cosa poi un mito dica, sul piano del contenuto, interessa poco a Lévi-Strauss, anche perché gli argomenti trattati tendono a ripetersi: per es. il divieto dell'incesto, la necessità umana di uccidere l'animale, la presenza di elementi opposti nel mondo, la fine delle persone morte, il ruolo della foresta, l'origine dell'universo, come si diventa adulti (prove da superare, riti di iniziazione, circoncisione...).
Non mancarono tuttavia le critiche, e proprio in relazione al metodo usato. (10) Anzitutto gli si fece notare che gli elementi contraddittori che egli aveva pensato di individuare nei miti, in realtà, essendo scontata, nella sua analisi, la loro ricomposizione, apparivano come dei semplici “contrari”. Cioè dall'analisi di Lévi-Strauss non si riesce a capire quando il mito esprime una contraddizione reale, irriducibile; questo perché il mito, secondo l'antropologo, doveva servire per escluderla o rimuoverla. Sicché “contrario” e “contraddizione” sono mescolati in modo arbitrario, e in definitiva prevale sempre il primo termine. Se lo scopo del mito è quello di fornire un modello logico in grado di superare una contraddizione reale, bisogna però aggiungere che tale contraddizione, nell'analisi di Lévi-Strauss, non è possibile individuarla, resta indecifrabile, poiché egli dà per scontato che la funzione del mito sia semplicemente quella di proporre un superamento dell'antitesi reale in chiave linguistico-formale (coincidentia oppositorum).
Il rischio, nella sua analisi, è quello di rinchiudersi in un atteggiamento “autospiegante e autogiustificante”, come è stato detto da K. Burridge nel libro citato di E. Leach. “Il metodo di Lévi-Strauss sembra imporre un'uniformità falsa al materiale, poiché l'ordine non scaturisce dall'incontro fra ricercatore e dati, ma dalle categorie di un sistema chiuso, che non può ammettere ulteriori possibilità” (p. 149).
D'altra parte Lévi-Strauss non si chiede mai quando un mito possa essere nato, in quale condizione storico-sociale (se comunistica, schiavistica, feudale o borghese-coloniale), né che cosa possa averlo generato, e neppure se in esso siano presenti degli sviluppi che riflettono il passaggio da una formazione sociale a un'altra. Al massimo arriva a sostenere che gli elementi inspiegabili di un mito si possono chiarire nell'analisi di altri miti, appartenenti alla stessa tribù o a una limitrofa. Quanti più miti si possono esaminare, tante più possibilità vi sono di comprendere gli elementi apparentemente inspiegabili. Il contenuto di un mito (il suo messaggio) può essere sviscerato solo dopo aver chiarito la sua ossatura (gli elementi costanti) e il suo codice (l'interrelazione tra gli elementi costanti). Le cose si trasformano sulla base delle opposizioni di vita (o di nascita) e morte, fuoco e acqua, Sole e Luna, luce e buio, maschio e femmina, alto e basso, e così via, sempre alla ricerca di una mediazione soddisfacente.
Tali limiti storiografici rendono arbitraria la ricostruzione logica della struttura di un mito. E diventa tanto più arbitraria quanto più un determinato mito viene analizzato nel suo passaggio da una popolazione a un'altra. È assai dubbio che in tali passaggi non venga snaturata l'essenza originaria di un mito, cioè che si sia in presenza di una semplice espressione di una medesima essenza in forme diverse.
Lévi-Strauss ha la pretesa di rendere intellegibile un mito spezzandolo in unità semantiche, basate sull'opposizione di elementi contrari, oggettivamente riconoscibili e definite con precisione, salvo poi dire, non avendo interesse per alcuna analisi storica, che i miti hanno significati molteplici, dovuti al fatto che delle loro origini ancestrali non hanno piena consapevolezza neppure gli stessi indigeni, i quali li accettano così come sono, eventualmente aggiungendo delle varianti. Il che è sicuramente vero, ma proprio per questo un antropologo dovrebbe sapere che se un mito si esprime in una forma linguistica, non è riducibile a una mera analisi di questo tipo, anche perché non è possibile capire con sicurezza quale delle singole unità che lo compongono debba essere considerata prioritaria sulle altre.
Decostruirlo in tante unità semantiche, come se fosse un componimento poetico o prosastico o la struttura di un brano musicale, significa perdere buona parte del suo significato complessivo: il tutto, in un mito, resta sempre di molto superiore alla somma delle singole parti. Dire che le strutture di un mito sono composte da opposizioni e mediazioni non è dire cosa sono le strutture, quale sia la loro origine sociale e culturale. È dire soltanto che ci sono delle “strutture”, ma questo è normale nel linguaggio umano. Anche un folle si esprime in maniera “logica”. Non si può restare stregati di fronte alle infinite possibilità del linguaggio, tanto più che nelle comunità primitive esisteva soltanto la comunicazione orale dell'esperienza.
Ecco perché non ha alcun senso cercare nei miti degli elementi costanti o comuni, per poi mescolarli in uno shaker, finalizzato a produrre un cocktail sufficientemente logico. Così facendo, si finisce con l'essere intrappolati in un gioco a specchi, in cui un'immagine rimanda a molte altre, senza che si sia in grado di dire quale sia quella autentica. Dopodiché è vano sostenere che la propria antropologia non ha nulla a che fare con il tema degli “archetipi universali” dello psicanalista C. Jung, temendo di non potersi sottrarre all'accusa di aver voluto rendere universali delle categorie inconsce che in realtà appartengono alla cultura occidentale.
Un mito può avere qualunque significato per l'antropologo contemporaneo, non potendolo conoscere direttamente da chi l'ha formulato e avendo informazioni limitate da parte di chi l'ha conservato e divulgato (peraltro oralmente, nel caso degli indigeni). Ricordiamo tutti quando, da bambini, giocavamo al “telefono senza fili”, quale stranissima frase l'ultimo componente della cordata diceva ad alta voce, dopo che il primo l'aveva sussurrata all'orecchio del secondo, questi al terzo e così via. Non solo, ma è difficile pensare che un occidentale, così “avanzato” nella sua cultura scientifica, possa comprendere il significato di un mito nato in un ambiente tribale. Per quanto tempo la Chiesa cristiana ha ritenuto che Adamo ed Eva fossero dei personaggi reali? O che fosse veridica la descrizione della nascita dell'universo riportata nella Genesi? Ancora oggi non ha dubbi nel sostenere che tutti i miracoli attribuiti a Gesù Cristo siano autentici.
Che le religioni facciano parte di una visione mitologica della realtà è ben visibile nell'idea favolistica che hanno dell'eroe, preposto a sacrificarsi romanticamente per il bene del suo popolo, nella convinzione che per risolvere i problemi dei conflitti sociali non vi sia altro modo che l'autoimmolazione. Un'idea basata sulla convinzione, del tutto moralistica e illusoria, che vedendo morire in questa maniera un'eroe positivo, innocente, intelligente, i protagonisti del “male” diventeranno migliori, si pentiranno del male compiuto.
Tuttavia, più che affrontare problemi del genere un antropologo dovrebbe cercare di comprendere lo sfondo storico-sociale-culturale in cui un mito tribale si è formato (sempre che la comunità indigena glielo permetta). Di sicuro non si può risalire alla comprensione della vita di una tribù analizzandone i miti: semmai si dovrebbe fare il contrario. Non c'è sincronia autentica senza adeguata diacronia. I miti non possono essere analizzati come strutture a-temporali solo perché contengono elementi formali o funzionali che si ripetono in decine o anche centinaia di miti. Se si prendono tre palline di colore diverso e le si mettono in file in cui le combinazioni di colore sono diverse, ad un certo punto le combinazioni finiscono. Ma questo non vuol dire che il significato del mito stia in una di quelle combinazioni, e neppure nel loro elenco complessivo. E non è che le probabilità di una corretta ermeneutica aumentino, aumentando il numero di palline di colore diverso. Questo, poi, senza considerare che resta alquanto dubbio che Lévi-Strauss abbia davvero fatto un favore ai primitivi dicendo che il loro pensiero assomiglia, più o meno, a quello dei popoli “civilizzati”.
Esistono motivazioni altamente drammatiche sottese alla elaborazione dei miti, i quali hanno proprio lo scopo di ridurne la gravità. I miti sono operazioni intellettualistiche che in genere vengono compiute quando il peso delle contraddizioni sociali si fa eccessivo e non si sa come risolverlo praticamente. I miti servono appunto per illudersi che si possano risolvere gli antagonismi non socialmente, bensì intellettualmente: in tal senso rappresentano una soluzione mistificata di un problema reale, di natura piuttosto seria. È difficile comprenderli se non vengono contestualizzati nelle loro coordinate storico-culturali.
Anche i bambini possono dare delle spiegazioni consolatorie di tipo fantastico ai loro problemi irrisolti. Ma per poter capire che le spiegazioni non hanno alcunché di reale, non basta avere un atteggiamento logico-razionale. Bisogna anche capire tutta la natura dei problemi irrisolti. Un mito non è come un puzzle di cui abbiamo tutte le tessere per poterlo ricostruire. Ci rimane in mano sempre qualche tessera che non si incastra da nessuna parte, e non è detto che queste tessere in più abbiano meno importanza di quelle che abbiamo già diligentemente collocato.
Nell'interpretare alcuni miti del mondo greco ho dovuto assumere, per poterci capire qualcosa che non fosse di una banalità sconcertante, un atteggiamento che considerasse in maniera rovesciata il significato ch'essi volevano trasmettere. I protagonisti che vincono in una determinata contesa ho finito col considerarli gli elementi eticamente peggiori del racconto, anche se nella mente dell'autore di quei testi dovevano apparire quelli più eticamente convincenti. I miti servono per falsificare la realtà, edulcorandola, stravolgendola, mistificandola in qualche sua parte. Che lo si faccia inventandosi le cose di sana pianta o manipolando degli eventi reali, non cambia molto la sostanza delle cose.
Un mito non esprime mai la vera o l'intera cultura di una popolazione, ma soltanto la presenza di una cultura che si dà spiegazioni parziali a problemi di natura complessa e altamente drammatica. Altrimenti non sarebbero tali, ma fiabe, favole, massime filosofiche, aneddoti o proverbi popolari, parabole ecc. Sono come una valvola di sfogo, usata nella speranza che la pentola a pressione non scoppi.
Semmai si potrebbe dire che anche nelle culture tribali, pur non conoscendo esse il regime schiavistico, si è vissuto, con un certo pathos, il momento del distacco dal regime delle foreste, dal primordiale comunismo egualitario. Si è percepita questa transizione con una certa sofferenza e si è cercato di renderla meno dolorosa possibile. Si potrebbe in sostanza sostenere che là dove sono presenti dei miti formalizzati, istituzionalizzati, come facenti parte di una cultura condivisa, lì è presente anche una comunità che ha vissuto con drammaticità le proprie contraddizioni sociali, nei confronti delle quali non è stato possibile trovare soluzioni soddisfacenti, se non appunto a livello mitologico, che però è puramente fittizio. In ogni caso, per capire davvero qualcosa dei miti di una tribù, bisognerebbe, come minimo, appartenervi per alcuni anni, spogliandosi di tutto il proprio background culturale, ivi inclusa la mania di “scrivere” le esperienze che si vivono.
Tuttavia, a Lévi-Strauss affascinava proprio l'aspetto “astratto” dei miti, il loro livello metafisico, espresso in maniera simbolico-metaforica, che giudicava sofisticato, più che poetico, molto evocativo e niente affatto “primitivo”. Non pochi critici però sottolinearono che egli sapeva pochissimo delle tribù di cui prendeva in esame i miti: stava con loro solo pochi mesi, avendo però cura di scrivere copiosi libri. I più maliziosi arrivarono a dire ch'egli preferì esaminare i miti ancestrali dei mondi extraeuropei nella speranza di non essere contraddetto nelle sue interpretazioni forzose, unilaterali. Da notare che una volta disse (lui che proveniva da un'agiata borghesia ebraica di origine belga) di non aver voluto prendere in esame i miti della cultura cui apparteneva (nonostante il professato ateismo) proprio perché della storia degli Israeliti, secondo lui, non si sapeva abbastanza!
C'è da dire che in questo atteggiamento intellettualistico egli rifletteva un trend comune a tutti gli antropologi del suo tempo. Si presentavano a una determinata tribù come degli estranei, dei ricercatori isolati, pagati da qualche istituzione prestigiosa, latori di esigenze personali, di cui la comunità non avrebbe saputo cosa fare, ma a cui non avrebbe potuto opporre la benché minima resistenza, essendo oppressa da un regime coloniale da parte di qualche madrepatria europea.
Si dice che Lévi-Strauss abbia contribuito a relativizzare l'importanza della cultura occidentale, a valorizzare le culture primitive, a mostrare che i meccanismi che fanno funzionare tutte le culture umane, di ogni tempo e luogo, sono fondamentalmente gli stessi, in quanto appartenenti inconsciamente all'homo sapiens. Tutto ciò è senz'altro vero, ma è anche vero che, nonostante i suoi studi e quelli di tanti altri antropologi, l'occidente ha continuato a sterminare le comunità indigene, cioè non ha mai smesso di comportarsi in maniera colonialistica. Alla fin fine questi ricercatori hanno usato le tradizioni primitive solo per la loro carriera professionale.
Con questo ovviamente non si chiede agli antropologi di diventare dei “politici”, di mettersi quotidianamente alla ribalta per difendere la causa delle ultime comunità indigene rimaste (soprattutto di quelle incontattate), mostrando che il loro stile di vita è l'unico davvero eco-compatibile. Magari lo facessero! Sarebbe in realtà sufficiente che riuscissero a scoprire, nelle società borghesi in cui vivono, quando nella cultura di queste società si assumono atteggiamenti “mitologici” nei confronti delle soluzioni di certi gravi problemi. Per es. affidare a un “duce” la soluzione degli antagonismi sociali riflette forse una posizione “razionale”? Non sarebbe forse sufficiente far capire che non si può assumere una posizione “mitologica” nei confronti degli stessi miti?
Lo strutturalismo in antropologia è stato importante in quanto ha fatto capire che nell'analisi delle comunità primitive bisognava partire dalle funzioni condivise dal collettivo locale, e che i ruoli soggettivi, presenti anche nei miti, hanno un ruolo del tutto secondario. Ha fatto anche capire, analogamente al marxismo, che dopo Hegel parlare ancora di filosofia dal punto di vista filosofico non ha alcun senso. Tuttavia a questa scienza è mancato l'aspetto politico e l'analisi storica. Le comunità primitive andavano in realtà difese contro il colonialismo e persino considerate come dei modelli praticabili da chi vuole uscire dal concetto di “civiltà”: questo lo strutturalismo non l'ha mai fatto. Anzi, Lévi-Strauss ha sempre dato per scontato che le comunità indigene sarebbero, prima o poi, scomparse dalla faccia della Terra, facendo così assomigliare le sue lacrime, in Tristi Tropici, a quelle di un coccodrillo.
Il crudo e il cotto, ed. Il Saggiatore, Milano 2016.
Mito e significato. Cinque conversazioni, ed. Il Saggiatore, Milano 2016.
La linguistica e la scienza dell'uomo. Mito e significato (con R. Jakobson), ed. Il Saggiatore, Milano 2011.
La via delle maschere, ed. Il Saggiatore, Milano 2016.
Antropologia strutturale, ed. Il Saggiatore, Milano 2015.
Il pensiero selvaggio, ed. Il Saggiatore, Milano 2015.
Tristi Tropici, ed. Il Saggiatore, Milano 2015.
L'uomo nudo, ed. Il Saggiatore, Milano 2008.
Le strutture elementari della parentela, ed. Feltrinelli, Milano 2003.
Razza e storia-Razza e cultura, ed. Einaudi, Torino 2002.
Strutturalismo del mito e del totemismo, ed. Newton Compton, Roma 1975.
Il totemismo oggi, ed. Feltrinelli, Milano 1991 (ed. Et al., Milano 2010).
La vita familiare degli indiani Nambikwara, ed. Einaudi, Torino 1982.
Primitivi e civilizzati. Conversazioni con Georges Charbonnier, ed. Rusconi, Milano 1997.
Dal miele alle ceneri, ed. Il Saggiatore, Milano 2008.
Le origini delle buone maniere a tavola, ed. Il Saggiatore, Milano 2010.
Lo sguardo da lontano, ed. Il Saggiatore, Milano 2010.
Da vicino e da lontano (con Didier Eribon), ed. Rizzoli, Milano 1988.
Parole date. Le lezioni al College de France e all'Ecole pratique des hautes etudes, 1951-1982, ed. Einaudi, Torino 1992.
La vasaia gelosa. Il pensiero mitico nelle due Americhe, ed. Einaudi, Torino 1987.
Storia di Lince. Il mito dei gemelli e le radici etiche del dualismo amerindiano, ed. Einaudi, Torino 1993.
Guardare ascoltare leggere, ed. Il Saggiatore, Milano 2001.
Babbo Natale giustiziato, ed. Sellerio, Palermo 1995.
Tropici più tristi. Conversazione con Veronique Mortaigne, ed. Nottetempo, Roma 2005.
L'identità. Seminario diretto da Claude Lévi-Strauss, ed. Sellerio, Palermo 1980.
Da vicino e da lontano. Discutendo con Claude Lévi-Strauss, ed. Rizzoli, Milano 1988.
Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità, ed. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ) 2010.
L'altra faccia della luna. Scritti sul Giappone, ed. Bompiani, Milano 2015.
Siamo tutti cannibali, ed. Il Mulino, Bologna 2015.
La sociologia francese, Mimesis Edizioni, Milano 2014.
Dentro il pensiero selvaggio. L'antropologo e i filosofi (con M. Hénaff), Medusa Edizioni, Milano 2013.
L'antropologia di fronte ai problemi del mondo moderno, Bompiani, Milano 2017.
Lettere ai genitori (1931-1942), ed. Il Saggiatore, Milano 2018.
Note
(1) Attenzione che Lévi-Strauss sentiva di avere qualcosa in comune non tanto con gli strutturalisti più famosi (Althusser, Foucault, Barthes e Lacan), bensì con quelli meno noti: Georges Dumézil e Émile Benveniste.
(2) Lévi-Strauss rimase positivamente colpito da un passaggio dei Saggi nei quali Montaigne descrive i selvaggi della costa brasiliana mentre si cibano delle carni dei loro nemici. Montaigne li giudica superiori ai fanatici europei, protagonisti delle guerre di religione, che uccidono i nemici e li tagliano a pezzi non per mangiarne la carne, ma per gettarla in pasto ai maiali.
(3) Giudicava Rousseau profetico per la moderna linguistica strutturale, in quanto aveva capito che la principale condizione per identificarsi con gli altri è la compassione (pitié), il solo mezzo affettivo e intellettuale insieme. Intellettuale perché, se possiamo identificarci con chi è diverso da noi, allora possiamo anche distinguerci.
(4) L'intero universo – semplificando al massimo la sua “significatività” – sembra essere sostenuto da poche forze fondamentali: gravitazionale, elettromagnetica e nucleare (forte e debole). La legge basica è la sinergia, nel senso che ogni singola cosa è connessa a un tutto, il quale, proprio per questa ragione, rivela una certa razionalità. Materia ed energia sembrano essere due facce di una stessa medaglia, essendo tra loro perfettamente complementari. Spazio e tempo sono del tutto relativi, contestuali all'osservatore.
(5) Infatti in una comunità autogestita l'identità si confonde continuamente con l'alterità e l'io è inconcepibile senza il noi. Né ha senso dire, alla maniera hegeliana, che la tesi “produce” la propria antitesi, da mediarsi in una sintesi superiore. E tanto meno ha senso pensare a un'antitesi del tutto irriducibile alla tesi che le sta di fronte, in grado di mettere in discussione i fondamenti del suo esistere. L'uomo primitivo, vivendo a stretto contatto con la natura, ha bisogno di affidarsi con sicurezza alla “Madre Terra”. Non può esserci un'antitesi alla natura, nei cui confronti la comunità ha un atteggiamento di riconoscenza. L'unica antitesi possibile è soltanto una prova da superare per passare da una condizione esistenziale a un'altra. Quando c'erano rivalità tra tribù limitrofe, non si arrivava mai alla guerra di sterminio, anche perché in tutte le tribù vigeva l'esogamia, ed era sempre possibile lo scambio dei doni e il baratto del surplus.
(6) In Psicologia delle masse e analisi dell'Io Freud fa capire che il “mentale” è fin dal principio già “sociale”, per cui i costrutti culturali si sviluppano secondo regole universali insite nel funzionamento della mente e condizionano il rapporto di questa con la realtà.
(7) Secondo lui la differenza principale tra le due correnti di pensiero stava unicamente nel fatto che lo strutturalismo non opponeva il concreto all'astratto, assegnando a quest'ultimo una posizione di privilegio. Una precisazione insufficiente, con cui non poté certo evitare l'accusa d'essere un formalista solo per aver indirizzato l'oggetto dell'analisi strutturale dalla grammatica e dai testi letterari ai miti e alle relazioni parentali dei primitivi. Di fatto tra il formalismo di V. Propp (applicato alle fiabe) e lo strutturalismo di Lévi-Strauss (applicato ai miti) le differenze sono minime: il che non vuol dire che Propp abbia influenzato Lévi-Strauss, anche se la pretesa, dell'uno e dell'altro, di aver individuato un archetipo di tutte le fiabe e un archetipo di tutti i miti era la stessa. Propp, peraltro, si era messo a studiare le fiabe perché per interpretare i miti, giudicati più importanti, riteneva indispensabile un'analisi storica della popolazione che li aveva prodotti: cosa che, per sua stessa ammissione, andava oltre le sue competenze. Persino nell'analisi delle fiabe popolari diceva d'essersi limitato a un approccio morfologico proprio perché non aveva elementi sufficienti per collegarle alle tradizioni contadine. Per Lévi-Strauss invece le fiabe non erano altro che miti in miniatura, con opposizioni binarie più deboli e con contenuti più etici che metafisici. In questa maniera saltava a piè pari l'esigenza di un'analisi storica, che ha sempre ritenuto irrilevante, in quanto si accontentava di un approccio diretto con le comunità indigene ancora viventi. Il che lo portava a dire, in maniera illusoria, che nei miti forma e contenuto coincidono.
(8) I primi studi sulla mitologia indoeuropea sono invece del 1929 (Georges Dumézell).
(9) In realtà il semiologo lituano A. J. Greimas, che aveva lavorato sui miti dei Bororo, dirà che Lévi-Strauss aveva dato di Propp una lettura molto parziale.
(10) Per capire i limiti dell'approccio ermeneutico di Lévi-Strauss nei confronti dei miti è sufficiente leggersi il libro a più voci curato da E. Leach, Lévi-Strauss. Strutturalismo del mito e del totemismo, ed. Newton Compton, Roma 1975.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube