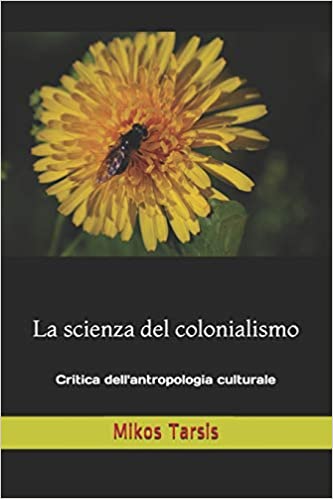
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
L'antropologia marxista
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
L'antropologia marxista fu un fenomeno, tutto sommato, abbastanza marginale nell'ambito degli studi del materialismo storico-dialettico. (1) Questo perché il mondo primitivo veniva considerato come una tappa dell'evoluzione storica destinata a essere superata dallo schiavismo, che sul piano produttivo, a causa delle monumentali città-stato, regni e imperi, appariva nettamente superiore. Per molto tempo il marxismo, sulla scia degli studi di F. Engels, considerò giusto che il modello-base dell'agricoltura emarginasse il sistema della caccia e raccolta e della pastorizia itinerante. Un modello che – come noto – s'impose, pur seguendo varianti significative in oriente e occidente, dal IV millennio a.C. sino al XIX secolo, quando fu rivoluzionato dal macchinismo capitalistico.
L'assurdità del marxismo è stata non solo quella d'immaginarsi un'evoluzione materiale o economica del tutto lineare (che si pensava essere basata soltanto su bisogni e interessi), senza una contestuale rivoluzione culturale che ne giustificasse il percorso, ma anche quella di ritenere che la comunità primitiva, nonostante il suo alto tasso di democrazia e di uguaglianza sociale, andasse superata a causa di una produzione troppo arretrata. Inoltre esso riteneva che, proprio a motivo del basso livello delle forze produttive, i primitivi si costruissero delle rappresentazione fantastiche che rispecchiavano la loro impotenza nella lotta contro la natura. Di qui la preferenza concessa al Neolitico patriarcale rispetto al Paleolitico matriarcale, benché il superamento definitivo della comunità primitiva avvenne soltanto nel IV millennio, con la nascita degli Stati schiavistici e l'uso dei metalli (oro, argento, rame, piombo, stagno e bronzo). (2)
Tutto questo oggi va considerato nettamente superato. Già Lenin aveva capito che la politica è più importante dell'economia, come la coscienza è più importante della spontaneità. Di fronte a processi che avvengono secondo determinazioni quantitative, spesso impercettibili, si può sempre far valere l'esigenza di una svolta qualitativa, di tipo rivoluzionario. Il leninismo dovette affrontare il problema delle società primitive quando, dopo aver compiuto la rivoluzione, ebbe a che fare con le tante etnie e nazionalità che lo zarismo teneva sottomesse, soprattutto nella parte asiatica della Russia. Purtroppo Lenin morì molto presto e i suoi successori, Stalin in primis, continuarono, peggiorandola, la politica autoritaria dei “grandi russi”.
Questo spiega uno dei motivi per cui l'antropologia non ebbe mai alcun significativo sviluppo nell'ambito del marxismo. Al mondo primitivo si riconosceva la prima forma di comunismo, ma solo nel senso dell'uguaglianza sociale, essendo assente la proprietà privata dei mezzi produttivi. Per tutto il resto quella forma di comunismo andava superata, esattamente come tutte le altre formazioni sociali antagonistiche. Il socialismo statale doveva avvalersi della rivoluzione tecnico-scientifica del sistema capitalistico, per cui si dava per scontato che solo questa forma di socialismo avrebbe garantito alla società tutto il benessere di cui aveva bisogno. Le comunità primitive ancora sparse nel pianeta avrebbero dovuto adattarsi a uno schema ideologico precostituito.
A questo schema, piuttosto semplicistico, dell'evoluzione storica si oppose un allievo e critico di Claude Lévi-Strauss, l'antropologo politico francese Pierre Clastres (1934-77), che fece importanti ricerche sugli indios del Sud America, cercando di dimostrare la falsità dell'assunto secondo cui tutte le società evolvono da un sistema tribale-comunista-egualitario a sistemi gerarchici. Questo perché le società non gerarchiche sono portatrici di meccanismi culturali che impediscono attivamente l'emergere di figure di comando, isolando potenziali candidati a leader o privandoli del potere. Tra i cacciatori-raccoglitori non si riconosceva mai alcun “capo ufficiale”, e in ogni caso il soggetto autorevole non disponeva di alcun potere coercitivo. Quando esistono dei “capi” è perché i colonizzatori volevano semplificare i rapporti con gli indigeni nel commercio di qualcosa. D'altra parte se manca la proprietà privata non possono esserci dei “capi”. Per 2,5 milioni di anni non ce ne sono stati. Ecco perché nel suo libro La società contro lo Stato (1974), in cui si riferisce agli Aché-Guayaki del Paraguay, Clastres sostiene che queste forme sociali non gerarchiche non possono essere considerate “primitive”, nel senso di “arretrate”. I gruppi primitivi andavano da 30 a 50 membri: se si arrivava a superare tale soglia, ci si divideva, proprio perché una comunità di 100-150 membri tende a diventare autoritaria.
Sino alla fine della II guerra mondiale il marxismo si era limitato all'opera di Friedrich Engels, Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato (1884), che può essere considerato il primo tentativo di applicazione delle idee marxiste alle società non europee. Engels non aveva fatto altro che utilizzare gli appunti etnografici presi dall'ultimo Marx, che si era messo a studiare vari testi sul comunismo primitivo, tra cui il principale fu quello dell'etnologo americano L. G. Morgan, La società antica (1877), dedicata alle istituzioni del matrimonio e della famiglia, ma gli interessava anche quello dello studioso russo M. Kovalevsky, La proprietà fondiaria in forma di obščina (1879), al fine di capire il carattere universale della proprietà fondiaria indivisa, esistente nei tempi antichi presso varie popolazioni del mondo. (3)
Tuttavia le conclusioni che trassero dai loro studi furono abbastanza divergenti: per Marx l'esistenza del comunismo primitivo andava completamente ripensata, e questo fu uno dei motivi per cui non portò a compimento gli ultimi due volumi del Capitale; per Engels invece l'esistenza di un comunismo del genere non metteva affatto in discussione ch'esso andasse superato dallo schiavismo, a partire dal quale nascono le civiltà progredite (Sumeri, Assiri, Babilonesi, Egizi, città-stato nella Valle dell'Indo, della Polinesia, della Cina, del continente americano, della Grecia e di Roma). Cioè Engels assunse in maniera schematica le tesi positivistico-evoluzionistiche di Morgan, secondo cui il mondo andava suddiviso in tre fasi: selvaggio, barbaro e civile, in rapporto al progresso tecnologico.
Quando negli anni Sessanta del XX sec. si avviò un primo tentativo di destalinizzazione in Russia, e si sviluppò nel Terzo Mondo il processo di emancipazione politica dal colonialismo, e si presero a leggere con maggiore interesse gli scritti di Marx dedicati al modo di produzione asiatico, alle forme economiche precapitalistiche e successivamente all'etnologia, l'ideologia marxista cominciò a diversificarsi, ammettendo l'idea che le formazioni sociali sono qualcosa di più complesso dei modi di produzione, e quindi criticando il carattere semplicistico della gerarchia dei cinque stadi dell'evoluzione (comunismo primitivo, schiavismo, feudalesimo, capitalismo, socialismo), incapace di rendere conto dello sviluppo storico delle società africane e asiatiche.
Ovviamente si evitava di prescindere da un fatto giudicato incontestabile: le società che costituiscono l'oggetto principale dell'antropologia culturale (quelle normalmente definite “arcaiche”, “non occidentali”, “pre-industriali” o “primitive”) devono essere osservate tenendo conto del rapporto di sottomissione coloniale che esse intrattengono verso il capitalismo, per cui considerarle come qualcosa di “statico”, conservatosi inalterato nel tempo, sarebbe un profondo errore.
La stessa tradizione antropologica occidentale, che aveva nutrito per motivi ideo-politici, una sostanziale diffidenza verso gli spunti etnologici offerti dalle opere di Marx e Engels, dovette ricredersi proprio dopo la II guerra mondiale, quando il socialismo statale ebbe nettamente la meglio sul nazifascismo, favorendo, indirettamente, i processi di decolonizzazione politica nel Terzo Mondo.
Furono gli etnologi francesi della seconda metà del sec. XX a interpretare una enorme mole di dati riguardanti le società africane in chiave marxista. Essi sostanzialmente aderirono alla versione strutturalista del marxismo data da L. Althusser, tra i cui allievi figurano M. Godelier, E. Terray e P.-P. Rey.
Ovviamente ci si muoveva anche in altre parti del mondo. In Gran Bretagna l'Associazione degli antropologi sociali convocò, nel 1973, per la prima volta nella sua storia, un simposio su antropologia e marxismo. Peter M. Worsley (1924-2013), figura di spicco dell'antropologia britannica, fu un membro fondatore chiave della Nuova Sinistra. Dedito ad alcuni studi antropologici è stato anche il marxista inglese Edward P. Thompson (1924-93), avverso allo strutturalismo di Althusser e per il quale il rapporto struttura/sovrastruttura andava ripensato completamente. Un antropologo inglese particolare è Stephan Feuchtwang, che dal 1966 si è concentrato sulle relazioni tra religione popolare e politica nella Cina Popolare e a Taiwan.
Negli Stati Uniti, Stanley Diamond (1922-91) fondò la rivista “Dialectical Antropology”, in cui sono pubblicati numerosi lavori sul rapporto marxismo/antropologia. Marvin Harris (1927-2001), col suo materialismo culturale, fece suoi alcuni postulati economici di Marx. Leslie A. White (1900-75) aveva simpatie per il marxismo, anche se non in maniera esplicita. J. S. Kahn, che ha svolto la sua attività sul campo tra i Minangkabau di Sumatra, aveva un'impostazione sostanzialmente materialistica.
Generalmente i suddetti etno-antropologi preferivano usare i concetti di “modo di produzione” e di “formazione economica e sociale”, più che quelli di “infrastruttura” e “sovrastruttura”, poiché avevano bisogno di individuare una totalità sociale in cui l'individuo e i gruppi sociali abbiano un senso generale nelle loro attività. La tendenza a collocare l'analisi di Marx all'interno di un'impalcatura meccanicistica (in senso funzionale-strutturale) veniva respinta a favore di un approccio più olistico, che tenesse contro degli aspetti simbolico-culturali. Erano considerate “volgari” le forme di materialismo che riducono le relazioni sociali allo status di epifenomeni ruotanti attorno alle relazioni economiche o in riferimento alla pura e semplice tecnologia o all'adattamento biologico.
Tuttavia quando si parla di “antropologia marxista” gli studiosi intendono soprattutto riferirsi a quella francese, per cui è di questa scuola che bisogna parlare, i cui autori più rappresentativi, che pubblicarono vari articoli nella rivista “L'Homme”, furono sostanzialmente quattro. (4)
Pur essendosi laureato in filosofia, Emmanuel Terray (1935) passò ben presto all'antropologia dopo aver letto Le strutture elementari della parentela di Claude Lévi-Strauss e soprattutto dopo aver incontrato Georges Balandier, che lo affascinò con la sua antropologia politica dedicata al Terzo Mondo. S'interessò dell'organizzazione sociale di un gruppo delle identità ivoriane: i Dida, cercando di costruire un'antropologia politica che potesse far parte del progetto marxista di Louis Althusser. (5) Fece una tesi anche sugli Abron, una popolazione del Ghana. Il suo testo più significativo è Il marxismo e le società primitive (1969), uno dei primissimi lavori di antropologia marxista, in cui mette in luce che presso i Dida vigeva una intersezione di due “modi di produzione”: il primo fondato sulla cooperazione paritaria di tutti i membri del gruppo, l'altro fondato su una distribuzione delle risorse alimentari e riproduttive (le donne) in base al criterio dell'anzianità, cioè legata al lignaggio. Secondo questo criterio i giovani sono dipendenti dagli anziani, gestori delle risorse materiali e degli scambi matrimoniali. Questo modo di produzione era del tutto estraneo alla teoria marxiana.
L'analisi di Terray veniva però contraddetta da quella di Claude Meillassoux (1925-2005), il quale aveva studiato la struttura socio-economica del gruppo Gouro (altra popolazione ivoriana), circoscrivendo l'intero metodo produttivo dei Gouro attorno alla dipendenza che legava i giovani agli anziani. Nel testo Donne, granai e capitali (1975) arriva a dire che il controllo sociale veniva esercitato dagli anziani sulle donne in quanto produttrici di uomini la cui energia lavorativa veniva poi investita nel lavoro della terra. La famiglia veniva quindi considerata una grande riserva domestica di manodopera: chi controlla le donne, controlla indirettamente la terra. Il modo di produzione lignatico non era che un'evoluzione storica del modo di produzione domestico, basato, quest'ultimo, sulla regola per cui i giovani, che prestano lavoro al servizio dei vecchi, ricevono, dopo un certo periodo di tempo, una moglie in cambio. Quindi tutti gli uomini hanno, nel corso della loro vita, la possibilità di accedere alle donne e ai mezzi di produzione sociale. Invece col metodo lignatico tutto dipende da chi è in grado di pagare un certo prezzo della sposa, sicché il controllo sociale della proprietà comune si trasforma in controllo biologico-riproduttivo da parte di una particolare categoria di persone. Un modo originariamente egualitario può trasformarsi, se condizionato da un sistema capitalistico-colonialistico, in una gerontocrazia sfruttatrice, in grado di destabilizzare, a lungo andare, la stessa comunità domestica.
Dopo aver studiato sul campo, dal 1965 al 1967, tre società del Congo-Brazzaville e la loro evoluzione durante il periodo coloniale, Pierre-Philippe Rey sostenne, in Colonialismo, neocolonialismo e transizione al capitalismo (1971), che i rapporti tra giovani e anziani, descritti nei due libri suddetti, andavano visti come “scontro di interessi tra classi contrapposte”, cioè tra i giovani e le donne da un lato e gli anziani e i maschi adulti dall'altro. Queste forme antagonistiche sono il prodotto, secondo Rey, dell'acuirsi dello sfruttamento coloniale delle piantagioni e dell'economia schiavista. È semplicistico parlare di giustapposizione di modi di produzione differenti.
In ogni caso questi studi sottolineavano come il lavoro sia fondato non solo sullo sfruttamento di una classe da parte di un'altra, ma anche su quello fra i sessi all'interno dell'unità domestica o fra i gruppi d'età nella società più ampia: sfruttamento legittimato dal sistema di proprietà e da quelli politico, di parentela e persino religioso.
Maurice Godelier (1930), allievo di Lévi-Strauss, centrò la sua attenzione sul tema della parentela nelle società primitive, osservando inizialmente usi e costumi dei Baruya, una cultura indigena della Papua Nuova Guinea. Stando a questo studioso la parentela è una “sovrastruttura” (secondo il significato marxista), ma, al tempo stesso, è anche una “struttura”, nel senso che i rapporti di parentela vanno visti come regolatori dei rapporti di produzione (struttura) e, al tempo stesso, dei rapporti politici e della sfera religiosa (sovrastruttura). Quindi la tesi di Meillassoux veniva considerata vera fino a un certo punto. Nelle società caratterizzate dal modo di produzione domestico i rapporti di parentela non sono il dato primario (biologico) del loro funzionamento, proprio perché l'universo di parentela non può essere ridotto a un livello meramente biologico, essendo qualcosa di eminentemente sociopolitico. Persino la religione può rivestire un ruolo centrale nei modi di produzione. Il classico rapporto struttura/infrastruttura/sovrastruttura andava ripensato, alla luce degli studi etnoantropologici delle comunità primitive, conferendo alle rappresentazioni simboliche una certa autonomia nei confronti dell'infrastruttura e delle basi materiali dell'esistenza. Anzi la nozione stessa di “modo di produzione asiatico”, elaborata da Marx per spiegare il mancato sviluppo del capitalismo in Cina e utilizzata da Karl August Wittfogel (1957) nell'analisi del dispotismo orientale nell'Asia antica, in Medio Oriente, nel continente americano e nell'Egitto faraonico, andava precisata proprio nella sua valenza culturale. (6)
Come si può notare la questione dei legami di parentela era centrale in queste ricerche. In ciò si rifletteva la dipendenza culturale dalle opere di Lévi-Strauss. In realtà il discorso sulla parentela, che poteva andare benissimo in un'analisi strutturale, non diceva granché sulla società primitiva. Questo perché il corpo sociale primitivo non può essere ridotto a legami di sangue o di alleanze parentali. La parentela non è la società, benché la società primitiva non possa essere pensata senza legami parentali. Per lo strutturalismo il sistema della parentela doveva servire per codificare il divieto di incesto. Ma per capire come la società primitiva possa costituire un'alternativa convincente alle società basate sugli antagonismi sociali ci vuole ben altro.
Come noto, l'altro grande argomento affrontato da Lévi-Strauss è stato quello mitologico, estraneo però ai marxisti francesi, e che invece interesserà molto quelli italiani. La tesi fondamentale dell'antropologo francese era che i miti costituiscono un sistema omogeneo, che li collega tra loro, per cui per capirne uno si può partire da un altro. Ma, così facendo, la formazione dei miti veniva ad essere separata dal sostrato sociale e produttivo che li aveva generati. La coerenza nell'interpretazione dei miti diventa logico-formale, ma perde di storicità. I miti implicano una dimensione sociopolitica, svolta con un linguaggio simbolico-figurato (ben visibile anche nei riti), che l'analisi strutturale, stregata dalla propria coerenza formale, evita di prendere in esame, anche perché sarebbe costretta a individuare le influenze del colonialismo sulle tradizioni popolari dei nativi. In poche parole lo strutturalismo, nelle mani di Lévi-Strauss, rischiava di diventare una sociologia senza società.
In Italia l'antropologia marxista è stata influenzata dal testo di Antonio Gramsci (1891-1937), Osservazioni sul folclore (1929-35), cui fece riferimento Ernesto De Martino (1908-65), anche se il suo fu un tipo di marxismo più etico-umanistico che socio-economico. Il marxismo gramsciano confluì successivamente negli studi demologici italiani (riguardanti il folclore e le culture contadine del Mezzogiorno), attraverso soprattutto le opere di Alberto M. Cirese (1921-2011) e di Luigi M. Lombardi Satriani (1936), senza dimenticare la figura di Vittorio Lanternari (1918-2010), concentrandosi sui temi seguenti: i riti e le concezioni magico-religiose, interpretate alla luce dei rapporti tra culture dominanti (cattolicesimo ufficiale e intellettuali meridionali) e culture subalterne (contadini della Basilicata), nel caso di De Martino; l'uso politico del folclore (come cultura di contestazione, come parte dei consumi di massa), nel caso di Lombardi Satriani; movimenti religiosi e oppressione coloniale, nel caso di Lanternari; demologia, letteratura popolare e patrimoni culturali nel caso di Cirese. Particolare attenzione all'antropologia religiosa ha dedicato anche Alfonso Maria Di Nola (1926-97), membro della presidenza del comitato promotore dell'Associazione culturale marxista fondata nel 1987. (7)
In Gramsci il folclore viene visto come una concezione del mondo e della vita di una popolazione, intesa come un insieme di credenze e di riti che caratterizzano le classi subalterne, del passato pre-unitario, ricche di tradizioni (anche magiche), contrapposte alle classi egemoniche, tipicamente borghesi, colte, fautrici dell'unificazione nazionale e tendenti all'omologazione culturale.
Accanto all'interesse esplicito verso il “Gramsci antropologo” nel dibattito letterario degli anni Cinquanta del XX sec., le raccolte sistematiche di canti e fiabe popolari italiane degli stessi anni sono da ricondurre alla forte influenza delle idee gramsciane su Italo Calvino (1923-85) e Pier Paolo Pasolini (1922-75), così come sulla produzione dei film neo-realisti.
Tuttavia, all'estero, soprattutto in Inghilterra, l'antropologia marxista si rese ben presto conto che identificare folk e mondo rurale era troppo semplicistico, anche perché nelle città si era sviluppato un folklore non riducibile a un semplice residuo frammentario di quello rurale, tenuto in vita da quanti erano immigrati dalle campagne nelle città in cerca di fortuna. Nella categoria del folk andavano inclusi sia la popolazione rurale che un proletariato urbano, in grado di gestire un proprio folklore. Per gli studiosi marxisti inglesi il folk (di origine sia contadina che proletaria urbana) s'identificava con le classi oppresse o, più in generale, con le “classi subalterne” in opposizione alle “classi egemoni”.
Senonché, proseguendo su questa strada, la sociologia borghese arrivò a dire che anche gli “oppressori” hanno un proprio folklore, sicché la parola “folk” può indicare qualunque gruppo di individui che presenta un fattore unificante, quale p.es. la nazionalità, l'appartenenza regionale o etnica o urbana (folklore italoamericano e cino-americano...), la religione (folklore cattolico, ebraico o islamico), l'occupazione (folklore dei vinificatori, dei fabbri, dei minatori o dei pastori), ecc. Ogni villaggio o paese o nazione possiede un suo corpus unico di tradizioni: toponimi, leggende, termini dialettali e specialità culinarie locali. Persino la singola unità familiare può vantare un tipo legittimo di folk: nomignoli per i familiari, storie tramandate delle vicende della famiglia, rituali familiari particolari.
La nuova definizione borghese di folklore, che rinunciava a qualunque caratterizzazione politica del folk, soprattutto se eversiva rispetto alla cultura dominante, consentiva di includervi anche tutti i gruppi di primitivi: ogni popolazione africana costituisce un autentico folk con il suo complesso di tradizioni folkloristiche, miti, leggende e fiabe, e lo stesso vale per le tribù indigene del Nordamerica e del Sudamerica. Anzi, un individuo può appartenere a diversi tipi di folk, in quanto membro di una famiglia, di un gruppo etnico, religioso, professionale e nazionale. Nel corso della sua vita egli dovrà passare da un codice all'altro, usando il folklore appropriato al gruppo in cui si trova in un dato momento.
Il declino dell'antropologia marxista
Verso gli inizi degli anni Ottanta, dopo una decina d'anni in cui lo strutturalismo e il marxismo erano prevalsi nella scienza sociale, un gruppo di pensatori (J.-F. Lyotard, J. Derrida, J. Baudrillard, G. Vattimo, ecc.) imbocca una strada che lo porterà lontano dal marxismo e che lo indurrà a porre le basi di una corrente filosofica postmoderna. Con la cosiddetta “fine delle ideologie”, col fallimento del cosiddetto “socialismo reale”, preceduto dall'esaurirsi delle speranze connesse alla rivoluzione culturale del Sessantotto, viene meno la ragione di presentare il socialismo scientifico come modello universale di validazione. Il fatto di trovarsi in un'era “post-metafisica”, rende impossibile credere in una visione del mondo agglutinante di tutte le culture. La “decostruzione”, lo smontaggio delle certezze acquisite diventa il modello critico del metodo ermeneutico della realtà. La credenza nella fine della storia viene infranta e s'impone il relativismo dei valori: non esiste più un obiettivo unitario verso il quale possiamo dirigerci.
Questi postulati penetrano nell'antropologia e sono approvati nel Seminario della School of American Research di Santa Fe nel New Mexico nel 1984. Qui si arriverà a criticare la pretesa di trasferire nel testo etnografico tutta l'immediatezza dell'interazione tra antropologo e informatori. L'antropologo non è in grado di descrivere esattamente ciò che vede, sia perché influenzato da un background culturale completamente diverso, sia perché i suoi stessi informatori, che in qualche maniera patiscono analoghi condizionamenti, non hanno la capacità di essere più obiettivi di lui. Le nozioni di “funzione” e “sistema” perdono di autorevolezza, sicché diventa inevitabile rinunciare a cercare le regolarità degli insiemi dei sistemi sociali e si preferisce la loro indeterminatezza.
Da allora un gruppo di antropologi americani (G. E. Marcus, V. Crapanzano, J. Clifford, P. Rabinow, S. Tyler, ecc.) ha trasformato l'antropologia in una mera lettura del comportamento umano, l'arte d'interpretare singole azioni significative, senza pretendere di studiare la società primitiva come un fatto oggettivo, nel suo insieme. Questo perché non è mai possibile entrare in contatto con una persona, in qualsiasi situazione sociale, senza costruire immediatamente una rappresentazione letteraria, simbolica, del soggetto di questo incontro. Anche nel caso in cui fosse l'informatore in persona a parlare, le sue informazioni non sarebbero altro che interpretazioni. La relazione tra antropologo e informatore è uno spazio di interlocuzione in cui entrano in gioco differenti interpretazioni di realtà, in maniera tale che l'antropologia altro non è che un'interpretazione di interpretazioni. Non c'è alcuna possibilità di penetrare in maniera olistica l'esperienza soggettiva dell'altro e della sua cultura: bisogna accontentarsi di dati parziali, ancorché rilevanti. Noi possiamo conoscere come un individuo usa i simboli nel suo rappresentare la realtà, possiamo conoscere la retorica dei simboli, ma non possiamo sapere, se non ipoteticamente, come i simboli siano vissuti.
La crisi della rappresentazione olistica di stampo struttural-funzionalista, o meglio, la decostruzione del concetto olistico di cultura ha indotto l'antropologia a passare dalla società al testo, a una specie d'incontro tra psicanalisi e letteratura, in cui lo stesso autore non deve temere di sentirsi coinvolto emotivamente. Fare ricerca non vuol dire analizzare e ricomporre sistemi sociali e culturali integrati, ma osservare frammenti di cultura, moltiplicare i punti di osservazione, collocarsi in una posizione decentrata, dentro e fuori il frame dell'osservazione.
Si prese a dire che, visto che un antropologo non è in grado di capire “scientificamente” neppure se stesso, deve smetterla di sentirsi il “salvatore” che cerca di recuperare le culture in via di estinzione, usando il più possibile un linguaggio asettico, neutrale, in cui viene bandita la sua personalità, la sua sensibilità (ci si riferiva ovviamente a Malinowski e Lévi-Strauss). L'antropologia, col suo culturalismo, deve allontanarsi dal “materialismo oggettivistico” e rientrare nel campo delle discipline umanistiche. La cultura deve diventare la variabile esplicativa indipendente da tutto. Questo permetterà all'antropologo di esprimersi non solo nella tradizionale forma saggistico-razionale, ma anche secondo altri criteri narrativi, etnopoesia, diario, fiction, comunicazione visuale, cultura orale, produzione estetica, stili performativi... La sua scrittura deve rinunciare a riordinare i dati, forzandoli dentro una “spiegazione” precostituita.
D'altra parte le stesse culture indigene non sono qualcosa di statico: il colonialismo le ha deformate in maniera irreparabile. È del tutto inutile cercare di rappresentarle oggettivamente (meno che mai può farlo un antropologo proveniente da società colonizzatrici): al massimo si può dar loro voce quando vogliono difendere il diritto a esistere.
Non solo, ma in un contesto globalizzante come quello attuale, ove i confini tra comunità locali e organismi sovranazionali sono quanto mai liquidi, l'antropologia deve ripensare il suo stesso oggetto tradizionale di ricerca. Tutto diventa oggetto di antropologizzazione. Il concetto di “campo” diventa quanto mai mobile, svincolato dall'aderenza a un determinato spazio, e per affrontare le sue problematiche occorrono competenze di più soggetti, in grado d'interagire tra loro (sociologi, psicologi, antropologi, statistici...). L'etnografia è multisituata, come dice George Marcus: il che richiede di comparare e giustapporre fenomeni che sono distanti tra loro solo in apparenza.
Tutto evapora, tutto si scolora, tutto s'intreccia in maniera inestricabile, al punto che non si capisce più da dove sorgano i problemi, quelli veri. Nell'analizzare l'iceberg, stando a bordo del Titanic, si preferisce limitarsi a osservare solo la sua punta, sotto ogni aspetto, considerando irrilevante quanto esso sia esteso sotto la superficie dell'oceano. Al IX Congresso di Sociologia spagnola, nel settembre 2007, più di 1.200 articoli o comunicazioni furono presentati. Ebbene, parole o definizioni come lavoratore, lotta di classe, classe operaia, fabbrica, fame, modi di produzione, neocapitalismo, imperialismo, colonialismo... erano quasi del tutto assenti. Eppure il colonialismo, seppure più economico e finanziario che politico, è rimasto. Il reddito medio dei paesi ricchi era, al tempo di Marx (1820), tre volte superiore a quello dei più poveri. Nel 1913 era undici volte. Nel 1973 quarantaquattro volte. Nell'attuale decennio, settantadue volte. Oggi, la quinta parte più ricca dell'umanità riceve l'86% delle entrate mondiali. Il relativismo o lo scetticismo degli antropologi postmodernisti serve soltanto a rafforzare una situazione abbondantemente consolidata; lasciano che tutto rimanga uguale in forza del presupposto che non ci sono criteri sufficienti per stabilire dei giudizi di valore oggettivi.
L'antropologia occidentale, che negli anni Sessanta e Settanta si era avvalsa del contributo del marxismo, oggi non sa che farsene, anche perché plaude al socialismo mercantile di tipo cinese. E pensare che già il classico Saggio sul dono (1924) di Marcel Mauss, pur considerando il dono come un fatto sociale totale, e quindi trascurando la produzione come elemento fondamentale per comprendere il meccanismo dello scambio economico, aveva molti punti di contatto con l'analisi della merce di Marx, con la differenza che la merce, essendo universale, fa incontrare due persone estranee, che tali restano dopo la compravendita, mentre il dono, essendo locale, aveva il compito di rinforzare delle relazioni sociali già in atto. Il libro era stato scritto in uno spirito di critica della disoccupazione e della disumana concorrenza borghese nel periodo tra le due guerre e presentava una visione politica riformistica in cui la società capitalistica doveva riconoscere un certo debito nei confronti del lavoratore.
Oggi il migliore etno-marxismo non appartiene né agli Stati Uniti né all'Europa occidentale, ma all'America Latina, che non può permettersi il lusso di rinunciare tanto facilmente a un approccio “classista” delle contraddizioni sociali e tanto meno a uno scollamento dell'antropologia dal colonialismo o dell'antropologia dalla storia, come facevano i funzionalisti e gli strutturalisti. Antropologi messicani, come R. Stavenhagen (1932-2016), scomparso di recente, e G. López y Rivas, non possono neppure separare i loro studi da un impegno politico progressista. Per loro l'etnia non è qualcosa di indipendente, incompatibile o antitetico al concetto di “classe”, né può essere ridotta al suo aspetto meramente “culturale”. Qualsiasi approccio economicistico è sbagliato, se riduce la questione etnica a una semplice questione di “sfruttamento economico” delle risorse del territorio di appartenenza dell'etnia. La questione etnica è una parte fondamentale della questione nazionale, nel senso che la fine dello sfruttamento della manodopera salariata è solo uno degli aspetti di un problema di più vaste proporzioni. Questo non tanto perché gli indigeni generalmente non sono dei “salariati”, quanto perché la questione etnica non può essere risolta semplicemente riconoscendo all'etnia uno spazio di manovra indipendente.
Bisogna peraltro fare attenzione all'uso che si fa del termine “etnia”, poiché con esso si possono mascherare atteggiamenti razzistici. Da tempo l'antropologia post-coloniale ha criticato l'uso di questo termine da parte degli antropologi che collaboravano coi colonialisti: se “etnia” vuol dire essere residenti in un medesimo territorio, fisicamente simili, parlanti una stessa lingua, devoti a una stessa religione e cose simili, allora tali classificazioni artificiose, che per gli stessi primitivi non avevano alcun senso, servono soltanto a controllare i vari gruppi etnici. L'odio interetnico scoppiato negli anni Novanta tra Hutu e Tutsi in Ruanda, che comportò un milione di morti, fu alimentato a bella posta da Francia, Belgio e Stati Uniti (tramite aiuti finanziari e formazione militare, con relative forniture belliche) per meglio influenzare quel Paese.
L'agire dei cosiddetti “primitivi” pone interrogativi di fondo (soprattutto in termini di tutela ambientale) alle relazioni sociali degli stessi popoli urbanizzati. L'antropologia marxista sudamericana è come se avesse intuito che è impossibile passare dal capitalismo al socialismo senza un certo ritorno al democratismo “primitivo”.
Nel suo manuale, Antropologia culturale (ed. Zanichelli, Bologna 1998, fasc. A, p. 133), Marvin Harris si chiede perché l'Africa sia così arretrata, e ha cercato di dare sette spiegazioni di tipo storico, culturale, ambientale, che metteremo in corsivo.
A causa del deserto del Sahara gli africani sono stati tagliati fuori dal patrimonio tecnologico e ingegneristico che Roma aveva lasciato in eredità all'Europa.
Questo è un modo positivistico o evoluzionistico di guardare le cose e, come tale, non vale nulla. Il progresso non sta nella tecnologia in sé. I parametri del progresso antico dell'Africa non vanno messi a confronto con ciò che i Romani avevano fatto sul piano tecnologico e ingegneristico. Nell'alto Medioevo le tribù barbariche liberarono gli schiavi o li trasformarono in servi pur avendo una tecnologia nettamente inferiore a quella romana; anzi, dopo che i barbari trasferirono la loro residenza nelle campagne, le città furono in gran parte abbandonate (si pensi alla perdita dell'uso degli acquedotti e delle condutture dell'acqua e delle fogne, oltre che dei bagni pubblici e delle terme). Non solo, ma nella campagna si fecero progressi tecnologici che i Romani, proprio a causa dello schiavismo, non arrivarono mai a compiere: si veda ad es. la sostituzione dello schiavo o dell'animale coi mulini a vento per macinare i cereali, ma anche il collare da spalla per i cavalli da traino, il ferro per i loro zoccoli, la bussola, il timone girevole, la carta, gli occhiali...
Il deserto del Sahara impedì anche il flusso verso sud delle influenze arabe che tanto fecero per rivitalizzare le scienze e il commercio europei.
Di nuovo si ripete il concetto borghese che il progresso sta nelle scienze e nei commerci. Qui poi gli errori storici sono due: a) non è vero che l'islam non poté penetrare nell'Africa sub-sahariana; poté farlo tranquillamente utilizzando l'Oceano Indiano, tant'è che furono gli arabi a creare l'istituto della schiavitù in questo continente, dopo ovviamente la civiltà egizia, che però la praticava nella forma statalistica. Non a caso furono proprio gli islamici, inizialmente, a fare da mediatori tra le comunità indigene e i colonizzatori europei per le esigenze di manodopera schiavile da parte di quest'ultimi. b) Il secondo errore sta nel fatto di non rendersi conto che anche i Paesi magrebini, pur essendo a contatto diretto con l'Europa occidentale di tipo capitalistico, rimasero poco sviluppati tecnologicamente, lontani dalle dinamiche borghesi più avanzate, tanto che furono facilmente colonizzati dagli europei. Questo per dire che per arrivare al capitalismo occorre anche una certa cultura cristiano-borghese. Conquistato l'impero bizantino, l'islam impedì che sulla costa mediterranea e mediorientale si formasse una cultura favorevole allo sviluppo del capitalismo. Anche quando l'islam occupò la Spagna, non arrivò mai a porre le basi di uno sviluppo socioeconomico favorevole al capitalismo, pur essendo gli islamici degli ottimi orticoltori, agricoltori, mercanti, navigatori... Non avevano la cultura adatta allo scopo.
La presenza della mosca tze-tze nelle foreste africane a sud del Sahara impediva che i bovini potessero essere utilizzati come strumenti da tiro e come fonti di latticini.
La mosca tze-tze è diffusa dal Sahara fino al deserto del Kalahari: depone le uova nella terra umida vicino all'acqua. Solo di recente, a causa dei mutamenti climatici, ha cominciato a migrare nei pressi delle grandi città, minacciando circa 60-70 milioni di persone di 36 Paesi sub-sahariani. Non esiste vaccino per animali o esseri umani, poiché il batterio parassita è in grado di eludere il sistema immunitario dei mammiferi. Ci si deve accontentare di alcuni farmaci per curare la malattia, anche se di recente è stato decifrato il suo complesso genoma, che conta ben 366 milioni di “lettere” (pari al 10% del genoma umano!): si è scoperto che l'insetto è particolarmente attratto dal nero e dal blu elettrico. Questo parassita non uccide animali tipicamente africani, come antilopi, bufali, potamocheri, cefalofi, antilopi cervicapra e facoceri, ma il bestiame introdotto in Africa dall'uomo: asini, buoi, cammelli, cani, capre, cavalli, maiali, muli e pecore. Ogni anno elimina circa tre milioni di capi di bestiame: il che ovviamente non è un male per gli animali selvatici e per la riproduzione vegetale della natura. Tra il 1902 e il 1905 la malattia uccise circa 30.000 persone nella regione del Lago Vittoria. Nei decenni successivi si propagò in Camerun, Ghana e Nigeria. In molti villaggi fu infettato un terzo della popolazione, al punto che fu solo verso la fine degli anni Trenta che l'epidemia scomparve. Oggi però questa malattia colpisce intorno alle 25.000 persone ogni anno. Detto questo, si può aggiungere che l'Europa occidentale ha conosciuto ondate ricorrenti di epidemie (peste, vaiolo, lebbra, colera, tifo, influenza spagnola...) infinitamente più gravi della cosiddetta “malattia del sonno”, al punto che hanno provocato una riduzione enorme dell'intera sua popolazione: tuttavia questo non le ha affatto impedito di svilupparsi in maniera borghese.
Harris sembra non rendersi conto che là dove esistono foreste che permettono caccia e raccolta (e, per certi versi, anche l'orticoltura nomadica), non vi è alcuna necessità di passare all'agricoltura intensiva. Gli Egizi han praticato l'agricoltura per 4.000 anni (iniziando quando in Europa si era ancora all'età della pietra): eppure ciò non ha avuto alcuna conseguenza sul resto dell'Africa, che rimase ancora ferma a metodiche alimentari nettamente pre-schiavistiche.
I cavalli, che nell'Europa medievale erano divenuti le principali macchine da guerra, nell'Africa tropicale scarseggiavano o addirittura non esistevano.
In realtà l'uso militare del cavallo è conosciuto in Africa da tempi immemorabili, grazie ai bellicosi Hyksos, che lo usavano nei loro carri militari (gli Egizi lo adottarono verso il 1600 a. C.). Al tempo dei Cartaginesi si usavano anche gli elefanti per fare la guerra. Gli stessi conquistatori arabi del nord Africa rimasero affascinati dai cavalli berberi, per la loro notevole resistenza, agilità e capacità di adattamento, e provvidero subito a incrociarli con quelli che loro già possedevano. Il cavallo berbero venne ampiamente impiegato sui campi di battaglia fino alla metà del Novecento. Eppure i Paesi magrebini non divennero mai capitalistici in maniera autoctona. Inoltre esistevano cavalli anche in Namibia, famosi per la loro capacità di sopravvivere in un ambiente desertico. E che dire dell'impresa eroica di Lawrence d'Arabia che, contro gli Ottomani, preferì usare i cammelli?
Mentre i popoli che vivevano nel bacino del Mediterraneo sviluppavano i commerci e le guerre grazie alle navi e divennero potenze marinare, i loro omologhi di pelle scura a sud del Sahara erano privi di mezzi navali per difendersi, tant'è che le prime navi portoghesi, nel XV sec., occuparono i porti africani con molta facilità.
La flotta navale punica dominò l'intero Mediterraneo dal VI al III secolo a. C., eppure questo non fu sufficiente per vincere l'espansione romana, che apprese l'uso militare delle navi proprio dai Cartaginesi. Questi ultimi avevano imparato a costruire navi dagli Egizi, che furono i primi a sfruttare la navigazione come mezzo di trasporto per merci, soldati e informazioni. Il Nilo, che attraversa l'intero Egitto, è un'ottima via di comunicazione grazie alle sue acque calme e al vento che, soffiando prevalentemente da nord, permette la navigazione controcorrente. Le prime zattere di papiro intrecciato risalgono al periodo Predinastico (tra il 5000 a.C. e il 3500 a.C.). Furono proprio loro a inventare la vela. Successivamente furono scalzati dai Fenici. Gli Arabi sono sempre stati ottimi commercianti e ottimi navigatori, in grado di insegnare agli europei molte cose. Eppure da tutto ciò non venne fuori la mentalità borghese che portò alla nascita del capitalismo. È altresì probabile che le società sub-sahariane non abbiano sviluppato la navigazione proprio perché, essendo l'Africa un continente immenso, non avvertivano la necessità di comportarsi in maniera colonialistica. In fondo i primi veri Stati schiavistici dell'Africa (oltre a quello statalistico degli Egizi) sono stati costruiti con due imperi in conflitto tra loro:
a) quello Songhai, che, costituito nel VII sec. sul medio corso del Niger, dominerà su quasi tutta l'Africa occidentale sino alla metà del XV sec., dopo aver adottato l'islam nell'XI sec. In questo impero si creò un esercito professionale e la suddivisione amministrativa del territorio in province, ciascuna affidata a un governatore. Inoltre i giudici, i medici e gli studiosi musulmani erano stipendiati dallo Stato.
b) L'impero del Mali (fondato a metà del XIII sec.), il cui sovrano Abubabakri II inviò una spedizione attraverso l'Atlantico quasi due secoli prima di Colombo (solo una nave fece ritorno). Il suo successore, Kankan Musa, donò così tanto oro, in un pellegrinaggio verso La Mecca, da far crollare il prezzo di questo metallo a livello mondiale per 12 anni. A Timbuctu furono fondate due università islamiche. Eppure tutto questo, che non aveva nulla di inferiore a quanto stava accadendo in Europa occidentale nello stesso periodo, non fu sufficiente a porre le basi per la nascita del capitalismo. Nel 1591 un esercito marocchino guidato da Judar Pasha (l'ex cristiano Diego de Guevara) invase e sconfisse l'impero, che non si riprenderà mai più.
Il commercio degli schiavi, inaugurato dai Portoghesi, paralizzò completamente l'economia africana, distruggendo tutti gli Stati feudali esistenti.
In realtà andrebbe spiegato il motivo per cui lo schiavismo introdotto dagli islamici non ebbe lo stesso effetto devastante di quello europeo. Schiavisti e commercianti berberi percorrevano da secoli, lungo il Sahara, le piste che li portavano nell'Africa tropicale per acquistare schiavi da vendere nei mercati nordafricani. Eppure ciò non sconvolse l'Africa come fecero gli europei. Inoltre lo schiavismo in sé non paralizza affatto l'economia: quello greco-romano creò due imponenti civiltà commerciali. Semmai paralizza l'economia basata sull'autoconsumo. Lo schiavismo risultò conveniente persino nel XIX sec., quando, pur di conservarlo tra le piantagioni di cotone, i piantatori sudisti negli Stati Uniti furono disposti a far scoppiare una dura guerra civile. Andrebbero inoltre diversificate le tipologie dello schiavismo: p.es. quello iberico, rispetto a quello anglo-francese, di industriale non ebbe quasi mai nulla.
La rivista “n+1”, espressione dell'ultima corrente bordighista italiana (Sinistra Comunista) e del sito quinterna.org, ha dedicato vari numeri al tema del comunismo primitivo. Pur non essendo specializzata in etno-antropologia, sono forse le sue cose migliori, che meritano d'essere analizzate, non solo perché attinenti all'argomento di questo libro, ma anche perché si rifanno all'ideologia marxista, seppur in modo piuttosto singolare, come vedremo.
La tesi principale che la redazione vuole sostenere è espressa nel numero monografico 27/2010: “nella prima transizione la dinamica sociale che porta dal comunismo primitivo alla proprietà [sottinteso: privata], alle classi e allo Stato [sottinteso: classista], contempla un passaggio in cui la società è ibrida, è cioè una commistione di comunismo che non c'è più e di proprietà classista che non c'è ancora. Nella seconda transizione avremo un effetto evolutivo analogo nel passaggio dalla società proprietaria di classe al comunismo sviluppato. Avremo cioè un comunismo che c'è già in lotta aperta contro un capitalismo che c'è ancora. Dimostrando che è possibile la persistenza di una struttura comunistica primitiva in ambiente sociale assai avanzato, alle soglie della forma statale, è anche dimostrato che sarà possibile l'anticipazione di una struttura comunistica avanzata in un ambiente sociale ancora arretrato, cioè con retaggi capitalistici”. La transizione odierna avrebbe un carattere “scientifico”, in quanto si porrebbe come “evento della natura, che accumula forza in evoluzione graduale verso eventi catastrofici repentini”. Le transizioni, infatti, sono evolutive, inevitabili, in cui il ruolo rivoluzionario dei soggetti è piuttosto relativo. L'inevitabilità consisterebbe nel fatto che il capitalismo, per sopravvivere, è costretto a socializzare sempre più, a livello internazionale, la propria produzione e distribuzione, venendo a collidere con una gestione privatistica della proprietà. La suddetta redazione cioè vorrebbe sostenere una corrispondenza speculare tra la prima e la seconda transizione, in cui il comunismo primitivo veniva conservato a fatica, e quello futuro, che non potrà affermarsi con meno fatica.
Ora però, senza star qui a discutere il determinismo scientista che caratterizza questa corrente (8), vediamo meglio come viene articolato il discorso sulla prima transizione, che è argomento attinente al nostro oggetto. La tesi principale che noi abbiamo sostenuto in tutto questo libro è che il comunismo primitivo può essere esistito, nella sua forma paleolitica, a livello mondiale, almeno fino a quando non si scopre l'importanza dell'agricoltura, che comporta il superamento del nomadismo con la stanzialità. (9) Dopodiché si fronteggiano due modi diversi di vivere la vita: anzitutto quello dei cacciatori-raccoglitori (prima raccoglitori stanziali nelle foreste, poi cacciatori nomadi nelle praterie, infine anche orticoltori, intenti a bruciare per uno o due anni piccole porzioni di foresta); in secondo luogo quello degli agricoltori e allevatori (decisamente stanziali i primi, spesso nelle zone più impervie del pianeta; viceversa, ancora nomadi o seminomadi i secondi, sempre in conflitto con gli agricoltori a motivo della recinzione dei campi). I due stili di vita hanno potuto coesistere per molto tempo, in quanto il numero degli abitanti mondiali era esiguo, gli spazi immensi e gli agricoltori avevano occupato zone fluviali acquitrinose, paludose, con imponenti fiumi soggetti a periodiche esondazioni, in grado di fertilizzare in maniera naturale il terreno. Si parla infatti di “civiltà fluviali”. (10) Il lavoro dell'agricoltore consistette nel canalizzare le acque, nel bonificare le paludi, nel produrre in maniera sistematica i cereali, nel creare agglomerati urbani in grado di organizzare tutta la produzione e distribuzione delle derrate. L'allevamento di caprini, ovini, bovini, suini... nasce contestualmente a questo nuovo stile di vita. I bovini arriveranno a essere impiegati nell'uso dell'aratro.
Esiste lo schiavismo in queste civiltà? In un primo momento no, ma si pongono tutte le premesse materiali perché si formi. Le date le conosciamo: il Neolitico agricolo si sviluppa nel 10-12000 a.C. Quando nasce la schiavitù? Se si guarda il Codice babilonese di Hammurabi dovremmo dire nel II millennio a.C., ma esso si riferisce a un'istituzione consolidata e del tutto comune tra i popoli dell'antichità. Infatti essa era già conosciuta tra le prime civiltà fluviali, come p.es. quella dei Sumeri in Mesopotamia, risalente al 3.500 a.C. Quindi possiamo dire che la schiavitù, in alcune aree del pianeta, ha circa 6000 anni di storia. (11)
Dunque cosa è avvenuto nel periodo compreso tra i 10-12000 anni a.C. e i 6000-5500 a.C.? Secondo Quinterna si è sviluppato un comunismo “urbano” (che per questa ragione non può essere definito “primitivo”), organizzato in maniera centralizzata (con stoccaggio di tutto il raccolto agricolo), sostanzialmente di tipo “distributivo-egualitario”, in quanto mancavano il denaro come equivalente universale e il mercato delle merci (se non quello tra città, che però era più che altro una forma di baratto delle eccedenze gestita da personale incaricato dallo Stato): in una parola c'era solo il valore d'uso. Non essendoci alcuna proprietà privata (in quanto al massimo la terra veniva concessa dal sovrano in usufrutto (12)) né una divisione “sociale” del lavoro, ma solo “tecnico-funzionale”, non vi era alcuna stratificazione sociale (se non quella per funzioni e non per ceti o classi), alcun tipo di discriminazione (neppure quella di genere!). Il produttore era padrone dei propri mezzi produttivi. A livello politico non esistevano monarchie o dinastie ereditarie né forme di autoritarismo, che non fossero una pura e semplice applicazione della legge. La stessa parola “Stato” non aveva nulla di ciò che qualifica quello moderno, nato a partire dal Cinquecento. Le funzioni amministrative erano revocabili in qualunque momento.
Riepiloghiamo con un'affermazione centrale di “n+1” questa curiosa interpretazione dei fatti: “non esiste un confine preciso tra le società pre-classiste e quelle di classe. La lotta della società per la conservazione del comunismo primitivo, paradossalmente, ha successo solo quando riesce a darsi un proprietario collettivo che amministra la società in modo centralizzato, producendo e distribuendo alla maniera antica ma organizzata secondo nuovi modelli quantitativi (surplus agrario)! (n. 27/2010). I paradossi, si sa, sono amati da chi ha una visione estremistica della vita. Chiunque però è in grado di accorgersi che se non esiste un “confine preciso” tra le suddette società o civiltà, si può dire, di entrambe, ciò che si vuole, persino qualcosa di “paradossale”, come p.es. che le società “pre-classiste” (ma sarebbe meglio dire “castali”) fossero quanto di meglio si potesse desiderare, una volta scoperta l'agricoltura, per conservare il comunismo primitivo. Anzi, si arriva addirittura a far capire che là dove c'è agricoltura c'è comunismo “sviluppato”; altrimenti bisogna parlare di comunismo “primitivo”, cioè spontaneistico, istintivo, di piccoli gruppi itineranti poco significativi, incapaci a “dominare” la natura.
Quindi gli antagonismi sociali, per Quinterna, maturano soltanto dopo, quando il proprietario collettivo al governo si accingerà a realizzare la transizione alla società classista. Lo Stato sarà l'artefice della distruzione della società civile. Motivo di questo comportamento schizofrenico? Il fatto di volere sempre di più, di non accontentarsi dell'economia del dono e del baratto, ma di pretendere metalli pregiati (oro e argento). Lo schiavismo nasce in seno al comunismo urbanizzato, così come il comunismo futuro sta nascendo in seno al capitalismo avanzato. Non è curioso che si dica una cosa giusta, come la seguente (se riferita al comunismo primitivo), senza capire che diventa subito falsa se applicata in un contesto diverso come quello delle civiltà fluviali? L'autosostentamento è “un sistema che possiede meccanismi di autoregolazione in grado di assorbire fluttuazioni e controllare eccessi e carenze” (n. 28/2010). Le società di tipo “asiatico” erano superiori in quanto si puntava più sull'equilibrio (omeostatico) che non sulla crescita.
Peccato che in questa analisi non si veda il rovescio della medaglia: l'equilibrio era ottenuto grazie alla sottomissione generalizzata della popolazione, pretesa da una casta di intellettuali. Le stesse carenze economiche venivano risolte in modo tutt'altro che “pacifico”: la guerra è una costante di tutte le società urbanizzate che, basando la propria ricchezza sull'agricoltura, erano inevitabilmente portate ai commerci e a ingrandirsi a spese altrui.
Il modello urbanistico di futura città comunistica, fatta salva l'odierna tecnologia, pare essere, nelle valutazioni di “n+1”, la Gerico di almeno 8000 anni anteriore alla nascita di Cristo (in Cisgiordania), quindi la città più antica della storia. Dagli scavi sono emerse tracce importanti di insediamenti circostanti del periodo epipaleolitico (tra il 18000 e il 12500 a.C.); sono stati trovati reperti appartenenti alla cultura natufiana (tra il 12000 e il 10500 a.C.) e reperti del periodo neolitico preceramico (tra l'8000 a.C. e il 7200 a.C.).
Nel 6850 Gerico era in grado di ospitare 2000 persone. Vi si praticavano caccia, pesca, orticoltura, agricoltura e allevamento di capre e pecore. Come religione aveva il culto dei morti, era ben fortificata e con una gestione centralizzata delle risorse e delle funzioni; era totalmente priva di proprietà privata, di classi sociali e aveva un'organizzazione statale completamente diversa da quelle attuali, con cui, peraltro, poteva costruire opere imponenti con attrezzi poco sviluppati. Raggiunse la sua maggiore estensione tra il 1700 ed il 1550 a.C. Verso il 1250 a.C., secondo la narrazione biblica del Libro di Giosuè, la città fu invasa e rasa al suolo dagli ebrei guidati dal condottiero Giosuè, successore di Mosè, anche se attualmente la maggioranza degli studiosi ritiene che l'ultima occupazione del luogo durante il tardo Bronzo è del XIV sec. e, da allora fino al sec. IX, non si verificarono ulteriori stanziamenti. Quindi, al tempo di Giosuè, nessuno viveva a Gerico. (13) La città fu comunque ripetutamente distrutta e ricostruita. Non è da escludere che sia stata proprio questa città, posta in uno snodo cruciale tra oriente e occidente, tra settentrione e meridione, a influenzare le successive civiltà basate sul “dispotismo asiatico”, pur restando essa una città-stato, senza mai diventare un “regno”. (14)
Abbacinata dalle teorie tecnologiche dell'archeologo Vere Gordon Childe (15), la redazione non vuole ammettere alcun antagonismo sociale interno a queste civiltà antiche, almeno fino alla nascita dello schiavismo: non solo riguardo a Gerico, ma anche in riferimento a Uruk dei Sumeri (16), Ebla, Mehrgarh, Harappa, Mohenjo-daro e a tutte le città egizie, ecc. Praticamente nel VII-VI millennio a.C. l'umanità avrebbe vissuto, secondo la rivista, un periodo d'oro (in senso comunistico) in un'area che va da dall'Iran all'Egitto, dalla Turchia al Golfo Persico (la cosiddetta “Mezzaluna fertile”), che poi includerà anche l'America centrale e alcune zone indo-cinesi. In genere si preferisce sostenere che tali società furono distrutte da eventi esterni, o naturali (climatici, alluvionali, ecc.) o militari, in quanto esistevano società commerciali bellicose. Persino dell'impero romano viene detto che se non fosse stato per le invasioni barbariche, avrebbe conservato il proprio “equilibrio”!
Così facendo però ci si lascia sfuggire la differenza tra “schiavismo privato” e “servaggio statale” (quest'ultimo è sempre tributario e basato sul pluslavoro, quello con cui si realizzeranno i grandi monumenti), e non si comprende né il ruolo mistificante della religione ai fini della realizzazione del “comunismo urbanizzato” (in origine le figure del sovrano e del sacerdote coincidevano, così come il tempio col palazzo in cui si compivano sacrifici e si stoccavano le derrate), né il fatto che l'ufficializzazione dello schiavismo, circa 6000 anni fa, non fu altro che la formalizzazione di una serie di discriminazioni sociali di molto anteriori, sviluppatesi in maniera crescente, di cui la prima, la più semplice, fu quella di genere, come ben documentano tutti i miti più antichi.
In sostanza, secondo “n+1” le migliori espressioni del comunismo primitivo non sono avvenute nel periodo paleolitico della caccia-raccolta (che pur è durato alcuni milioni di anni), in cui le comunità erano di piccole dimensioni e totalmente dipendenti dalla natura (economia acquisitiva), ma nel periodo agricolo-pastorale del Neolitico, in cui si cominciò a “dominare” la natura e a creare federazioni o leghe tra proto-città, con necropoli e centri culturali in comune. La grandiosità dei monumenti non dipendeva affatto da alcuna forma di schiavitù né di lavoro coatto: semplicemente gli operai e gli artigiani erano persone libere che accettavano un lavoro provvisorio, difficile e ben remunerato in prodotti naturali. (17) Naturalmente la costruzione di opere imponenti, l'osservazione dei cieli, la contabilizzazione degli ammassi di cereali comportarono la nascita della scrittura e della matematica.
La data della fine di tale comunismo viene spostata dalla redazione verso il periodo della nascita dello schiavismo in Grecia, successivo persino alla fase minoico-micenea. (18) Quindi, sotto questo aspetto, nessuna civiltà antica può essere stata “schiavistica”: non lo furono gli Egizi e neppure gli Incas e i Maya, né gli abitanti della Valle dell'Indo o quelli della Mesopotamia, e così via.
La redazione arriva addirittura a sostenere che in Egitto, durante il periodo pre-dinastico e quello delle prime dinastie, non poteva esistere la schiavitù in quanto i prigionieri di guerra venivano uccisi! Col che però si dà per scontato che il cosiddetto “comunismo primitivo” degli Egizi era, sin dagli inizi, molto bellicoso. In ogni caso non è vero che, nella fase espansiva, i prigionieri venissero uccisi: in realtà venivano schiavizzati. Al massimo diventavano soldati mercenari, riscattandosi dalla schiavitù col servizio delle armi. In Egitto gli schiavi esistono sin dalla I dinastia: persino i sacerdoti venivano detti “schiavi” di questa o quella divinità. Uno dei re di questa dinastia si vantava di aver preso 120.000 prigionieri nel Basso Egitto. La lotta tra Alto e Basso Egitto è il filo conduttore che spiega tutta la storia del Primo Regno.
Si può anche pensare che i primi canali d'irrigazione lungo il Nilo siano stati scavati da persone libere, ma lo sviluppo su larga scala del sistema d'irrigazione esigeva una considerevole quantità di manodopera, sicché il lavoro doveva per forza diventare obbligatorio. E sarà sulla base di questo lavoro che si costruiranno le piramidi e tutti gli altri monumenti. L'indigenza della popolazione rurale era già molto grave al tempo della IV dinastia. Anzi, proprio sotto questa dinastia persino i sacerdoti potevano possedere schiavi personali, seppur non in proprietà ma concessi in usufrutto dal sovrano come retribuzione per i riti.
Neppure è vero che l'esercito non fosse permanente. Già nel Medio Regno lo era, e molto duro era l'addestramento, che peraltro avveniva sin dalla più tenera età. In un testo del Nuovo Regno è detto che “per ogni lieve trasgressione il suo corpo viene battuto come un papiro. Deve abituarsi anche a portare carichi più pesanti della soma di un asino e a bere acqua putrida... tutto ciò in previsione delle lunghe marce nelle assolate terre siriane”. Se uno disertava veniva inflitta a lui la morte e ai suoi genitori la condanna al lavoro forzato nelle miniere. Generalmente i soldati potevano contare su ricche ricompense e partecipare alla divisione del bottino di guerra; e quando si ritiravano dal servizio ottenevano delle terre da coltivare.
Viene offerta da “n+1” una descrizione della storia egiziana quanto meno edulcorata. In pratica gli Egizi, non essendoci il denaro, si accontentavano di ciò che avevano. Quando avevano bisogno di oro, legname o lapislazzuli, organizzavano una spedizione per procurarseli nel “deserto” (!) o presso altri popoli, ai quali facevano “un dono talmente grande da non poter essere rifiutato” (n. 27/2010). A parte queste affermazioni dal sapore vagamente “mafioso”, è indubbio che la società egizia fosse fondamentalmente basata sui tributi in natura, richiesti sia internamente che nelle colonie. I faraoni praticavano l'imperialismo sui Paesi confinanti.
Non è comunque vero che non conoscessero l'uso del denaro. A partire dalla XVIII dinastia (1552-1305 a.C.) vi fu uno strumento di scambio basato sui metalli: il deben, che poteva essere d'oro, d'argento o di rame. Se l'uso di questo metallo come mezzo di scambio nel Nuovo Regno non incise sull'economia agricola del Paese, fu solo perché in assenza di proprietà privata dei mezzi produttivi non si sviluppano i mercati. Ma questo non vuol dire che la “democrazia” o l'“uguaglianza sociale” fossero maggiori.
È quanto meno idilliaco sostenere che il faraone “è una divinità fra le altre (e non un uomo autoproclamatosi divino come succederà in Mesopotamia, in Grecia e a Roma); non ha alcuna possibilità di adoperare l'autorità suprema per legiferare, far eseguire o giudicare. Egli è 'servo di Maat' ed esegue ciò che prescrive la tradizione” (n. 27/2010). Sotto questo aspetto la redazione ritiene perfettamente giusta l'avversione del clero politeista all'eresia monoteistica di Amenofis IV. Nulla però viene detto, da parte della redazione, del fatto che i faraoni della I dinastia (cioè quelli più vicini all'ex comunismo primitivo) erano già così crudeli da richiedere persino il sacrificio di alcuni funzionari di corte, di servi e di artigiani per averli al loro servizio nell'oltretomba.
Quanto alla natura divina del faraone si è completamente trascurato il fatto ch'egli era l'unico sommo sacerdote, cioè l'unico vero intermediario tra gli uomini e le divinità, l'unica persona che poteva accedere alle cerimonie più sacre officiate nei templi: la classe sacerdotale che eseguiva i riti lo faceva soltanto dietro sua delega. La monarchia egizia era una regalità sacra e onnipotente a tutti gli effetti. I nobili (spesso familiari del sovrano), il visir (scelto tra i nobili) e i funzionari svolgevano mere funzioni di supporto. Il concetto di “divinità faraonica” decadde solo nel cosiddetto Periodo tardo (672-332 a.C.), quando gli Assiri, occupato l'Egitto, imposero al faraone di rinunciare al titolo di sommo sacerdote (il ruolo di mediatore religioso fu assunto direttamente dai funzionari chiericali locali).
Vi sono altri aspetti significativi che la redazione trascura o sottovaluta o interpreta in maniera distorta, conseguenti al fatto ch'essa non vede alcuna violenza nell'appropriarsi dei beni altrui in politica estera e si rifiuta di definire “burocratica” un'amministrazione statale dei beni comuni, è inutile dilungarsi. (19)
1) Non è interessata allo studio del mito per capire la transizione dal comunismo primitivo allo schiavismo, quando invece sarebbe stato fondamentale farlo, poiché la nascita dell'agricoltura è strettamente connessa alla nascita di nuove religioni, tutte politeistiche. (20) Gli elementi del comunismo primitivo sono stati usati in maniera mistificata dalle società agricole, servendosi appunto di miti e religioni. È del tutto inutile sostenere che noi occidentali non abbiamo neppure adeguate categorie per interpretare delle società che non erano classiste come le nostre e che quindi non usavano le parole come le intendiamo noi. In realtà non può esistere alcun passato che ci impedisca di darne un'interpretazione corretta. La stessa redazione di “n+1” ritiene di non avere dubbi sulla validità delle proprie affermazioni, neppure quando sostiene che nell'antico Egitto non vi era una monarchia assolutistica, in quanto il faraone si considerava un “dipendente del cosmo”, preposto a tenere le cose in ordine! (21)
2) La redazione sembra non comprendere che nella fase storica iniziale dell'antagonismo sociale il rapporto tra padrone e schiavo (o servo) non poteva avere alcunché di “personale” ma solo di “istituzionale” o di “statale” proprio perché la memoria del comunismo primitivo era ancora molto forte (e anche perché a un certo senso solidaristico costringevano le condizioni geograficamente difficili dell'ambiente da urbanizzare). La privatizzazione di questo rapporto (la sua estremizzazione) è stata una caratteristica della cultura europea o mediterranea, che sul piano logistico rappresentava un'area periferica di due grandi continenti confinanti, e che però porterà alla nascita del più grande impero schiavistico della storia, quello romano. È quindi assurdo sostenere che nel modo di produzione asiatico non poteva esserci alcuna forma di schiavismo e che l'unica vera schiavitù fu quella greco-romana. In tal modo non si riesce a distinguere lo schiavismo “statale” o “pubblico” da quello “privato” (se non piace la parola “schiavo” si possono usare le parole “servo”, “sottoposto”, “suddito”: la sostanza cambia solo se il “padrone” è istituzionale o privato o anche associato in forma privata).
Così viene scritto nel n. 28/2010: “La forma cosiddetta asiatica è l'estensione di una società precedente ancora comunistica, in cui struttura e sovrastruttura coincidono, non essendoci ancora separazione tra valore d'uso e valore di scambio, ed essendoci armonia tra produzione e riproduzione dell'uomo e della sua comunità”. La redazione salva la forma asiatica proprio perché vi vede “un involucro che corrisponde al suo contenuto”. Ecco a quali sviste può portare un'analisi meramente strutturale degli eventi, incapace di tener conto dell'importanza dell'ideologia e del suo impatto sull'economia. Tutti i cosiddetti modi di produzione asiatici hanno avuto religioni naturalistiche, collettivistiche e fatalistiche che hanno giustificato degli Stati centralizzati, gestiti da una ristretta élite di potere.
3) Quando si afferma che nelle società antiche pre-classiche non vi era divisione sociale del lavoro in quanto era assente la proprietà privata dei mezzi produttivi, si sta trasformando il concetto di “proprietà statale” (che viene fatta arbitrariamente coincidere con quella “pubblica” o “sociale”) in qualcosa di feticistico, cioè come una sorta di assoluta garanzia contro ogni forma di antagonismo sociale. In nome di questa proprietà statale viene minimizzato arbitrariamente il ruolo del sovrano: si arriva addirittura a sostenere che fosse “eleggibile”, una sorta di “primus inter pares”, coadiuvato da amministratori revocabili, la cui autorità era distribuita secondo le funzioni, senza alcun “gioco di potere”.
In realtà l'autorità naturale dei capi-tribù e dei consigli degli anziani non viene affatto “superata” nelle proto-città, bensì ipostatizzata, cioè resa indipendente dalla volontà popolare. Di qui la corruzione di tutte le autorità, i tentativi del clero e dei funzionari locali di rendersi indipendenti dal sovrano, la razzia delle tombe e il continuo malcontento popolare, che in Egitto, partendo sin dalla V-VI dinastia, proseguì fino alla morte dell'ultimo sovrano tolemaico, esacerbandosi ancor più, ovviamente, sotto l'imperialismo romano.
4) La redazione sembra non avere alcuna consapevolezza della pericolosità di poter ammassare quantità significative di scorte alimentari. Non è forse l'eccedenza che ad un certo punto determina la formazione di un ceto preposto a “controllarla”, il quale non si preoccupa di svolgere alcun vero lavoro produttivo? Non vi sono già qui, in questa tentazione di gestire le cose dall'alto, in maniera esclusiva o “in nome del popolo”, i germi dell'involuzione autoritaria di tutte le città antiche? L'aumento esponenziale delle riserve da stoccare non è forse in grado, ad un certo punto, di generare una nuova mentalità, un diverso stile di vita? La redazione si limita a dire che le società proto-urbane distrussero il proprio comunismo solo verso l'età del bronzo, ma questa è un'epoca assolutamente troppo recente. Anche ammesso e non concesso che in tali società non vi fossero i cosiddetti “segni del potere” (palazzi, templi, tombe reali, caserme, monumenti celebrativi...) e che la mobilità sociale fra uno strato sociale e l'altro fosse sempre possibile, resta il fatto che le basi del superamento del comunismo primitivo si pongono semplicemente “uscendo dalle foreste” e avventurandosi nelle savane e nelle praterie. Con ciò non vogliamo sostenere che l'agricoltura in sé abbia creato lo schiavismo, però è un fatto incontestabile che lo schiavismo (prima statale in Asia, Africa e America, poi privato in Europa occidentale) s'impone solo là dove c'è l'agricoltura e quindi la stanzialità. Che in queste forme di “socialismo statale”, prive di proprietà privata dei mezzi produttivi, non si possa parlare di “schiavitù” come quella greco-romana, non toglie nulla al fatto che si fosse in presenza di una “servitù generalizzata”, gestita da una casta di intellettuali rappresentata da un sovrano assolutista. Lo schiavismo privato del mondo greco-romano non sarebbe stato possibile realizzarlo come “sistema” se non fossero esistiti in precedenza dei rapporti servili-tributari gestiti dallo Stato.
5) “La caccia, la raccolta e il nomadismo, che comportano lo spostamento di intere tribù-nazioni, sono attività altamente dissipative in relazione alla quantità di energia in gioco, anche se alterano relativamente poco il rapporto uomo-ambiente” (n. 27/2010). Questo quello che Quinterna pensa del “vero” comunismo primitivo, esistito ben prima delle civiltà antiche così tanto esaltate.
Ora, a parte che il rapporto uomo-ambiente non era “alterato” per niente nel periodo del Paleolitico, ci si chiede se davvero si debba dare per scontato che un'intera tribù dovesse trasferirsi altrove per le esigenze della caccia: non era forse sufficiente un gruppo di cacciatori? In ogni caso quando lo si faceva, le abitazioni non venivano forse smontate e ricostruite con molta facilità? Il nomadismo non ha forse in sé maggiori possibilità di garantire la democrazia all'interno di un gruppo tribale o clanico? Che senso ha sostenere che le società paleolitiche vanno rifiutate in quanto avevano “un rendimento basso”? E che le città neolitiche furono in grado di unire per la prima volta “efficacia ed efficienza”? Per quale motivo bisogna usare criteri così tipicamente “borghesi”? Il capitalismo non ha forse un alto rendimento? Eppure è enormemente dissipativo, come d'altronde la stessa rivista ammette. Le civiltà antiche non furono forse responsabili di tante deforestazioni per cuocere i mattoni per le loro abitazioni, per forgiare armi da guerra nei forni, per realizzare navi di ogni tipo? Là dove si formano le città, antiche o moderne, attorno ad esse scompaiono le foreste. Le città producono solo desertificazione.
Che senso ha osannare le società neolitiche per essere state capaci di garantire la produzione agricola e la distribuzione in maniera centralizzata e poi contestare duramente la realizzazione dello stalinismo, quando nella sostanza (quella organizzativa) si voleva la medesima cosa, cioè uno Stato centralizzato? Non è affatto vero che “l'esigenza dell'organizzazione e della centralizzazione nasce per conservare i rapporti comunistici anche quando la società è florida e può permettersi un surplus, il quale a sua volta permette la specializzazione tecnica, la contabilità e la scrittura” (n. 27/2010). Se questa tesi fosse vera, noi avremmo che in un primo tempo i leader politici di queste società avrebbero svolto funzioni democratiche, cui però avrebbero rinunciato in un secondo tempo, pretendendo di governare arbitrariamente sul popolo. E come si sarebbe potuto scongiurare, oggettivamente, una involuzione del genere? Quali sono le condizioni materiali che meno favoriscono l'emergere di rapporti conflittuali? Non le abbiamo forse vissute per due milioni di anni?
Si può anche ammettere un periodo di transizione dal cacciatore-raccoglitore all'agricoltore-allevatore in cui non fossero presenti dei rapporti antagonistici, ma la storia ha dimostrato che là dove si sono imposte le civiltà fluviali o le città-stato, basate prevalentemente su agricoltura e allevamento, col tempo si sono formate delle stratificazioni sociali sempre più nette, al punto che non si è più riusciti a tornare indietro, almeno non in maniera progressiva o pacifica. Il surplus ottenuto da agricoltura e allevamento ha indotto a creare delle città commerciali, intenzionate a diventare sempre più grandi, sempre più ricche, e quindi ad assumere atteggiamenti sempre più aggressivi. È del tutto inutile sostenere, come fa “n+1”, che tali società, se fossero rimaste isolate, accontentandosi dell'economia del dono e del baratto, sarebbero rimaste inalterate per millenni, avendo piena capacità di autoregolarsi. Di fatto nessuna società urbana nella storia dell'umanità ha mai scelto l'isolamento. Semmai lo fanno ancora oggi le società di cacciatori-raccoglitori per evitare il colonialismo occidentale.
In realtà sarebbe meglio sostenere, anche perché si sbaglierebbe di meno, che l'organizzazione centralizzata delle civiltà antiche rientra da subito nella categoria dell'“antagonismo sociale”. Quel tipo di organizzazione non serviva affatto per conservare il comunismo primitivo, ma proprio per negarlo, facendo vedere che non vi era soluzione di continuità tra i due sistemi sociali di vita. In realtà, come evidenza esteriore di una precisa rottura, la religione era lì a testimoniarlo, la prima ideologia (necessariamente prescientifica) che l'umanità si sia data per giustificare la rinuncia al comunismo primitivo. Non ha alcun senso sostenere che l'impero di Sargon, di Tuthmosi III, di Ramses II non erano imperi come possiamo intenderli oggi, poiché non avevano classi, interessi economici in conflitto, uno Stato che opprime la società, dei territori occupati militarmente. Proprio Sargon, "re-sacerdote delle quattro parti", cioè dell'intero mondo conosciuto, fondò il concetto di “regalità” non più sulla spersonalizzata gestione amministrativa tipica dei Sumeri, ma su un ideale eroico-militare. Quello accadico fu il primo vero impero della storia, il primo organismo multietnico, capace di assoggettare quasi l'intera Mesopotamia per circa 150 anni e di tenere relazioni commerciali con tutta l'Asia. Un impero lacerato da congiure di palazzo e dall'anarchia.
Il genere umano non è caratterizzato da una progressiva evoluzione verso il meglio, ma da un'involuzione sempre più tragica. Di fronte alle contraddizioni antagonistiche si è cercato di porvi rimedio, ripristinando qualcosa del passato comunismo, ma i risultati sono stati molto deludenti, non solo perché altamente provvisori, ma anche perché sulla base di essi si sono costruite delle alternative conflittuali ancora più difficili da superare. È aumentata la sofisticazione degli strumenti di dominio e la mistificazione con cui si è capaci di usarli.
6) A volte si ha l'impressione che “n+1” non sia in grado di comprendere la differenza sostanziale tra “casta” e “classe”. Infatti quando nega l'esistenza delle classi, nelle società antiche non ancora basate sullo schiavismo come sistema economico, tende a negare anche quella delle caste. In realtà la casta è perfettamente compatibile con un “socialismo statale” (antico e moderno) – come la storia ha dimostrato –, essendo composta da funzionari governativi o amministrativi, nonché da militari, oltre che ovviamente dai politici e da tutto il parentado dei sovrani. (22) Tutta questa gente non svolge alcun lavoro “produttivo” in senso economico, ma solo un lavoro legislativo, giudiziario, sanzionatorio, poliziesco, militaresco, propagandistico e ideologico: tutti lavori che una società basata su caccia e raccolta avrebbe giudicato assurdi, inutili, anzi pericolosi.
Oggi, quando si parla di "caste", s'intende qualcosa che riguarda prevalentemente l'India e si pensa ch'esse risalgano alla penetrazione degli Arii (o Indoeuropei) in questo Paese nel corso del secondo millennio a.C. Inizialmente il meccanismo castale fu usato per tener separati i ruoli dei dominatori da quelli dei dominati, classificando le persone sulla base delle loro occupazioni; in seguito però le caste sono divenute ereditarie. A dir il vero la casta è un concetto molto più antico, strettamente collegato alla religione, che può imporsi anche in società in cui non sono presenti il denaro e il mercato urbano, ma solo scambio alla pari delle eccedenze, fatta salva, in politica interna, la subordinazione della campagna alla città.
Al tempo delle città o civiltà neolitiche (quelle del regime di produzione cosiddetto “asiatico”) vi erano anche commerci in denaro tra città-stato, ma generalmente il commercio estero era monopolizzato dalle istituzioni. I mercanti erano funzionari statali. Era troppo forte la paura che si formasse una classe sociale capace di rendersi autonoma dal controllo del potere politico. Anche nell'alto Medioevo europeo mancavano il denaro, il mercato e la borghesia, ma non per questo mancava la casta dei nobili laici ed ecclesiastici, la quale, avendo in proprietà privata la terra, si configurava anche come una classe sociale.
Dunque, se si vuole sostenere che lo Stato sia nato prima della formazione delle classi, non si può sostenere ch'esso sia nato prima della formazione delle caste. Lo Stato non è nato per tutelare una giustizia distributiva di risorse alimentari, organizzata in maniera centralistica, ma perché le caste, la cui ricchezza è sempre stata basata sulla terra, pensarono che con uno Stato centralista il loro potere sarebbe stato assicurato per il futuro, anche a costo di dover attribuire al sovrano dei poteri sovrumani. All'origine della “civiltà” vi è sempre un atto arbitrario, come documentano tutti i miti nati in contesti urbani. Lo Stato serve per garantire un'egemonia pregressa. Se sotto il socialismo statale antico si rinuncia alla proprietà privata delle terra, lo si fa solo perché il sovrano sa benissimo che se non la concedesse liberamente in usufrutto alla casta, il suo potere sarebbe costantemente minacciato. La rinuncia alla proprietà privata, in società del genere, faceva parte dell'ideologia utilizzata per ingannare la popolazione lavoratrice, che non voleva rinunciare al comunismo primitivo. È proprio a partire dal Neolitico che inizia a formarsi una casta (inizialmente con funzioni religiose), la quale rivendica un potere particolare, reso subdolo dalla religione, con cui può contrapporsi all'intero popolo. In ogni caso i cosiddetti “nomarchi” non erano – come vuole “n+1” – dei semplici funzionari amministrativi che gestivano le province egiziane, ma costituivano anche una potente aristocrazia schiavistica, in possesso privato di enormi ricchezze, tant'è che potevano venderle, lasciarle in eredità o regalarle. Sotto la IV dinastia tutta questa nobiltà era in buona parte imparentata col faraone.
Viceversa, lo Stato dei regimi schiavistici che abbiamo conosciuto in Europa occidentale, è nato per regolamentare i conflitti tra classi che avevano interessi opposti tra loro e che volevano conservare il potere o conquistarlo in quanto classe e, all'interno di questa, in quanto individui singoli: ci riferiamo alle classi agrarie, mercantili, contadine, operaie, artigiane e così via. Di tutte queste classi, quella che riuscì a compiere una rivoluzione assolutamente inedita nella storia, scoppiata intorno al Mille, fu la classe borghese, che seppe sfruttare il progressivo acuirsi delle contraddizioni sociali dovute alla rendita agraria, utilizzando il cristianesimo a favore del mercantilismo. La borghesia diede una risposta sbagliata, perché individualistica, a un problema reale, che solo i contadini avrebbero potuto risolvere, ripristinando il comunismo primitivo, ma non seppero farlo. Da allora il capitalismo borghese non ha fatto altro che svilupparsi in maniera forsennata, a dispetto di tutti i conflitti bellici, le epidemie e mutamenti climatici causati dalle devastazioni ambientali.
Lo Stato come amministrazione pubblica del bene comune è una contraddizione in termini. Non ha senso che il bene economico primario, quello del cibo, venga reso “comune” da una volontà particolare, quella appunto della casta, che pretende di rappresentare una volontà popolare attraverso la mediazione assolutistica del sovrano e l'uso mistificato della religione.
Quando la distribuzione delle risorse dipende da una volontà particolare, per quanto riconosciuta collettivamente nella sua funzione autorevole, esiste sempre la tendenza a usare quelle risorse in modo arbitrario, oppure tende a formarsi una volontà oppositiva alla direzione centralizzata, che nel peggiore dei casi porta a realizzare una società basata sull'antagonismo privato. Ecco perché non può esistere alcuna vera democrazia in un contesto urbano, dove i cittadini non vanno a caccia e non praticano orticoltura, agricoltura e allevamento, ma campano sulle spalle di chi fa questi lavori fuori dalle mura urbane. In città la vicinanza più prossima ai propri strumenti lavorativi è vissuta da operai e artigiani, provenienti sempre dal mondo contadino. La città, in sé, esprime una divisione sociale del lavoro che ha addirittura connotati logistici: il che la rende particolarmente alienante.
Là dove esiste un surplus regolare (il limo lasciato dal Nilo permetteva tre raccolti l'anno!), le cui variazioni quantitative accidentali non minano l'efficacia del metodo produttivo per ottenerlo, emerge sempre il desiderio di usare tale eccedenza come dono per motivi d'interesse, oppure di scambiarlo con beni, giudicati essenziali, di cui si difetta per motivi ambientali; finché poi viene l'esigenza di venderlo, quando tra le comunità s'impone una moneta di valore (oro, argento, bronzo, rame) che svolga la funzione di equivalente universale. Il vero baratto, quello che non mina l'autonomia di una comunità, dovrebbe avvenire solo con uno scambio di beni giudicati superflui, cioè non essenziali alla propria sopravvivenza. Al di fuori di questo caso, qualunque surplus, prodotto in maniera sistematica, può essere occasione di conflitti: p.es. quando si dona si pretende un “contraccambio”, in mancanza del quale si pensa subito a qualche intenzione minacciosa; quando tali beni si scambiano beni giudicati essenziali, si pretende il loro progressivo aumento quantitativo, al fine di soddisfare una crescente domanda interna; quando vengono venduti, si vuole realizzare il massimo possibile, a qualunque costo, poiché si è consapevoli che il potere economico fa aumentare quello politico.
Sotto questo aspetto, l'unica vera differenza tra lo schiavismo statale e quello privato sta nel fatto che il commercio, nel primo sistema, è un monopolio dei sovrani e dei loro funzionari: i mercanti non possono fare ciò che vogliono. Per poterlo fare, in Europa occidentale, la borghesia ha dovuto inventarsi una serie infinita di princìpi etici, religiosi, filosofici, giuridici e politici che sul piano umano e democratico dovevano apparire di altissimo livello, altrimenti le motivazioni individualistiche sarebbero state considerate immediatamente contrarie agli interessi nazionali. Viceversa, nel modo di produzione cosiddetto “asiatico”, se è giusto parlare di “dispotismo” in riferimento alla compagine governativa, la collettività continuava ad avere ancora sentore delle passate tradizioni comunistiche.
L'ideologia più assurda della classe borghese occidentale fu interamente applicata al concetto di “libertà personale”: per poter fruire di questa libertà occorre essere giuridicamente liberi (cioè non servi né schiavi), occorre avere una proprietà privata, che renda economicamente autonomi, senza accontentarsi di quella pubblica, e occorre credere che il lavoro sia fonte di valore. Un'ideologia assurda per il semplice fatto che per realizzare tutto questo occorre “sfruttare” il lavoro altrui.
Da tempo vari antropologi, come ad esempio Giulio Angioni (allievo e collaboratore di Ernesto de Martino e di Alberto Mario Cirese, esponente della Scuola antropologica di Cagliari) e Philippe Descola (titolare della cattedra che fu di Claude Lévi-Strauss al Collège de France), hanno evidenziato come non esista un legame diretto tra l'adozione di una nuova tecnica o di un nuovo strumento lavorativo e un aumento della produttività. Questo perché le attività produttive sono connesse a un insieme di condizioni sociali che ne determinano il valore intrinseco. La relazione che si instaura tra l'uomo e la materia, inerte o viva, si deve poter rappresentare a partire dall'insieme delle relazioni (pre)esistenti all'interno di una totalità sociale tra l'uomo e la materia. Ognuno capisce da sé che se esistesse il primato del valore d'uso, scomparirebbe del tutto il concetto di lavoro come fonte di valore. Il valore dei beni sarebbe dato dal contesto che li usa, a prescindere dalla possibilità di scambiarli o venderli.
Da dove veniva alla borghesia il concetto di “lavoro” come fonte di valore se non dalle società asiatiche (o dall'Egitto faraonico), che lo vivevano come “tributo in natura”? All'epoca dei cacciatori-raccoglitori non esisteva neppure il “lavoro” in senso proprio. Non era il lavoro che dava “valore” alle cose. Il valore era dato dalla comunità nel suo insieme, che sostanzialmente non “lavorava” come facciamo oggi. Non c'era nessuno a cui dover “rendere conto”. Il lavoro non era “produttivo”, quello che serve per far “quadrare i conti”, quello misurato quantitativamente in rapporto al tempo e statisticamente secondo una media calcolata in rapporto all'età, alla forza fisica, all'abilità delle mani, ai prezzi di mercato e così via. Il lavoro era puramente “acquisitivo”, basato su raccolta e caccia: si toglieva provvisoriamente alla natura una piccola parte di ciò che essa offriva spontaneamente e le si permetteva di riprodurla in maniera agevole. Caccia e raccolta non era “produttive” proprio perché non producevano surplus. Al massimo lo era l'orticoltura, ma in forma limitata, in quanto si doveva permettere a una piccola parte della foresta, temporaneamente disboscata, di ricrescere. Soltanto là dove s'impone la stanzialità, resa necessaria dalla presenza dell'agricoltura, sorge anche inevitabilmente la necessità di “lavorare”. La nuova ricchezza, ottenuta dal surplus alimentare, ha sempre come conseguenza logica una deforestazione e quindi una desertificazione dell'ambiente, quindi un mutamento climatico e delle conseguenze nocive sul proprio fisico, non adatto a vivere in luoghi del tutto artificiali. (23)
Insomma la redazione non ha fatto altro che proiettare nel passato un tipo di comunismo statalizzato che vorrebbe veder realizzato nel futuro. Giustifica le civiltà antiche dicendo che “ogni sistema complesso tende al caos... Raggiunto uno stato di instabilità che le comunità non possono più tollerare, la crisi viene superata soltanto aumentando il livello di complessità, ma con un ordine di tipo nuovo” (n. 27/2010). In realtà la storia (di lunga durata) dimostra proprio il contrario, e cioè che quando la complessità diventa insopportabile, la società tende ad autodistruggersi (salvo scaricare all'esterno, con l'uso della guerra, il peso delle proprie insanabili contraddizioni), oppure viene distrutta da altre società che non sopportano la sua presenza, fino al punto in cui non s'impone una decisiva semplificazione delle relazioni sociali.
Non ha alcun senso sostenere che la storia del genere umano va divisa in società completamente comuniste e altre tendenzialmente comunistiche in quanto contenenti elementi di socializzazione che le fanno somigliare a quelle del passato. Non si può scambiare la realtà con la propria fantasia. Non solo con l'agricoltura ma anche con l'introduzione dei metalli s'impone nella storia qualcosa di radicalmente diverso dal passato paleolitico. Che poi questa diversità sia stata vissuta inizialmente in una forma che potremmo definire “feudale-statale” e che solo in seguito si sia imposta come “privata-commerciale”, non cambia nulla. Oggi il comunismo primitivo non esiste più, se non in qualche sperduto luogo del pianeta che Monsieur Le Capital non è ancora riuscito a sfruttare. Madame la Terre è stata detronizzata 10.000 anni fa.
Anche i riferimenti che la rivista fa a Marx sono del tutto forzati. Non è vero che Marx, parlando delle società precapitalistiche si riferiva a uno stadio tribale inferiore a quello della Cina, dell'Egitto antico, del Messico e delle civiltà mesoamericane. Quando inizia a fare questo egli era nell'ultimissimo periodo della sua vita. Prima di allora intendeva riferirsi proprio al modo di produzione asiatico (specie a quello dell'India colonizzata dagli inglesi). Non pubblicò niente di definitivo perché non aveva sufficienti materiali da analizzare, ma aveva già chiaro che le forme comunitarie del modo di produzione asiatico erano state le più tenaci nell'opporsi allo sviluppo del capitalismo non in virtù di aspetti positivi, ma proprio a causa del fatto che l'individuo veniva praticamente sacrificato sull'altare dell'interesse collettivo, che a sua volta era imposto o tenuto entro certi limiti dal potere autocratico. Queste forme poterono opporsi al capitalismo solo perché questo si trovava ancora allo stato embrionale; in seguito però, non avendo esse mutato fisionomia, saranno destinate a soccombere. Semmai Marx non riuscì ad analizzare l'apporto che i fenomeni sovrastrutturali diedero alla persistenza di quelle società tributarie, dove i lavori collettivi erano coatti. Per il resto egli aveva già capito che in quelle società si era abolito il comunismo primitivo conservandone però l'apparenza: cioè se dal punto di vista della proprietà collettiva vi era qualcosa di apparentemente “comunistico”, dal punto di vista della stratificazione sociale non vi era più nulla, anche se ciò non favorì il processo d'individualizzazione dell'uomo, come appunto avvenne nelle società classiste occidentali. (24)
Forse l'unica domanda sensata che possiamo rivolgerci è la seguente: può durare di più una società servile basata sulla proprietà privata o su una proprietà statale dei mezzi produttivi? Guardando la storia, dovremmo dire che lo schiavismo statale è durato di più. Ma dobbiamo anche dire che i maggiori progressi tecnologici sono avvenuti sotto lo schiavismo privato, come d'altronde era naturale che fosse, in quanto la reciproca concorrenza, la competizione individualistica stimola la ricerca di strumenti sempre più efficaci per imporsi. Questi mezzi sembrano garantire nel breve periodo una superiorità schiacciante (come fu p.es. quella romana), almeno finché i progressi tecnici non vengono acquisiti da quelle società che invece preferiscono uno schiavismo statale. Grazie a questi mezzi l'Europa occidentale, che ha inventato il capitalismo privato, domina il mondo intero da molti secoli. Ma oggi il testimone sembra stia per essere ceduto a una potenza asiatica, la Cina, specializzata nello “schiavismo statale”, una potenza che unisce, in forma inedita, la presenza di proprietà statale di tutta la terra col mercantilismo individuale. Il socialismo che tende a sostituire il capitalismo privato del mondo occidentale è un socialismo mercantile o, se si preferisce, un capitalismo statalizzato. Probabilmente si passerà da una forma di schiavitù salariata privata a una forma di schiavitù salariata statalizzata, dove il salario tornerà ad essere, per la stragrande maggioranza delle persone, in natura.
Ecco ora un breve riassunto della storia politico-militare della civiltà egizia, che può servire a capire quanto siano improprie talune affermazioni della rivista “n+1” su tale civiltà.
Generalmente nei manuali scolastici si sostiene che i due regni, Alto e Basso, dell'Egitto vennero unificati con la forza militare in una guerra civile, verso il 3100 a.C., in un solo impero da Narmer (o Menes in greco), re dell'Alto Egitto, che inaugurò le trenta dinastie, con cui gestire in maniera esclusiva le acque del Nilo, sottraendole alle tribù paleolitiche e neolitiche (la coltivazione del grano, dell'orzo e del lino risale come minimo al 3500 a.C.). A lui infatti si deve un vasto programma di drenaggio delle acque e di sistemi di irrigazione. Narmer pose le basi per una monarchia assolutista, ereditaria e teocratica, anche se già con la II dinastia iniziò una nuova guerra civile (le piramidi pretese dai sovrani nella IV dinastia dovevano appunto servire per indurre la popolazione a sentirsi unita in un progetto nazionale). Il faraone era “il figlio del dio Sole” e doveva sposarsi solo con membri di sangue reale, quindi si trattava generalmente di matrimoni tra parenti. La prima colonia di Narmer fu conquistata nella terra di Canaan in Palestina, ma già nella IV dinastia ci si espande verso la Nubia e la Libia, dove era relativamente facile acquisire degli schiavi. La più antica iscrizione geroglifica è la Tavoletta di Narmer, databile al 3000 a.C. circa, in cui viene testimoniata la bellicosità di questo re guerriero.
Una prima fase di sfaldamento completo del potere centrale a favore dei governatori provinciali, i nomarchi, avviene nel cosiddetto “Primo periodo intermedio”, che copre gli anni che vanno dal 2160 al 2055 a.C. e comprende le dinastie VII, VIII, IX e X.
Nel Regno medio (2055-1790) i faraoni della XI dinastia, tornati a egemonizzare l'intero Paese, assoggettano Nubia e Palestina. Ma nel 1730 gli Hyksos, provenienti da oriente, conquistano l'Egitto per 150 anni, grazie alla superiorità militare, ma anche approfittando di una serie di rivolte e divisioni interne al regno. Durante la dominazione degli Hyksos una popolazione nomade ebraica entra in Egitto. Dagli Hyksos gli Egizi apprendono l'uso del cavallo, del carro da combattimento e delle armi in ferro; così nel Regno nuovo (1530-1080), dopo un conflitto trentennale, i faraoni riconquistano il Paese. Sottomettono Etiopia, Palestina, Fenicia, Siria, Babilonia e Assiria. Fermano l'avanzata dell'impero ittita nella battaglia di Kadesh del 1275, con cui si pone fine a una lunga serie di guerre tra i due regni.
Dal 1375 al 1350 il faraone Amenofi IV tenta d'imporre un culto monoteistico, che però non sopravvive alla sua morte, a causa dell'ostilità del potente clero politeista. È probabile che da questa riforma fallita sia nato il tentativo di proseguirla, da parte di Mosè (sacerdote egizio) col popolo d'Israele, che non uscì dall'Egitto in maniera pacifica.
Nel 663 la capitale Tebe viene conquistata dagli Assiri, sicché nella Bassa epoca (663-525) i faraoni rinunciano alle conquiste, limitandosi a promuovere un'intensa attività commerciale con Greci e Fenici. I Filistei sottraggono all'Egitto la Palestina. Nel 525 i Persiani di Cambise uccidono in battaglia il faraone Psammetico III, riducendo l'Egitto a una loro provincia. Quando nel 331 Alessandro Magno, conquistando l'impero persiano, giunge in Egitto, viene accolto come liberatore e fonda la nuova capitale Alessandria. Alla sua morte l'immenso impero da lui conquistato viene diviso tra i suoi generali: Tolomeo ottiene l'Egitto, che includeva la Palestina e la Siria. L'indipendenza verrà definitivamente persa con l'arrivo dei Romani.
Note
(1) Cfr il testo riepilogativo di Vito Bongiorno edito su “Marxismo oggi” nel settembre 2015.
(2) Sumeri e Ittiti già 4000 anni a.C. usavano il ferro per piccoli oggetti come punte di lancia e gioielli. Con la Grecia classica si verificò il passaggio dalle armi in bronzo a quelle in ferro. L'Età del Bronzo in Europa si colloca tra il 3500 e il 1200 a.C. circa.
(3) Su questo ho già scritto varie cose in Marx economista e in Cinico Engels, ed. Amazon. Il testo di Marx in lingua italiana è Quaderni antropologici, ed. Unicopli, Milano 2009. Si veda anche A. Schmidt, II concetto di natura in Marx, ed. Laterza, Bari 1969.
(4) Non dimentichiamo però il nome del venezuelano Rodolfo Quintero (1903-1985), uno dei maggiori esponenti dell'antropologia marxista in America Latina, soprattutto per i suoi studi sull'Antropologia petrolifera e su quella delle città latinoamericane. Stranamente, inoltre, non è stato tradotto nulla di significativo in italiano dell'antropologo e sociologo marxista francese Jean Copans, specialista in Africa nera e co-fondatore della rivista “Politique africaine” nel 1980. Pochissimo tradotte in italiano sono anche le opere di José R. Llobera, antropologo cubano naturalizzato inglese.
(5) È noto che l'antropologia marxista sia stata influenzata dalla rilettura strutturalista del Capitale di Marx operata da Althusser (1966). La sua analisi, infatti, partiva dall'assunto che nei sistemi economici vi sono strutture che tengono insieme in maniera organica le forze produttive, la tecnologia e persino la religione, senza che ciò possa essere ricondotto a un piatto determinismo economico. Non solo, ma le “formazioni sociali” non sono caratterizzate da un unico modo di produzione, ma piuttosto da un'articolazione di diversi modi.
(6) Godelier criticò molto anche la separazione operata da Lévi-Strauss tra la forma delle relazioni sociali e le loro funzioni, in forza della quale il “simbolico”, ricostruito artificiosamente, trionfava sul reale (visibile) e si perdeva l'insieme delle relazioni.
(7) Cfr di lui Antropologia religiosa: introduzione al problema e campioni di ricerca, ed. Newton Compton, Roma 1984; Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, ed. Boringhieri, Torino 2001; La nera signora: antropologia della morte e del lutto, ed. Newton & Compton, Roma 2001. Su di lui invece cfr Antropologia e storia delle religioni: saggi in onore di Alfonso M. di Nola, a cura di A. De Spirito e I, Bellotta, ed. Newton & Compton, Roma 2000.
(8) Quinterna è favorevole a una transizione comunista che utilizzi il meglio della tecnologia capitalistica. Vede tale transizione come conseguenza non della completa dissoluzione del capitalismo, ma, al contrario, del suo pieno sviluppo contraddittorio.
(9) Attenzione che questo non vuol dire che la stanzialità sia stata successiva al nomadismo. Non si può escludere il fatto che all'interno delle foreste i primi uomini siano stati stanziali e che abbiano iniziato a praticare il nomadismo appena ne erano usciti. Solo che la stanzialità interna alle foreste, ricche di alimenti a portata di mano, non poteva portare ad accumulare un surplus, che è invece tipico della stanzialità agricola.
(10) Non a caso tutti gli studiosi, di qualunque disciplina, parlano di “civiltà” per intendere qualcosa che si distaccava chiaramente dal modo di vivere neolitico, paleolitico o genericamente "primitivo". Il periodo e il luogo originario di riferimento, per le civiltà, è quello Calcolitico (età del rame) nel Medio Oriente, ivi inclusi elementi forti di civiltà riscontrati in alcuni siti archeologici dell'Armenia, della Grecia e nell'altopiano della Persia, per non parlare delle culture asiatiche dell'Estremo Oriente, lungo le vaste vallate fluviali, specialmente quella dell'Indo nell'Asia centro-meridionale (odierno Pakistan) e del Fiume Giallo in Cina. Non è da escludere che la grande migrazione asiatica avvenuta 13.000 anni fa verso il continente americano fosse dovuta proprio alla presenza di strutture “schiavili” o “servili” in Cina e India, le quali strutture però furono riproposte dalle civiltà mesoamericane e andine (inca, maya e azteca). Da notare però che secondo le ricerche di Luigi L. Cavalli-Sforza i primi esseri umani sono arrivati nel continente americano circa 40.000 anni fa utilizzando lo stretto di Bering via mare. Di sicuro si sa che la Beringia è rimasta emersa solo tra 25 e 10.000 anni fa.
(11) Se si esige la scrittura come prerequisito per definire la “civiltà”, allora la prima "culla" dello schiavismo (in forma statalizzata) è la civiltà sumerica, seguita dal periodo arcaico dell'Egitto (prima dinastia). Ma se si guarda la sola agricoltura, allora i primi segni di un processo di sedentarietà possono essere rintracciati nelle regioni attorno al Mediterraneo già dal 12000 a.C., quando la cultura natufiana divenne sedentaria e cominciò a evolvere verso una società agricola attorno al 10000 a.C. Se si prende come punto di riferimento la ceramica, bisogna risalire addirittura a un periodo compreso tra il 17100 e il 14500 a.C. in Cina e Giappone. Tuttavia la svolta verso il superamento definitivo del comunismo primitivo è avvenuta solo con la fusione del rame, verso la fine del V millennio a.C. La fusione di qualunque metallo comporta sempre pesanti deforestazioni (per arrivare al carbone, con cui fondere il ferro, ci vorrà la rivoluzione industriale). Ma sarà solo a partire dall'età del bronzo (circa 3300 a.C.) che le guerre diverranno interminabili.
(12) La rivista (n. 27/2010), di fronte a questa concessione della terra in comodato d'uso, è costretta ad ammettere che venivano consegnati anche i contadini che la lavoravano, benché, pur di non ammettere la presenza del servaggio, anteponga a ciò l'avverbio “probabilmente”.
(13) Gerico, prima conquista degli Israeliti sotto il comando di Giosuè, fu rasa al suolo e tutti gli abitanti uccisi, ad eccezione della famiglia di Rahab, una prostituta che aveva ospitato le spie ebraiche. Il giudizio che gli ebrei davano di Gerico era analogo a quello su Babilonia.
(14) Montesquieu per primo, nello Spirito delle leggi e nelle Lettere Persiane, considera il "dispotismo asiatico", basato sulla paura e sul potere arbitrario del sovrano (come in Turchia e Cina), una forma autonoma di governo, e non più una semplice degenerazione rispetto a monarchia e repubblica, come voleva Aristotele. In tal senso esso poteva applicarsi anche alle nazioni europee, p.es. alla Francia del suo tempo. Cfr Domenico Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, ed. Liguori, Napoli 2002.
(15) Gli unici testi di Childe presi in esame sono stati La rivoluzione urbana e Il progresso nel mondo antico.
(16) Uruk fu il primo insediamento umano a prendere la forma di una città, con tanto di stratificazione sociale e specializzazione del lavoro. Posta a 20 km ad est del fiume Eufrate, in una regione meridionale dell'attuale Irak, aveva un territorio arido per le piogge scarse e irregolari, ma anche perché le acque del fiume scorrevano disordinatamente, favorendo le inondazioni. A ciò si rimediò inventando l'irrigazione, con cui distribuire l'acqua del fiume a tutta la pianura coltivata. Fu abitata dal IV millennio a.C. al V sec. d.C. Contava una popolazione di circa 80.000 abitanti (la maggiore del mondo). Fu la città dello storico re Gilgameš, famoso eroe di un'epopea (2600-2500 a.C.) che influenzerà gli scritti biblici del peccato adamitico e del diluvio universale. Coeva di Uruk è Ur, la città da dove emigrò l'allevatore Abramo. Attorno al 2350 a.C. il prestigio di Uruk inizia a declinare, perché conquistata dagli Accadi di Sargon, il primo popolo a realizzare un impero (poi fu la volta dei Gutei, dei Babilonesi, degli Assiri...). D'altra parte il regno sumerico fu sempre debole, in quanto composto da città-stato indipendenti tra loro, governate dal proprio re-sacerdote, in lotta tra loro per la questione idrica. Il più grande tempio di Uruk aveva una struttura con cui saranno costruite, dopo tre millenni, le chiese cristiane. Qui fu ideata la più antica forma di scrittura (cuneiforme) intorno al 3200 a.C. Applicarono per primi la ruota ai trasporti di terra. Misuravano il tempo col sistema sessagesimale ed erano molto avanzati in campo matematico. Elaborarono un calendario lunare di dodici mesi di trenta giorni ciascuno e produssero le prime cosmogonie.
(17) È noto che l'idea che le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino fossero state costruite da “lavoratori oppressi” fu formulata per la prima volta da Erodoto, che visitò l'Egitto intorno al 450 a.C., circa 2000 anni dopo la loro costruzione. È stato intorno al 1990 che, sulla base di alcuni scavi archeologici, si arrivò a scoprire che l'edificazione delle piramidi fu opera di cittadini comuni, di cui alcuni erano precettati, a rotazione, e altri ingaggiati a tempo pieno. Questi operai e artigiani erano talmente rispettati che quando uno di loro moriva sul lavoro veniva seppellito con tutti gli onori vicino alla piramide. Non solo, ma a dimostrazione che questa “follia” aveva un carattere nazionale, risulta da prove certe che le grandi famiglie del Delta del Nilo e dell'Alto Egitto inviassero ogni giorno 21 vitelli e 23 montoni per nutrire i lavoratori. Il problema resta comunque un altro: il fatto che dei sovrani avessero bisogno di costruire opere così colossali o che decine di migliaia operai fossero impiegati per buona parte della loro vita e in una maniera particolarmente faticosa a costruire edifici del tutto inutili alla loro vita privata, può essere considerato un segno di “democrazia”? O forse si preferisce evitare di rispondere a questa domanda, limitandosi a constatare che quelle costruzioni furono comunque spettacolari?
(18) La società minoica, a differenza di quanto sostiene “n+1”, non aveva tracce del comunismo primitivo, in quanto era una società palaziale e tributaria, con un re-sacerdote e con miti tendenti a sminuire il ruolo della donna. Essa è all'origine della civiltà europea.
(19) In questa valutazione della burocrazia “n+1” sposa le tesi di J. Needham (Scienza e società in Cina) contro quelle del sinologo marxista K. Wittfogel (Il dispotismo orientale). Quest'ultimo cercò di spiegare la natura delle società statuali asiatiche sulla base della propria "teoria idraulica", subendo gli influssi di K. Marx e M. Weber. Nel 1951, in piena guerra fredda, divenne un convinto anticomunista, arrivando persino a denunciare come “filo-comunista” l'ambasciatore canadese (eminente storico del Giappone) Egerton Herbert Norman davanti al Sottocomitato per la Sicurezza Interna del Senato americano. Pur essendo difeso dalle autorità canadesi e pur non essendoci prove certe che fosse una spia sovietica, Norman si suicidò a Il Cairo nel 1957, mentre svolgeva un ruolo chiave come diplomatico tra il leader egiziano G. A. Nasser e le potenze occidentali, preoccupate di un'intesa troppo stretta dell'Egitto con l'URSS. Le ragioni del suicidio sono ancora avvolte nel mistero. Wittfogel, in seguito, si pentì amaramente del suo gesto.
(20) Nel n. 28/2010 viene esaltata la filosofia taoista: “produzione senza possesso, azione senza autoaffermazione, sviluppo senza dominio”, ponendola come sovrastruttura adeguata al modo di produzione asiatico. Si dimentica però di aggiungere che il taoismo veniva affiancato dal confucianesimo: il primo rappresentava l'idealismo astratto, il secondo invece l'atteggiamento concreto da tenere nei confronti delle autorità. Entrambe erano filosofie favorevoli a uno Stato centralizzato e classista.
(21) Sarebbe bastato prendere in esame il poema di Gilgamesh, non meno interessante di quelli omerici, non foss'altro perché in esso risulta chiarissimo (forse perché scritto molto tempo prima dell'Iliade) che la civiltà urbanizzata si era formata allontanandosi dalle foreste, nei cui confronti si provavano sentimenti molto controversi. Già dalla Tavola I si comprende bene il livello delle contraddizioni sociali vissute a Uruk, i cui sudditi si lamentano dell'oppressione del loro re Gilgamesh e chiedono al dio An, sovrano del firmamento, di far nascere un oppositore. Viene così creato Enkidu, l'uomo selvaggio che vive con gli animali nella steppa. Siccome si tratta di un mito “proto-urbano”, Enkidu viene dipinto non solo come colui che potrà tenere a freno la smisurata potenza di Gilgamesh, ma anche stargli accanto nei momenti di pericolo (un nemico che può diventare amico). Enkidu però deve essere prima educato alla civiltà. A questo compito provvede la prostituta sacra Shamkhat, che gli insegna le basi della vita cittadina prima di condurlo a Uruk (si noti peraltro che la sessualità, in tanti miti antichi, viene sempre usata per screditare il ruolo della donna e imporre il patriarcato).
(22) Ancora oggi in Asia la grande maggioranza degli Stati è riluttante a riconoscere dei diritti territoriali ai popoli indigeni. Non a caso molti di questi popoli, più che lottare per ottenere una parziale autonomia, preferiscono la secessione.
(23) Un ettaro di terreno coltivato – viene detto in J. Diamond, Armi, acciaio e malattie (ed. Einaudi, Torino 1998) – nutre da 10 a 100 volte più contadini che cacciatori/raccoglitori se incolto. Naturalmente nel medio-breve periodo.
(24) Gli appunti etnologici di Marx risalgono a poco tempo prima della morte, ma quando egli risponde alla famosa lettera della Vera Zasulič (1881), si era già letto nel 1877 Ancient Society di L. H. Morgan, regalatogli dall'etnografo russo M. Kovalevsky; conosceva bene anche le opere etno-antropologiche di J. W. B. Money (1861), H. S. Maine (1875), J. B. Phear (1880), R. Sohm (1880), J. Lubbock (1882) sull'origine delle civiltà, e l'opera di storia del diritto di G. L. von Maurer sulle comuni germaniche primitive, pubblicata nel 1865-66. Il capitolo sul feticismo della merce, nel Capitale, gli era stato ispirato dal testo di Charles de Brosses, Du culte des dieux fétiches (1760), letto nel 1841. Per scrivere il capitolo sulle “Forme che precedono la produzione capitalista”, presente nei Lineamenti della critica dell'economia politica (1857-58) si era letto, nel 1851, un testo di W. Coke sulla storia naturale della società negli Stati barbari e civilizzati e un testo di H. H. Bancroft sugli indiani nordamericani. Engels invece non era minimamente interessato al comunismo primitivo, però poi quando vide nell'archivio di Marx, appena deceduto, i suoi quaderni etno-antropologici, scrisse, nel 1884, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, traendone conclusioni abbastanza diverse da quelle di Marx. Infatti per quest'ultimo l'esistenza del comunismo primitivo andava completamente ripensata, soprattutto a causa del primato assoluto del valore d'uso su quello di scambio; per Engels invece l'esistenza di un comunismo del genere non metteva affatto in discussione ch'esso andasse superato dallo schiavismo, a partire dal quale nascono le civiltà progredite.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube