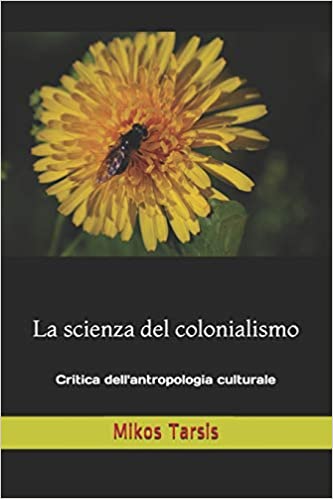
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Chi è l'uomo?
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Alla domanda, tipicamente filosofica, “Chi è l'uomo?”, l'antropologia va (o è andata) a cercare, fisicamente e materialmente, la risposta in popoli molto diversi da noi occidentali, in luoghi remoti, che conosciamo solo attraverso delle letture o visti in qualche documentario televisivo, che apparentemente paiono “incontaminati” dalla nostra presenza, o comunque poco influenzati dal nostro stile di vita. Essa cioè compie una cosa che i filosofi di un tempo generalmente non facevano, essendo più che altro dei docenti universitari, delle persone sedentarie, o dei soggetti intenzionati a migliorare il luogo in cui operavano (migliorarlo in senso politico o giuridico o economico), senza interessarsi granché di ciò che non riguardava direttamente l'Europa, benché questa fosse già un continente colonialistico. I filosofi han sempre vissuto in maniera astratta, intellettualistica. Gli etno-antropologi davano invece l'impressione di essere delle persone più concrete, disposte a sacrificare, per almeno un anno, gli agi della vita borghese, pur di avere delle situazioni reali da esaminare in prima persona.
Il problema però è che l'antropologia, pur avendo, a causa del colonialismo, maggiore consapevolezza di quel passato che l'occidente ha definitivamente abbandonato, anzi caparbiamente rimosso, usando forme e metodi per lo più violenti, non riesce a trovare alcuna risposta significativa alla suddetta domanda. Parte con le migliori intenzioni e se ne ritorna più ignorante di prima. Nel migliore dei casi l'antropologo è una persona frustrata, in quanto, pur avendo incontrato qualcosa di molto diverso dal nostro stile di vita, alla fine non sa che farsene. Sa benissimo di non poterlo proporre a nessuno, se non come una sorta di curiosità esotica, sul contenuto della quale oggi può realizzare un testo che lo favorirà nella carriera accademica o un documentario per la televisione o, al massimo, una sceneggiatura per un film. Nel peggiore dei casi (dal punto di vista etico) arriva addirittura a comportarsi come un ladro di opere d'arte primitive o comunque molto antiche, salvo poi lasciarle in eredità, in punto di morte, a qualche museo.
Attenzione a non considerare queste caratteristiche “borghesi” come tipiche del solo antropologo moderno. Se leggiamo i testi dello storico greco Erodoto (484-425 a.C.), forse il primo occidentale ad avere una mentalità etnologica, ci accorgeremo di quanti pochi dubbi avesse nel considerare il popolo cui lui apparteneva il migliore in assoluto, decisamente superiore agli stranieri “barbari”, incapaci di parlare il greco e che, per questa ragione, meritavano la sottomissione. Euripide addirittura usava le parole “barbaro” e “schiavo” come sinonimi. Aristotele invece era disposto a riconoscere il coraggio ai barbari d'Europa e l'ingegno a quelli asiatici, ma attribuiva entrambe le qualità ai soli Elleni.
Forse il primo che ha cominciato a mettere in discussione il primato assoluto della cultura europea, rispetto a qualunque altra cultura del mondo, è stato il teologo cattolico Bartolomeo de Las Casas (1474-1566), testimone diretto del genocidio delle popolazioni amerinde compiuto dagli spagnoli. Non a caso nello stesso periodo Michel de Montaigne (1533-92) cominciò a impostare il problema del relativismo delle culture, affermando nei suoi famosi Saggi: “ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi”. Col che anticipava di due secoli le riflessioni del grande Rousseau, che pur non esitò ad abbandonare i suoi cinque figli alla pubblica assistenza di Parigi.
Quando poi in Europa si faranno strada le relazioni di viaggiatori come Pietro Martire di Anghiera, di Girolamo Benzoni, di Filippo Sassetti, di Francesco Carletti, di Francesco Gemelli Careri, di Matteo Ricci (tutti esistiti tra il Cinquecento e il Seicento), preceduti nel periodo medievale da Marco Polo e da Ibn Khaldun, sarà impossibile, da parte dei filosofi, non affrontare l'argomento dell'alterità culturale. All'origine della moderna antropologia vi sono infatti le riflessioni del suddetto Rousseau, ma anche di Vico e del gesuita Joseph-François Lafiteau (1670-1740).
Anche Montesquieu, nelle sue Lettere Persiane (1721), mostrava d'essere del tutto favorevole al relativismo in merito alle credenze religiose: “I negri dipingono il diavolo d'una bianchezza abbagliante, mentre i loro dèi sono neri come il carbone”, scriveva. Nonostante ciò la sua tesi etnologica di fondo, secondo cui i caratteri delle varie popolazioni sono particolarmente determinati dai climi delle regioni in cui vivono, resta molto limitata.
Bisogna tuttavia constatare che questa sorta di relativismo culturale (rinvenibile anche ne L'ingenuo di Voltaire e nel Supplemento al viaggio di Bougainville di Diderot) era svolta, al tempo dell'Illuminismo francese, più che altro in funzione anti-ecclesiastica, cioè contro la cultura dominante della teologia cattolica: di fatto non ebbe mai alcuna conseguenza critica nei confronti della stessa società borghese.
Alla domanda “Chi è l'uomo?” la cultura borghese, sin dal tempo della nascita dei Comuni italiani, ha dato una risposta molto precisa: è l'uomo che fa affari. È possibile parlare di tutta l'etica che si vuole, è possibile avere le idee più sublimi di tutti i tempi, ma, in ultima istanza, ciò che conta è la proprietà, poiché solo su questa si può sviluppare un determinato senso della libertà. E per “proprietà” non s'intende tanto quella agraria, che quando nacque la borghesia era patrimonio degli aristocratici, ma quella mobile dei capitali, ottenuti attraverso i mercati, in cui si possono vendere merci prodotte con le macchine e lo sfruttamento di una manodopera salariata, giuridicamente libera.
Se l'antropologia non parte da questo presupposto storicamente inconfutabile, il suo contributo critico ai fini del superamento del capitalismo sarà sempre prossimo allo zero.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube