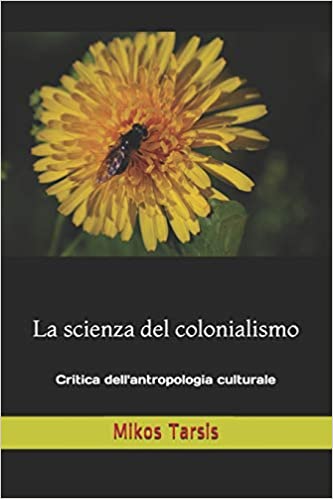
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
L'antropologia religiosa di Lévy-Bruhl
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Di Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), un filosofo, anzi un sociologo prestato all'antropologia (1), l'unico libro, scritto nel 1931, che ho preso in esame è Sovrannaturale e natura nella mentalità primitiva (ed. Newton Compton, Roma 1973). (2) Devo dire che è più che sufficiente per comprendere la sua antropologia religiosa, che non riesce a sottrarsi ai condizionamenti positivistici della sua epoca, se non in un aspetto di tipo etico: i primitivi – secondo l'autore – possono svilupparsi come gli occidentali solo se muta il contesto sociale in cui vivono; in attesa che ciò avvenga è del tutto sbagliato utilizzare le rappresentazioni collettive dell'uomo occidentale per interpretare sistemi logico-culturali così diversi dai propri. Le polemiche antimagiche di matrice evoluzionistica non aiutano a comprendere il mondo primitivo.
Egli ha l'impressione che il pensiero primitivo, da lui paragonato a quello dei bambini, sia basato interamente sulla religione e che quindi tutta la realtà non venga collegata a cause reali (o “seconde”), di origine fisica chimica biologica, ma pensata come l'insieme degli effetti di una causa divina o magica, intesa come “causa prima”, che rende irrilevante l'idea di distinguere il possibile dall'impossibile. Insomma, per pigrizia intellettuale o a causa delle scarse motivazioni offerte dall'ambiente, gli indigeni sono privi di “logica”. Il loro pensiero è “prelogico” (mistico), in quanto ignora i princìpi aristotelici basati sull'identità, la non-contraddizione e la causalità; inoltre non sa distinguere chiaramente la parte dal tutto, in quanto la parte può assumere la funzione dell'intero. Essi non hanno un'idea precisa neppure dell'individualità, poiché si sentono parte del gruppo in cui vivono.
Detto altrimenti: le rappresentazioni collettive dei primitivi sono dominate da una sorta di “fluidità”, e hanno alla base quella che Lévy-Bruhl definisce “legge di partecipazione”. Secondo tale legge, lo stato mentale dei primitivi è caratterizzato da un'estrema intensità emozionale che induce a una costante partecipazione mistica con l'universo. Il primitivo “sente” ciò che lo circonda come attraversato da una forza numinosa fluida, fisica e psichica. I confini che nel nostro mondo isolano nettamente l'uomo dall'ambiente esterno, la natura dalle forze soprannaturali, lo stato di veglia dallo stato di sogno, nel mondo primitivo sono estremamente labili o inesistenti. Dunque la mentalità primitiva, più che rappresentare l'oggetto, lo vive e ne è posseduta. Anche la personalità è rappresentata come “energia”, qualitativamente identica a quella che promana dagli animali, dalle piante e dalle cose, e i suoi limiti sono considerati evanescenti, tanto che l'identità personale non è incompatibile con la dualità o la pluralità delle persone: si può essere qui e altrove, se stessi e qualcos'altro. I concetti di tempo e spazio sono assolutamente relativi. Anche nel modo di calcolare sono approssimativi: non usando i numeri come gli occidentali, preferiscono affidarsi a espressioni generiche, come “molti, un sacco, parecchi”, oppure usano immagini concrete, come “i capelli della testa”, “le stelle del cielo”, “i granelli di sabbia”. D'altra parte in un mondo dove la matematica non serve per dominare, a che pro contare? (3)
Queste tesi, cui resterà fedele per quasi tutta la sua vita, erano già stata elaborate verso il 1910, in polemica con E. Burnett Tylor e J. Frazer, che gli apparivano troppo psicologisti, incapaci di vedere che il carattere prelogico della mentalità primitiva era qualcosa di organico a tutte le comunità indigene, vissuto in maniera collettiva, senza mai essere messo in discussione. L'antropologia borghese, soprattutto con Émile Durkheim, Marcel Mauss e Bronisław Malinowski, contestò le teorie di Lévy-Bruhl, sostenendo l'unità dello spirito umano e la sua omogeneità in tutte le epoche, e mostrando come nella vita quotidiana i primitivi applichino una razionalità pratica simile a quella che governa le azioni di tutti gli uomini della Terra. La forza di tali argomentazioni (che lo accusavano di razzismo, lui ch'era di origine ebraica (4)) indusse col tempo Lévy-Bruhl a rivedere in parte le sue posizioni più estreme. Infatti, come si constatò in una serie di quaderni stesi nell'ultimo periodo della sua vita, i Carnets, pubblicati postumi nel 1949, egli arrivò a dire che la mentalità mistica è presente in tutti gli esseri umani, persino nelle società occidentali, là dove si crede nei miracoli o negli oroscopi.
In realtà c'era di peggio nelle sue analisi e solo col tempo lo si capì. A Lévy-Bruhl infatti non venne mai in mente né che la religione fosse un aspetto del tutto secondario nella vita dei primitivi (tant'è che l'animismo e il totemismo si limitano a “divinizzare” la natura e non a crearsi della entità astratte ultraterrene, per cui si può tranquillamente dire che i primitivi fossero in realtà “atei”), né che le manifestazioni mistiche potessero essere un riflesso condizionato dal colonialismo europeo, nei cui confronti quelle comunità si sentivano impotenti (5), né che la stessa cultura occidentale non fosse affatto esente da una forma laicizzata del medesimo misticismo, in forza dei successi della scienza e della tecnologia, considerati indiscutibili e venerati come una forza umana divinizzata, né che le rappresentazioni collettive distorte (p.es. razzistiche) sono una caratteristica soprattutto delle società occidentali e non di quelle primitive.
L'autore sostiene che il primitivo, con la sua mentalità mistica, è in grado di spiegarsi ogni fenomeno naturale, per cui, a modo suo, potrebbe anche essere considerato “razionale”. Come se il fatto di dare un senso a ogni fenomeno naturale non possa essere un atteggiamento appartenente anche a una persona folle! O, al contrario: come se il fatto di poter capire scientificamente i fenomeni naturali implicasse l'impossibilità ad assumere atteggiamenti irrazionali! L'autore rimase impressionato dal fatto che con una partecipazione emotiva alla cognizione delle cose, il primitivo fosse in grado di conciliare ogni contraddizione. Come se un atteggiamento del genere non caratterizzi tutti i soggetti più discriminati delle civiltà basate sull'antagonismo sociale, i quali s'illudono di poter risolvere tutti i loro problemi senza compiere alcuna rivoluzione politica!
A volte si ha addirittura l'impressione che quando l'autore mostra che al primitivo, nell'ambito dell'approccio magico alla realtà, nulla è impossibile, è come se volesse dire all'uomo civilizzato che, nell'ambito dell'approccio scientifico alla realtà, le speranze di risolvere le contraddizioni sociali sono infinitamente superiori. Dunque se gli uomini primitivi sono felici nella loro ignorante ingenuità, perché mai gli occidentali sono sempre tribolati nella loro sapienza? Per quale ragione la scienza, in occidente, non riesce a risolvere i problemi vitali di tutte le categorie sociali? Forse l'unica risposta ch'egli riuscì a dare a questa domanda si trova nel suo primo libro, L'idea di responsabilità, del 1884, che non a caso fu dedicato al Kant più moralista e sentimentale.
Una risposta che ribadì, in chiave sociologica, in un libro successivo, La morale e la scienza dei costumi, del 1903. La sociologia deve limitarsi a individuare quali regole di comportamento sono necessarie tanto quanto le leggi di natura. Nel mondo primitivo queste regole sono basate sulla “partecipazione emotiva”, che nella cultura occidentale vengono subissate dalla razionalità. L'occidente sembra soffrire di una mancanza di empatia, così ben presente tra le comunità primitive, che però la vivono senza avere cognizione di causa dei fenomeni naturali.
Interessante, sotto questo aspetto, è il fatto che nella sua analisi lo studio dei primitivi viene considerato utile per comprendere l'uomo nelle sue varie sfaccettature culturali, evitando, nel fare ciò, di mettere delle graduatorie di merito, che potrebbero risultare fastidiose a chi non appartiene alla civiltà occidentale. Per lui i primitivi non sono “inferiori”, ma “diversi”, ugualmente dotati di spirito umanitario. Bisogna solo individuare i meccanismi che tengono in piedi le loro comunità autosufficienti. Tali meccanismi riflettono bisogni collettivi di tipo emotivo. Analisi sui comportamenti individuali non sono pertinenti. “Emotivo” vuol dire che bisogna prendere in esame i miti, i riti, le pratiche magiche, le feste, le credenze mistiche, ecc.
Naturalmente Lévy-Bruhl non può astenersi dal giudicare negativamente il fatto che il primitivo pensa che la credenza in forze “sovrannaturali” possa avere delle ripercussioni reali, fisiche, sulla sua vita quotidiana. Invece di chiedersi che senso abbia credere in un sovrannaturale religioso quando dovrebbe bastare credere nella natura, si meraviglia che i primitivi non riescano a fare differenza tra i due aspetti, e pensa che questa confusione sia determinata dal fatto che sono affetti da “misticismo religioso” e non dal fatto che considerano la Terra come una “Grande Madre”. Senza poi considerare che questo atteggiamento “mistico”, in forma laicizzata, è possibile, anzi inevitabile, anche nell'ambito del capitalismo, quando si fa dell'imparzialità dello Stato e del diritto, dell'autoregolazione del Mercato, dell'infallibilità della Tecnoscienza, della democrazia parlamentare, delle news dei Media (quando supportate da immagini), della superpotenza distruttiva delle armi nucleari... una rappresentazione di entità “sovrumane”, da cui non è possibile prescindere! Non è forse meglio confondere, come fanno i primitivi, ciò che si vede con ciò che non si vede, avendo però cura di non arrivare mai a forme di vita disumane o innaturali? Perché meravigliarsi del fatto che per i primitivi non esiste una linea di demarcazione tra il possibile e l'impossibile, quando con la stessa pretesa noi occidentali abbiamo fatto la rivoluzione tecnico-scientifica devastando l'intero pianeta? Non era meglio credere che quel limite si può superare solo nei sogni (quando è bello volare) o nelle danze estatiche (quando è bello stordirsi)? Che danni avremmo fatto alla natura o alla collettività?
Vi sono dei passi nel suo libro in cui sembra che il primitivo gli piaccia proprio perché, vedendo come coincidenti il reale e l'immaginario, assomiglia a un bambino innocente, puro, con gli occhi aperti sul mondo, tutto da scoprire, un mondo che insieme lo affascina o gli incute paura. L'idea che la mentalità primitiva non si preoccupi affatto di evitare la contraddizione, ma la sussuma in maniera emotiva, considerandola come un dato di fatto, lo intriga. In questa maniera non è affatto indispensabile ch'essa si logicizzi, come nella cultura occidentale. Perché dunque osteggiare la percezione di chi di non sa separare in maniera radicale il naturale dal sovrannaturale? In fondo si tratta soltanto di un modo diverso di guardare la realtà, che certo non può avere la raffinatezza del pensare europeo, anche perché non possiede gli strumenti scientifici adeguati per interpretare i nessi tra i fenomeni, ma che non per questo va ridicolizzato, osteggiato, come invece fanno gli agenti del colonialismo francese.
E pensare che qualunque credente del mondo occidentale, per quanto capace sia di distinguere nettamente la ragione dalla fede, è comunque disposto ad ammettere, nell'ambito della fede (soprattutto se cattolica o ortodossa), qualunque misticismo. Dunque dove sta la differenza nel modo di credere? A ciò si potrebbe aggiungere che nei Paesi protestanti, sebbene la ragione tendenzialmente prevalga sul misticismo, la figura del premier politico è spesso vista con un atteggiamento “mistico” da parte degli elettori, i quali si aspettano che sia in grado di risolvere i problemi più gravi della nazione.
Più interessante però di questi discorsi, il cui moralismo rischia di non portare da nessuna parte, è il fatto che, al dire di Lévy-Bruhl, ciò che i primitivi intendono per “sovrannaturale” non è qualcosa di affine a un “dio” onnipotente e onnisciente, ma a varie entità di forma umana o animale. Un atteggiamento, questo, ch'egli considera inferiore alle teologie razionalistiche sviluppatesi in Europa. In realtà andava considerato superiore, poiché, mentre tutte le teologie, di qualunque confessione, hanno sempre riflettuto gli interessi delle caste o delle classi dominanti, le religioni primitive, invece, generalmente totemico-animistiche, erano espressione di comunità egualitarie, quelle tipiche dei cacciatori-raccoglitori. Non erano animisti perché avevano scarse conoscenze scientifiche della natura, ma proprio perché le loro conoscenze erano il prodotto di sperimentazioni, di “prove ed errori” che si perdevano nella notte dei tempi.
Si può forse dire che le teologie europee, con tutta la loro razionalità, hanno, seppur involontariamente, favorito lo sviluppo delle conoscenze scientifiche della natura? Sì, è possibile dirlo, ma non hanno certamente favorito il recupero delle conoscenze ancestrali della natura che avevano i primitivi. I primitivi non erano privi di teologie perché non avevano “l'idea di un ordine della natura intellegibile” (p. 42), ma perché non avevano conflitti di casta o di classe da giustificare.
Se fosse arrivato a queste convinzioni, l'autore non si sarebbe limitato a dire che la mentalità mistica può caratterizzare, sotto vari aspetti, anche lo stile di vita occidentale, ma sarebbe addirittura arrivato a dire che una formazione culturale che si presume “razionale”, come quella europea, non è detto che abbia in sé elementi sufficienti per scongiurare atteggiamenti assolutamente irrazionalistici, come p.es. quelli accaduti durante le due guerre mondiali, di cui la prima vide lo stesso Lévy-Bruhl seguace dell'interventismo.
Nell'Introduzione del suddetto libro l'autore afferma che i primitivi “per proteggersi e difendersi posseggono tradizioni trasmesse dagli antenati... in cui hanno fiducia inattaccabile... Non viene loro in mente che una conoscenza più completa o più esatta delle condizioni in cui si esercita l'azione delle potenze invisibili suggerirebbe forse loro metodi di difesa più efficienti” (p. 34).
Che frase sciocca! E per quanti motivi! Che senso ha ritenere “inefficiente” il credere in tradizioni millenarie? Dire che i primitivi, che con tali tradizioni vivono da migliaia di anni (e hanno vissuto in tutta tranquillità fino alla colonizzazione europea), sarebbero molto limitati rispetto agli occidentali, giunti alla scienza più evoluta sin dai tempi della rivoluzione astronomica, non è forse un modo vergognoso, seppure indiretto, di giustificare il colonialismo europeo?
E poi perché dire che i primitivi non sanno cosa si perdono a non avere una scienza come quella occidentale, in grado di dimostrare tecnicamente i propri assunti teorici? Davvero avrebbero potuto vivere migliaia di anni solo in virtù del loro presunto “misticismo”? Non è forse questa, da parte dell'autore, una professione di malcelato razzismo? Il fatto che i primitivi non abbiano dei “dogmi” va considerato una conseguenza della loro natura “emozionale”? La natura, per loro, non va forse rispettata in maniera “dogmatica”? È stato forse un bene per la scienza occidentale assumere atteggiamenti “dogmatici” sulle proprie acquisizioni, mostrando così di non essere molto diversa dalle religioni che combatteva? Ma anche nel caso in cui si volesse fare dell'“emotività” qualcosa di prioritario nel proprio stile di vita (come spesso succede negli artisti), non si rischierebbe, così facendo, di finire nel campo dei dogmatici? E che dire del fatto che proprio l'emotività sia considerata, nelle società opulente, lo strumento principale in campo pubblicitario e per fare della stessa politica una forma di pubblicità?
E poi perché dire che la scienza aiuterebbe i primitivi a capire meglio da dove proviene “l'azione delle potenze invisibili”? Ha forse aiutato la moderna scienza a far diventare “atei” i credenti europei, i quali, non meno dei primitivi, credono nell'azione occulta delle “potenze invisibili” (poche o tante che queste siano)? Il Mercato, lo Stato, il Capitale... non sono forse dei Leviatani invisibili, delle astrazioni intellettualoidi, non meno coercitive di quelle teologiche? La scienza ci ha forse indotti a comportarci in maniera sempre razionale? È davvero giusto sostenere che un qualunque atteggiamento religioso è per sua natura tendente all'irrazionalità più di quanto possa esserlo un qualunque atteggiamento scientifico? Quando gli occidentali han preso a fare i colonialisti, non avevano forse obbligato i primitivi a sostituire il loro misticismo col misticismo delle religioni europee? Che cos'è che rende più “razionale” il misticismo delle confessioni religiose europee rispetto a quelle primitive? In che cosa sono “razionali” due confessioni, come quella cattolica e protestante, che son quasi sempre state in guerra tra loro?
L'autore riporta una descrizione della religione dei Papuani della Nuova Guinea redatta dall'antropologo finlandese G. Landtman nel primo decennio del Novecento, al fine di confermare la tesi che tra i primitivi non esistono idee sistematiche circa il mondo sovrannaturale. “Niente preti. Niente culto pubblico né preghiere o sacrifici. La concezione delle cose spirituali differisce alquanto persino da un individuo a un altro. Ciascuno è sacerdote di se stesso... L'idea di somma totale delle cose e dei fenomeni è assente. La natura, per loro, si compone di unità indipendenti le une dalle altre” (p. 43).
Mentre le prime frasi avrebbero potuto essere applicate a una qualunque corrente dell'evangelismo riformato, l'ultima invece ha qualcosa di ridicolo. Si tende ad applicare ai primitivi lo stesso modo che gli occidentali hanno di approcciarsi alla realtà sociale e naturale, che è sempre quello di giungere al tutto passando per le sue singole parti. I primitivi, essendo olistici di necessità, han sempre ragionato in maniera inversa: per loro il tutto esiste già, è la natura, che è un dato incontrovertibile; all'uomo non resta che farne esperienza nelle sue singole parti, che vanno salvaguardate nel loro insieme, essendo profondamente intrecciate. Di ogni singola cosa la natura garantisce l'integrità nel rapporto interdipendente con le altre cose. L'interezza è di molto superiore alla somma delle singole parti, anche perché viene vissuta in maniera istintiva, fidando in ciò che il passato ha da trasmettere. Se non fosse così, il dubbio tenderebbe a insinuarsi sull'evidenza dei fatti.
Ciò va considerato vero anche in riferimento alla vita della comunità di villaggio, la cui identità non è certamente data dall'insieme delle singole identità dei suoi componenti. Il concetto di “persona”, indipendentemente dal contesto sociale di riferimento, è una pura astrazione. Sentirsi “unici e irripetibili” verrebbe considerato un limite non un pregio: infatti alla morte di un soggetto del genere la comunità non saprebbe come sostituirlo, soprattutto se egli avesse posizioni di comando (che comunque, per fortuna, nelle società di cacciatori-raccoglitori difficilmente poteva avere).
Viceversa, gli occidentali hanno un approccio del tutto individualistico e intellettualistico alla realtà. Per comprenderla adeguatamente hanno bisogno di affidarsi ad analisi di tipo scientifico, che si avvalgono di strumenti d'indagine logico-matematici, chimico-fisici, ecc. Inoltre vivono costantemente nel dubbio che qualcuno li voglia ingannare. Purtroppo questa capacità di raggirare il prossimo, loro stessi l'hanno usata quando hanno cominciato a fare i colonialisti. L'incontro con gli indigeni è stato l'incontro tra una cultura abituata a mentire e un'altra abituata a credere, e si è svolto tra una cultura che si è approfittata della buona fede di chi le ha creduto, e un'altra che, per continuare a credere in se stessa, doveva imparare a mentire.
Semmai si sarebbe dovuto fare indagini su un altro filone di ricerca. Per es. quando i moderni europei, con la loro pratica colonialistica, hanno incontrato gli indigeni, questi ultimi, in genere, stavano vivendo la transizione dall'ateismo naturalistico primitivo a quelle forme di religione chiamate animistico-totemiche. Ebbene, da che cosa era determinata una transizione del genere? Come mai quando la comunità primitiva ammetteva l'esistenza di un “essere supremo”, spesso si era in presenza di rapporti schiavili (vedi ad es. le grandi civiltà pre-colombiane)?
Su questo però Lévy-Bruhl non è in grado di dire nulla di significativo. Infatti, invece di mettere il pensiero dei primitivi in rapporto a delle fasi storiche precedenti, lo paragona a quello dei credenti o degli scienziati occidentali a lui coevi. Vede le tribù primitive come se fossero sempre state uguali a se stesse. E, quel che è peggio, considera il pensiero primitivo sulla religione troppo scoordinato per non dover sottostare all'insegnamento “razionale” dei missionari europei. Vede però questo pensiero frammentario come un limite che i teologi, al seguito dei colonialisti affaristi e militarizzati, fanno fatica a far evolvere pacificamente, democraticamente, verso la vera “scienza”, non avendo sufficienti capacità pedagogico-persuasive.
Da un lato si meraviglia del “sentire comune” che avevano i primitivi, cioè del fatto che la loro rappresentazione della realtà fosse caratterizzata da categorie “affettive”, invece che logiche; dall'altro però non vede questo atteggiamento in rapporto a una forma d'esistenza molto più democratica di quella occidentale. È forse un caso che nel nostro linguaggio razionale abbiamo continuamente bisogno di definire il significato delle parole che usiamo, proprio perché pensiamo sempre al rischio d'essere fraintesi? Ed è forse un caso che nelle società basate sull'antagonismo sociale, quando non si riesce a far valere il proprio punto di vista, si accusi la controparte dicendo di non essere stato capito o di essere stato volutamente frainteso? Non è forse una caratteristica dello stile di vita borghese dire una cosa e farne un'altra, dando per scontato che ad ogni affermazione si possono dare mille interpretazioni diverse, nella consapevolezza che alla fine chi decide quale debba essere l'interpretazione più giusta non è la logica o il diritto ma la forza?
Neanche per un momento l'autore si sogna di dire che i colonialisti, pur con tutta la loro scienza, non erano riusciti a risolvere neppure uno dei problemi che avevano i primitivi. Gli interessa soltanto far notare che i primitivi, con la loro esistenza emotiva o prelogica, avrebbero qualcosa da insegnare allo stile di vita così irreggimentato degli europei.
L'autore, inoltre, si meraviglia che i primitivi siano molto dettagliati in ciò che concerne il culto dei morti (credenze, riti, cerimonie, offerte, sacrifici, suppliche...), ma si lamenta ch'essi non dicano nulla sulla “vera condizione” che i morti vivono “al di fuori delle loro relazioni coi vivi” (p. 35). Sembra che come parametro letterario di quali forme congruenti di premi e punizioni il cristianesimo riservi nelle sfere dell'aldilà, egli abbia in mente la Divina Commedia. Si può essere più ingenui? Si meraviglia che sull'esistenza ultraterrena i primitivi mostrino d'aver idee parziali e confuse, e che per questa ragione essi avrebbero delle credenze immotivate! Come se una motivazione logica potesse rendere più convincente una credenza religiosa!
Nel cercare di spiegare le credenze religiose dei primitivi l'autore non fa mai riferimento al colonialismo ch'essi erano costretti a subire. È forse un caso? Non mette mai in relazione la natura di quelle credenze, il modo di viverle alle forme di condizionamento sociale imposte dall'esterno. Egli non fa alcuna analisi storica o economica. Dalle sue pagine non si riesce neppure a capire se le tribù primitive di cui parla fossero state oppresse anche da popolazioni diverse da quelle europee. Sarebbe stato infatti importante sapere se le loro credenze erano davvero ancestrali o storicamente determinate.
Il suo è un atteggiamento nettamente kantiano, per il quale la conoscenza delle leggi della natura ci aiuta a difenderci dalle “diverse forze psichiche che agiscono su di noi”. E quali sarebbero queste “forze”? Vi è forse qui un riferimento alle teorie di Freud o di Schopenhauer? Ma non era lui che prima accusava i primitivi d'essere imprecisi nel descrivere le condizioni ultraterrene dei morti? Che cos'è preferibile dire: che “i morti sono i vivi per eccellenza” (p. 49), o – come dicono gli occidentali, credenti o atei che siano – che bisogna vivere il più a lungo possibile, anche in condizioni terribili, del tutto debilitanti, perché la vita è una sola o perché la vita ci è stata data da Dio e non possiamo togliercela?
L'autore si stupisce che uno stregone, mentre dorme tranquillamente sulla stuoia, creda di poter assumere nello spirito (o nel sogno) le fattezze di un animale feroce in grado di aggredire qualcuno. Perché in occidente cosa fanno tutti i giorni, possibilmente in tutte le ore, i politici, gli avvocati, i commercialisti, i giornalisti, i bancari, le forze dell'ordine e militari e altri “professionisti” del genere che, mentre parlano di democrazia, di diritti umani, di benessere, di sicurezza, di progresso e di sviluppo non hanno scrupoli nel mandare in rovina chi sbarra loro la strada o chi non li segue con convinzione?
Nella nostra civiltà materiale il culto degli antenati è una pura formalità. Ci ricordiamo di loro quando mostriamo le fotografie che li ritraggono o quando facciamo visita ai cimiteri. Noi occidentali non abbiamo un vero culto degli antenati, ma solo di noi stessi. Chi ha il coraggio di dire che li percepisce in maniera costante, viene considerato una persona disturbata. Eppure se c'è una cosa non contraria allo sviluppo degli umani sentimenti e del tutto contraria all'esigenza di accumulare beni per poter vivere una vita tranquilla, non è forse questo tipo di culto? Tutto quanto ci appartiene non viene forse preso o ereditato da qualcuno, il quale, il più delle volte, non avendo fatto alcun sacrificio per ottenerlo, tenderà probabilmente a fare la fine del “figliol prodigo”? E tutti noi non dovremo forse presentarci al cospetto dei nostri antenati, mostrando come siamo riusciti a conservare o a realizzare una società umana e naturale?
L'autore è lontanissimo dal capire che l'unica religione che conta è quella che predica il culto della natura e degli antenati. Una comunità deve sentirsi in armonia con ciò che la circonda, cioè con la Terra, che è “madre”, in quanto la nutre, e con l'Universo, da cui la Terra proviene e a cui dovrà tornare. Il culto degli antenati non è una forma di superstizione del mondo primitivo, ma un'esigenza di equilibrio, di armonia, tipica di una visione olistica, integrata, della realtà.
Il fatto che gli indigeni rifiutino di attribuire agli antenati e ai morti in generale delle caratteristiche sovrumane, è indice di maturità. I cristiani, col loro culto dei santi e della Vergine Maria, sono sicuramente più infantili, più superstiziosi. Anzi, il fatto di attribuire a delle figure estranee, che in vita non si sono mai viste né conosciute, dei poteri miracolosi, in virtù dei quali si pensa di poter risolvere i tipici problemi dell'antagonismo sociale, significa credere in una magia della peggior specie, usata proprio per negare la necessità di lottare contro le ingiustizie.
Non si può avere nei confronti degli antenati un atteggiamento di soggezione né di superiorità. Tutti dovranno rendere conto di ciò che hanno fatto per mantenere il pianeta nella sua integrità originaria. Tutti dovranno mostrare gli sforzi compiuti per assicurare una gestione egualitaria dei bisogni umani. La Terra è solo un banco di prova: il destino del genere umano va ben oltre quello del nostro pianeta. Non si può popolare l'intero universo senza aver chiari i limiti naturali, le condizioni umane in cui è possibile farlo. Ciò che è stato distrutto, dovrà essere ricostruito, se risulterà conforme all'essenza originaria delle cose.
Non è strano che l'autore non abbia trovato, nelle relazioni etnografiche prese in esame, alcun accenno alle conoscenze, molto precise, dei primitivi circa le caratteristiche alimentari e curative delle centinaia di piante che dovevano per forza conoscere per poter sopravvivere nella foresta? I resoconti che leggeva avevano tutti lo scopo di giustificare il colonialismo europeo? Possibile che neanche per un momento gli sia venuto in mente che l'atteggiamento di vaghezza, di reticenza, di indeterminazione, da parte dei primitivi, potesse essere un'arma con cui difendersi dalle ingerenze dei colonizzatori, dalle loro pretese ideologiche?
Dipinge i primitivi come se fossero dei bambini impauriti di tutto a causa della loro ignoranza, della loro scarsa propensione a farsi una cultura scientifica. Con ciò è come se volesse dire ai colonizzatori: il primitivo non può essere perseguitato, ma va compatito, poiché vive costantemente nella paura di tutto quanto non conosce; per poterlo “occidentalizzare” occorre un atteggiamento “pedagogico”, cioè pazienza, persuasione ragionata, anche perché non si tratta di atteggiamenti individuali, ma collettivi, difficili da superare, in quanto dipendono da culture ancestrali, che l'Europa ha superato da tempo.
Poi alle pp. 36-7 riporta la dichiarazione che uno sciamano eskimo, Aua, fa all'etnologo danese K. Rasmussen circa la mentalità mistica della propria tribù; e la considera come una prova convincente della fondatezza delle sue tesi antropologiche. “Noi non crediamo, abbiamo paura!”. Cioè i primitivi “credono” in maniera mistica perché hanno “paura” delle forze negative della natura, quelle che impediscono loro di vivere in tranquillità. Queste forze non vengono “spiegate”, ma prese così come sono. La natura, mostrandosi come una potenza nettamente superiore alla forza umana, va sommamente rispettata. Essa non è gestita da un'unica divinità, ma da tanti spiriti, che a volte sono buoni e a volte cattivi.
L'autore considera questo atteggiamento del tutto comprensibile, visto che è privo di conoscenze scientifiche, e però non può fare a meno di considerarlo nettamente inferiore a quello occidentale, che, in forza della scienza, non ha paura di nulla. Tant'è che quando lo sciamano prosegue il suo pensiero con un'ulteriore affermazione, questa non lo induce a pensare che anche l'atteggiamento occidentale di voler sottomettere la natura in tutte le maniere sia non meno sbagliato di quello di chi ne accetta, con rassegnazione, tutte le sue manifestazioni.
Dice quindi lo sciamano, lasciando intuire una grande saggezza, che però l'autore non coglie: “È per questo che i nostri padri hanno ereditato dai loro padri tutte le antiche regole di vita che sono fondate sull'esperienza e la saggezza di generazioni. Non sappiamo dire come, non sappiamo dire perché, ma osserviamo queste regole per vivere lontano dalla sventura” (p. 37).
Lo sciamano considerava le tradizioni ancestrali come la “scienza” più sicura per la propria popolazione. Aveva nei confronti delle tradizioni quel profondo rispetto che in Europa occidentale è sempre mancato; quel rispetto che noi europei ci siamo sentiti in dovere di rifiutare proprio in nome della scienza che, col telescopio e col microscopio, tutto vuole conoscere e in profondità, poiché la borghesia, che gestisce questi strumenti, vuole “dominare” (non “conservare”) la natura.
Ancora una frase dello sciamano: “Abbiamo timore delle forze della natura, per questo ci affidiamo alla tradizione, alla sapienza dei padri”. Questa la filosofia di vita che ha permesso ai popoli primitivi di vivere per migliaia e migliaia di anni, così diversa dalla nostra, che, grazie alla scienza e soprattutto alla tecnica, ci permette di non avere paura di nulla.
Conclude infine lo sciamano, mostrando un grande senso dei pericoli insiti nel colonialismo europeo; quel senso che Lévy-Bruhl non possiede, pur mostrando una scienza avvolta nell'aureola moralistica del kantismo: “È per questo che abbiamo le nostre tradizioni, che non sono le stesse dei bianchi. I bianchi vivono in un altro paese, e occorrono loro altre regole di vita”.
Lo sciamano non stava dicendo che le loro tradizioni erano “superiori” alla scienza degli europei, ma semplicemente che si trattava di due conoscenze differenti, incompatibili quando gli ambienti vitali sono opposti. Stava invitando gli europei a non essere colonialisti, a restarsene a casa propria, a non imporre per forza le loro convinzioni a chi è abituato a vivere diversamente.
Che cosa potremmo dire oggi a un primitivo che la pensasse ancora così? Anzitutto dovremmo dirgli che, non avendo i bianchi rinunciato al proprio colonialismo, tutte le tradizioni degli indigeni, anche le più ancestrali, sono assolutamente a rischio di estinzione. (6) In secondo luogo che su questo pianeta non c'è alcun modo d'impedire che la scienza dei bianchi non abbia conseguenze deleterie su tutte le popolazioni del pianeta. Cioè non esiste alcuna possibilità, da parte di alcuna popolazione, di sottrarsi a questa perniciosa influenza del cosiddetto “progresso”. In terzo luogo gli diremmo che per vincere questa gigantesca disgrazia dell'umanità bisogna unire le forze, nel senso che le comunità indigene devono uscire dal loro isolamento, devono cercare di superare le loro frustrazioni tribali e sentirsi parte di un unico progetto mondiale di emancipazione. Unire le forze nella diversità delle tradizioni per abbattere un nemico comune, per tutelare insieme la natura e riportare l'umanità alla condizione originaria, in cui l'uguaglianza sociale regnava sovrana e la libertà di tutti era garanzia per la libertà di ciascuno.
Accettando queste proposte, gli ultimi primitivi rimasti scopriranno di avere tanti atteggiamenti comuni, di essere imparentati tra loro così strettamente, pur nelle profonde diversità dovute agli ambienti, da far invidia alle tendenze massificanti dell'odierno globalismo capitalistico. L'unico modo che hanno di poter uscire dalla paura è quello di unirsi per combattere ciò che li opprime da almeno mezzo millennio (ma, considerando la nascita dello schiavismo, da ben seimila anni). Non è quello di acquisire la scienza e la tecnologia dei colonizzatori.
Bisogna far capire alla scienza borghese che la paura di non riuscire a sopravvivere proviene da questa stessa scienza, postasi al servizio delle esigenze del capitale. Scienza e Capitale, Mercati mondiali e Stati nazionali sono le principali minacce alla sopravvivenza del genere umano e della natura. Bisogna fare in modo che siano loro ad aver paura di loro stessi, di ciò che hanno creato a partire dalla nascita dei Comuni italiani, che sono all'origine della mentalità e dello stile di vita borghese.
M. Finiani, L'arcaico e l'attuale. Lévy-Bruhl, Mauss, Foucault, ed. Boringhieri, Torino 2000.
S. Mancini, Da Lévy-Bruhl all'antropologia cognitiva. Lineamenti di una teoria della mentalità primitiva, ed. Dedalo, Bari 1989.
C. Prandi, Lucien Levy-Bruhl: una introduzione, ed. Armando, Roma 1989; Lucien Lévy-Bruhl: pensiero primitivo e mentalità moderna, ed. UNICOPLI, Milano 2006.
P. Di Palma, Lucien Lèvy-Bruhl: dalla scienza dei costumi all'antropologia, ed. M. Pacini Fazzi, Lucca 1983.
F. S. Nisio, Lucien Lévy-Bruhl: filosofia, scienze sociali, giustizia, ed. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019.
G. Bertolini, La ricerca di Levy-Bruhl, “Rivista di Sociologia”, n. 14/1967.
A. Bixio – T. Marci (a cura di), Società moderna e pensiero primitivo, ed. Rubbettino, Roma 2008.
Note
(1) I suoi iniziali interessi filosofici lo portarono dapprima verso Kant (L'idea di responsabilità, del 1884), in seguito verso Jacobi, nella ricerca del valore delle facoltà extra-razionali dell'uomo, e verso il positivismo di Comte per cercare una connessione tra filosofia e scienza, che poi riuscì a trovare nella spiegazione sociologica di Durkheim, anch'egli di origine ebraica, come lo sarà poi un altro grande etnologo francese, Lévi-Strauss. Tuttavia a livello autobiografico egli ammise il proprio debito nei confronti di Spinoza e Hume, dei quali apprezzava l'esigenza di trovare un punto d'incontro tra ragione e passioni. Egli non vide mai una tribù primitiva coi propri occhi, ma si limitò a leggere le relazioni di vari etnologi: M. C. Schadee, J. H. Hutton, K. Rasmussen, E. Best, J. P. Mills...
(2) Di lui si possono leggere anche La mentalità primitiva, CDE, Milano 1991; L'anima primitiva, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1990; La mitologia primitiva, ed. Newton Compton, Roma 1973; Psiche e società primitive, ed. Newton Compton, Roma 1970; I quaderni, ed. Einaudi, Torino 1952. L'esperienza mistica e i simboli presso i primitivi, Le funzioni mentali delle società inferiori, La morale e la scienza dei costumi non sono stati ancora tradotti in italiano.
(3) Inutile dire che questo modo d'impostare la conoscenza del mondo primitivo venne sfruttato, al tempo dell'autore, da una sfilza di psicologi, psicanalisti e psichiatri per sostenere una certa concordanza tra le forme elementari del pensiero magico e i comportamenti dei pazienti nevrotici e psicotici in cura da loro. Cfr U. Fabietti, Storia dell'antropologia, ed. Zanichelli, Bologna 1996, e E. De Martino, Magia e civiltà, ed. Garzanti, Milano 1962.
(4) Se c'era del razzismo nelle idee positivistiche di Lévy-Bruhl, era del tutto involontario. Egli infatti simpatizzava per il socialismo riformistico, e lo dimostrò finanziando, nel 1904, la nascita del giornale “L'Humanité”, diretto dall'amico Jean Jaurès, e sempre con Jaurès prese pubblicamente le difese di Alfred Dreyfus, accusato di tradimento, e non solo perché era suo parente.
(5) Lévy-Bruhl non fu mai contrario al colonialismo, anzi i suoi testi, scritti in un linguaggio non specialistico, sembrano essere indirizzati proprio agli amministratori coloniali, invitandoli a comprendere le caratteristiche della mentalità primitiva e a non usare le maniere forti per indurre gli indigeni a superarla. Riteneva che la Francia fosse la nazione culturalmente più avanzata del mondo, anche sul piano linguistico, in grado di portare il meglio di sé alle popolazioni colonizzate.
(6) P.es. a Porto Rico, una semicolonia degli Stati Uniti dal 1898, il popolo dei Taino è scomparso a causa del genocidio commesso dai colonialisti spagnoli, soprattutto a causa delle malattie infettive (nel 1492 erano in 230.000 ma nel 1548 si erano ridotti ad appena 500). Il DNA di questo popolo (il primo degli amerindi a trasferirsi nei Caraibi) si trovò mescolato con quello dei colonizzatori e degli schiavi africani al loro seguito. Oggi Porto Rico ha lo status di Commonwealth, ma potrebbe diventare il 51° stato federato dell'Unione. Più della metà della sua popolazione (4,3 milioni) si è trasferita negli Stati Uniti.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube