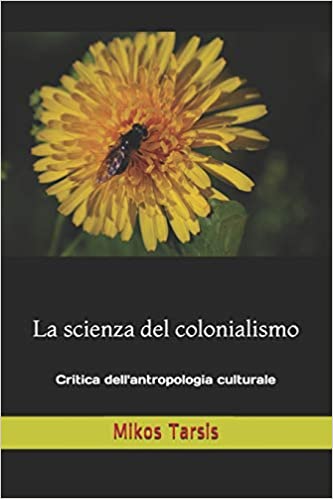
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Un pianeta troppo piccolo
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Stiamo avvertendo il nostro pianeta troppo piccolo per continuare ad abitarlo. Ma il genere umano percepisce questa cosa in maniere molto diverse tra loro. Negli ultimi decenni del Novecento abbiamo sostituito all'immagine di un mondo abitato da una pluralità di culture separate, facilmente distinguibili le une dalle altre, la percezione di una specie di “villaggio globale” (così definito dal sociologo canadese Marshall McLuhan), in cui tutto appare interconnesso e interdipendente, e dove, più che di “culture” (diverse tra loro, impermeabili), occorre parlare di “gruppi di persone”, le cui culture si influenzano reciprocamente.
Era sbagliata l'idea di prima, ed è sbagliata quella di adesso. Prima del colonialismo infatti le culture del pianeta non erano affatto separate le une dalle altre, ma si influenzavano a vicenda, in tutta tranquillità. Persino durante l'epoca dello schiavismo lo facevano, seppur con meno tranquillità (per es. la filosofia greca presenta tracce ben visibili di culture africane e assiro-babilonesi). A partire dal moderno colonialismo, invece, la cultura occidentale, che ha preteso di egemonizzare l'intero pianeta, ha indotto le culture più deboli a isolarsi, a rinchiudersi in se stesse, nella speranza di potersi difendere meglio. I deboli, sul piano tecnologico, hanno avvertito gli altri come estranei e hanno cominciato ad averne paura. Parlare di “villaggio globale”, in una condizione di tale sudditanza, è ridicolo, a meno che non s'intenda che tale villaggio è pervaso da un'unica cultura, quella del capitale.
Oggi il capitalismo è così mondiale che non ha neppure bisogno di esercitare il colonialismo con l'uso della forza militare. Il mondo intero sembra aver accettato l'idea che gli stili di vita possono essere soltanto due: o di tipo “borghese” o di tipo “proletario”. Entrambi con mille sfumature diverse. Tutti si sforzano di vivere lo stile di vita borghese, perché appare più comodo, più facile, più appagante. Sono forse stili di vita reciprocamente dipendenti, come nel celebre apologo di Menenio Agrippa? Diciamo che non si potrebbe condurre una vita borghese se non ci fosse un proletariato da sfruttare. Diciamo anche che il proletariato non avvertirebbe di vivere una condizione precaria se non ci fosse uno stile di vita borghese.
Per queste ragioni, e non avendo consapevolezza della possibilità di un'alternativa radicale, il soggetto proletario fa di tutto per diventare “borghese”, cioè per emanciparsi dalla propria condizione. I grandi flussi migratori, che avvengono in tutto il mondo, in direzione dei paesi più benestanti, lo dimostrano. I poveri del mondo vogliono trasferirsi nei luoghi ove è più facile diventare “borghesi”. In questa maniera non fanno che perpetuare il regime di sfruttamento mondiale dal quale sono fuggiti. Essi avvertono i loro luoghi d'origine troppo angusti, troppo miseri per poterci vivere bene. Hanno bisogno di avvertire il mondo come un “villaggio globale”, in cui ci si può spostare con relativa facilità in cerca di fortuna.
Tuttavia anche i borghesi avvertono il luogo in cui vivono troppo stretto. Proprio a causa di queste imponenti migrazioni, sentono minacciata la loro ricchezza e non vogliono condividerla oltre un certo limite. D'altra parte se tutti vogliono diventare “borghesi”, chi farà la parte del “proletario”? Per la borghesia il mondo sta diventando piccolo proprio perché la grande massa dei proletari vuole imborghesirsi.
Anche i grandi affaristi avvertono il mondo sempre più piccolo, soprattutto quando entrano in scena nuovi competitori su scala internazionale, oppure quando si accorgono che talune fondamentali risorse, che permettono grandi profitti, vanno esaurendosi. La grande borghesia teme i flussi migratori proprio perché sa di non poter sfruttare i proletari con la stessa facilità di un tempo, quando sulla scena internazionale vi erano pochi competitori. Anzi, sta addirittura pensando di dirigere tali flussi verso alcuni paesi capitalistici da destabilizzare, al fine di poterli depredare delle loro ricchezze o di renderli più docili ai ricatti finanziari.
D'altra parte non è possibile ripristinare la schiavitù fisica di un tempo: si andrebbe incontro a obiezioni di tipo etico. Oggi, in tutto il mondo, si dà per scontato che chiunque ha diritto almeno alla libertà giuridica, quella formale, la quale, anche se non garantisce alcun benessere economico, permette comunque di cercarlo. Lo schiavo, oggi, può essere solo una persona che accetta “liberamente”, cioè “formalmente”, un contratto salariale. Il salario, anche quando irrisorio, salva le apparenze di una certa libertà di scelta: sostituisce la frusta di un tempo.
Dunque, alla borghesia il mondo appare piccolo anche perché questa imponente massa di proletari non può essere schiavizzata nella maniera classica. La borghesia non ha più il diritto di vita e di morte sugli schiavi. Almeno non può più averlo formalmente, proprio perché nel passato ci si è opposti a questo trattamento inumano. Non esiste nemmeno più la dipendenza personale del servo della gleba. Persino la stessa borghesia ha combattuto questo stile di vita. I contadini lottavano per liberarsi dalle prepotenze e dalla soggezione nei confronti dei feudatari, che volevano vivere di rendita. Ma la stessa borghesia aveva bisogno che i contadini si liberassero della loro servitù per poterli avere come operai nelle proprie fabbriche. Tutti gli operai erano stati, un tempo, contadini.
Oggi non è facile neppure fare l'operaio in occidente. I dirigenti d'azienda sanno di avere a che fare con molti concorrenti nel “villaggio globale”. I migranti vengono a cercare un lavoro ben retribuito nelle aree più ricche del pianeta, ma da queste aree le aziende vengono trasferite nelle aree geografiche dove il costo del lavoro o delle materie prime o delle tasse da pagare è minimo. Oppure, se questi processi di trasferimento delle imprese da un luogo all'altro appaiono troppo onerosi, i grandi imprenditori si trasformano in grandi finanziatori. Non costruiscono ricchezza effettiva, basata sulla produzione, ma fittizia, basata sul credito.
Dunque, a che serve emigrare in società che sono ormai “post-industriali”? dove la ricchezza sta nei servizi che si offrono? Molti servizi sono complessi, richiedono una buona dose di competenza, per la cui acquisizione ci vuole un certo tempo, una istruzione superiore. Per un immigrato, che voglia svolgere un lavoro legale, ben remunerato, non è facile “imborghesirsi”. Forse ce la faranno i suoi figli, se potranno accedere a un'istruzione di qualità.
Una volta si svolgevano lavori semplici in fabbrica, dove era la macchina a “dettar legge”. Ma oggi le macchine sono gestite da computer sofisticati, oppure vengono dismesse o delocalizzate in luoghi più convenienti, anche perché inquinano terribilmente, e nessun imprenditore vuol pagare multe salate, o spendere una fortuna negli impianti di tutela ambientale. Il macchinismo, qualunque esso sia, devasta l'ambiente, e l'occidente preferisce farlo il più possibile nel Terzo Mondo, là dove i poveri non sono capaci di protestare e dove, pur di sopravvivere, sono disposti ad accettare qualunque condizione.
Insomma, il mondo, per una ragione o per l'altra, è diventato piccolo per tutti. Viviamo in un villaggio globale in cui gli interessi in gioco sono opposti, in perenne conflitto tra loro. Quanto potrà durare questa situazione? E soprattutto, dopo che il bubbone sarà scoppiato, si sarà capaci di trovare delle alternative praticabili? delle soluzioni che non facciano rinascere degli antagonismi irriducibili, quelli che ci hanno portato a queste assurdità?
Siamo diventati così ingestibili che, oggi, quando si usa il termine “indigenizzazione” (come fanno p.es. Marshall Sahlins e Arjun Appadurai), non s'intende tanto una resistenza locale (tribale) ai processi di omologazione del capitalismo mondiale, ma si intende una certa capacità di assimilazione “personalizzata” o di traduzione “locale” di processi che avvengono all'esterno e nei cui confronti non ci si può opporre in maniera significativa. L'unica cosa che si può fare è quella di recepirli nella maniera meno dolorosa possibile, meno traumatica. In questa maniera si pensa che sia possibile tutelare ciò che resta della propria identità locale (tribale).
Ma ha senso una resistenza del genere, quando il “locale” viene sempre più fagocitato dal “globale”? Se “indigenizzazione” vuol dire “acculturazione”, per le comunità primitive è finita. Non ci sarà alcuna rivincita del “locale” sul “globale”. Qualunque modificazione operata da parte delle culture indigene, relativamente a un proprio comportamento o prodotto culturale, porterà alla perdita della propria identità, poiché le differenze, tra “noi” e “loro”, nell'uso della natura e nel modo di vivere le relazioni sociali sono abissali. “Integrarsi”, nell'accezione “borghese”, vuol dire acquisire una nuova identità, completamente diversa dalla precedente: è bene che le comunità indigene sappiano che non potranno conservare quasi nulla del loro passato. Atteggiamenti come quello di Paulinho Payakan, tanto per fare un esempio, non potranno essere tollerati. (1)
Se chi, da posizioni socialiste, contesta l'attuale sistema capitalistico, prospettando un suo superamento qualitativo, ha il dovere di rispettare integralmente lo stile di vita delle comunità indigene, o comunque di permettere loro di ripristinarlo nei suoi valori più autentici, se nel passato non avevano potuto farlo a causa del colonialismo. Se tale rispetto verrà considerato positivamente da tali comunità, ciò significherà che il superamento del capitalismo sarà avvenuto in maniera pienamente democratica. Il rispetto integrale della libertà degli indigeni deve diventare la cartina di tornasole della credibilità di tutte le posizioni politiche anticapitalistiche. In tal senso qualunque forma di socialismo che non metta in discussione l'esistenza dello Stato, del mercato e della tecnologia basata sull'industrializzazione, va guardata con sospetto.
I fallimenti di tutte le esperienze socialiste del passato, utopistiche o scientifiche, riformistiche o rivoluzionarie, mercantili o statalistiche, vanno addebitati alla totale incomprensione dello stile di vita delle comunità primitive. Queste, in attesa del crollo del capitalismo, devono isolarsi il più possibile dai processi attuali di globalizzazione, limitandosi a utilizzare, se vogliono, i mezzi di comunicazione di massa per contrastarli. Per esempio possono denunciare con forza il fatto che il capitalismo non conosce alcun rispetto per la natura e che la sua sopravvivenza dipende soltanto dalla possibilità di ampliarsi continuamente a danno dei più deboli, aumentando in intensità o in estensione la propria capacità distruttiva o predatoria.
Fare appelli “ecologici” alle imprese che basano la loro esistenza sui profitti economici, non ha alcun senso; come non ne ha farli ai governi politici che tutelano gli interessi di quelle aziende. Possono però acquistare un senso se la denuncia viene utilizzata per dimostrare che le imprese vanno espropriate e rese pubbliche, o che i governi che non fanno nulla per impedire le devastazioni ambientali, vanno rovesciati. La tutela dell'ambiente garantisce la sopravvivenza del genere umano. Chi non la rispetta, andrebbe messo in condizioni di non nuocere.
Che l'attuale globalizzazione non abbia alcunché di democratico è dimostrato anche dal fatto che il capitalismo, pur avendo fagocitato le comunità indigene, considerandole una forma di diversità estranea, obsoleta, rozza e primitiva, non è riuscito all'interno delle proprie nazioni a creare un benessere diffuso per tutta la popolazione. Infatti tendono a formarsi continuamente delle realtà emarginate, che soffrono enormemente uno stile di vita basato sull'antagonismo sociale e sullo sfruttamento della natura. La diversità distrutta all'esterno, in mezzo millennio di colonialismo, continua a riproporsi all'interno, come risultato di un individualismo esasperato, di una disintegrazione dei valori umani.
Se l'antropologia vuole aiutare le comunità primitive ad esistere, deve mettersi a studiare le realtà marginali del mondo capitalistico, quelle esistenti nei centri urbanizzati, e quelle esistenti nei centri periferici soggetti a tutte le forme neo-colonialistiche. Deve mostrare e, con dati alla mano, dimostrare che quanto più cresce la globalizzazione tanto più aumentano le forme di marginalizzazione. In particolare la classe operaia dei paesi occidentali deve smettere di rendersi complice dello sfruttamento del Terzo Mondo perpetrato dalle aziende capitalistiche presso cui lavora. Gli operai devono insorgere non solo per abolire la proprietà privata dei fondamentali mezzi produttivi, quelli che garantiscono l'esistenza delle società capitalistiche, ma anche per mettere in discussione la legittimità di tali mezzi produttivi, il cui impatto sui processi naturali si sta rivelando sempre più devastante.
Nota
(1) Il capo dei Kayapó, Paulinho Payakan, fece nascere un movimento di resistenza in Amazzonia contro la costruzione della diga idroelettica ad Altamira nel Parà sul fiume Xingu (detta anche Diga di Belo Monte). Ebbero la meglio sul governo brasiliano, anche perché la Banca Mondiale rinunciò a concedere il prestito.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube