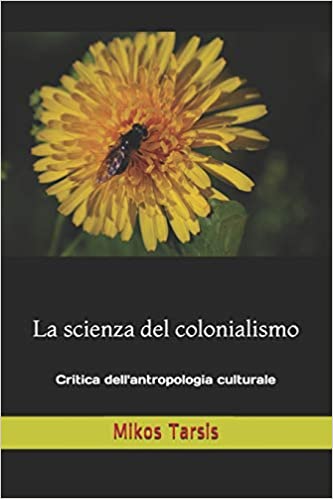
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Oltre Tylor
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Il concetto tyloriano di “cultura” venne messo in crisi dalle ricerche fatte dagli etnologi direttamente presso le comunità primitive. L'antropologia da tavolino di Tylor, Morgan e Frazer, che dalle loro cattedre universitarie impartivano lezioni sui resoconti di chi aveva visitato luoghi esotici da colonizzare (missionari, esploratori, militari, medici, mercanti...) (1), fu superata dagli antropologi che praticavano il fieldwork, cioè il “lavoro sul campo”.
Vediamo, in sintesi, le idee di Tylor:
- la cultura è un insieme composito e integrato di norme, usanze, comportamenti di una determinata comunità, che, nel caso di quelle primitive, si mantiene più o meno inalterata nel tempo, soprattutto se la comunità è di piccole dimensioni, isolata dallo sviluppo urbano coloniale;
- la cultura ha una natura olistica, cioè è una totalità in sé conclusa, le cui parti sono in reciproca relazione;
- la cultura si sovrappone alla natura, distinguendo l'uomo dall'animale, che è incapace di usare strumenti simbolici;
- la cultura si trasmette alle nuove generazioni attraverso un processo verticale e discendente, dal più anziano al più giovane.
Contro queste idee si è cominciato a dire, a partire dagli anni Settanta del XX sec.:
- non esiste una cultura universale condivisa da tutti gli esseri umani, cioè non esistono valori minimi o fondamentali in cui tutti gli esseri umani si possono riconoscere;
- la cultura non è un insieme compatto e stabile, ma un processo in continuo mutamento, i cui confini non sono invalicabili o impenetrabili;
- natura e cultura si influenzano reciprocamente: se la cultura pretende di sovrapporsi alla natura, ne paga le conseguenze;
- una cultura come totalità a se stante poteva esistere quando le comunità extra-europee erano circoscritte in un'area geografica piccola (un'isola o una vallata protetta dalle montagne), e non conoscevano né la scrittura né un'organizzazione sociale evoluta. Oggi tutto questo, in presenza della globalizzazione capitalistica, tende a scomparire: si è tutti sottoposti a influenze esterne;
- la trasmissione della cultura non è più unidirezionale ma multidirezionale: chiunque può insegnare qualcosa a chiunque, soprattutto se le informazioni, i valori sono veicolati da strumenti tecnologici avanzati. Tende a scomparire la sequenza lineare dell'apprendimento, a vantaggio della circolarità del sapere: tutti imparano da tutti. La democrazia è più produttiva dell'autoritarismo, anche se può apparire più dispersiva.
In virtù di queste convinzioni è diventato oggi abbastanza scontato ritenere che le culture indigene, tribali, stiano scomparendo sotto il peso della diffusione mondiale del capitalismo, che ci vuole tutti “consumatori” di qualcosa. Persino quando le colonie hanno iniziato a liberarsi delle loro madrepatrie (2), i nuovi Stati indipendenti non hanno fatto altro che promuovere delle politiche d'integrazione sociale alle tribù indigene presenti nel loro territorio, le quali dovevano mandare i loro figli nelle scuole statali, dovevano curarsi con la medicina sintetica, dovevano votare in occasione di elezioni, e adempiere a tutti i principali obblighi del “cittadino”. Le comunità indigene tendono a essere sempre più assorbite dalla cultura dominante, che resta “dominante” anche in presenza di processi di decolonizzazione.
I mass-media sono in grado di raggiungere i luoghi più remoti del pianeta. Paradossalmente le ultime comunità indigene stanno diventando un'attrazione di tipo “turistico”, a motivo dei loro manufatti, delle loro usanze, della loro alimentazione, ecc. Nell'analisi di queste comunità la “semplicità” è un lusso che l'antropologo non si può permettere, anche perché quanto più si afferma la dipendenza da fattori esterni, tanto più si diversificano le risposte (soprattutto commerciali) da offrire a tale dipendenza.
In virtù dei mass-media ognuno ha la sensazione di vivere più culture, locali e globali, proprie e altrui, off-line e on-line. L'antropologia ha di fronte a sé il mondo intero, percepito nella sua interezza e complessità. Negli ultimi decenni del Novecento ci si è convinti che col colonialismo si è imposta l'idea di un “villaggio globale” (planetario), che tende a uniformarsi in maniera consumistica. Oggi è la tecnoscienza, gestita dai grandi capitali produttivi e finanziari, a dirci come dobbiamo essere “umani”.
Nell'intero pianeta la cultura sembra essere diventata una sola: al massimo sono ammesse delle varianti, una relativa autonomia in uno spazio (o anche in un range) molto circoscritto e fino a quando esigenze superiori non decideranno di ridurla a zero. La diversità sta scomparendo sotto il peso della uniformità, della omologazione. Ci sentiamo parte di un unico mondo, ma non sulla base di comuni sentimenti umani, di valori minimi condivisibili, di approcci equivalenti ai processi naturali. Siamo in realtà tutti schiavizzati da poteri che sfuggono completamente al nostro controllo.
Quando si parla di “cultura delocalizzata”, non s'intende la presenza di più culture autonome, che possono interagire tra loro in piena libertà, ma s'intende il fatto che i processi decisionali non appartengono al luogo in cui si vive. La cultura è “delocalizzata” soltanto perché non è attribuibile a un gruppo sociale preciso, a un ambiente specifico, connotato fisicamente, territorialmente. Il razzismo biologico è stato superato dall'uniformità sempre più spiccata degli stili di vita.
L'umanità è sempre più divisa in due grandi gruppi umani: quelli che producono molto e consumano poco, e quelli che consumano molto e producono poco. La stragrande maggioranza del genere umano lavora molto e consuma poco. Il capitale pensa che per produrre molto bastino poche macchine potenti, efficienti, fatte funzionare da lavoratori esperti, usati come schiavi salariati. Chi è privo di mezzi culturali (o chi pensa di possederli inutilmente) avverte solo angoscia e frustrazione. Di qui la continua esigenza di trasferirsi altrove, di emigrare in cerca di fortuna.
Continua imperterrito a riproporsi il problema sollevato dal socialismo due secoli fa: il capitale è in contraddizione irriducibile col lavoro. A questo problema oggi se ne è aggiunto un altro: il lavoro non può emanciparsi dal capitale senza mettere in discussione l'uso delle macchine, che è incompatibile coi processi di sviluppo o di riproduzione della natura. Il crollo della ecosostenibilità del macchinismo ha posto all'ordine del giorno l'esigenza di una elaborazione fortemente ecologistica delle idee del socialismo. Di qui il ritorno dell'interesse per le comunità primitive.
Note
(1) A dir il vero Tylor nel 1855 visitò il Messico per dedicarsi a studi di archeologia ed etnografia.
(2) Forse può apparire esagerato che in questo testo si continui a parlare di “colonialismo”, quando si sa benissimo che a partire dalla fine della II guerra mondiale gli imperi coloniali europei hanno iniziato a disgregarsi. Tuttavia in questi ultimi 70 anni si è formato una sorta di “neo-colonialismo”, consistente in una dominazione più sofisticata e apparentemente meno brutale, più economico-finanziaria che politico-militare. In ciò il ruolo degli Stati Uniti è dominante. Oggi è sufficiente l'arma del debito o dell'embargo commerciale per mettere un'intera nazione in gravi difficoltà. È impossibile uscire dal colonialismo, vecchio e nuovo, se non si diventa una grande potenza capitalistica o se non si esce completamente dalle dinamiche predatorie delle multinazionali. Significativo resta il fatto che tutti gli Stati che si sono emancipati politicamente dal colonialismo, a partire dal secondo dopoguerra, non riescano a non riprodurre, nei confronti delle comunità indigene autoctone, lo stesso trattamento discriminante che esse subivano in precedenza dal colonialismo occidentale.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube