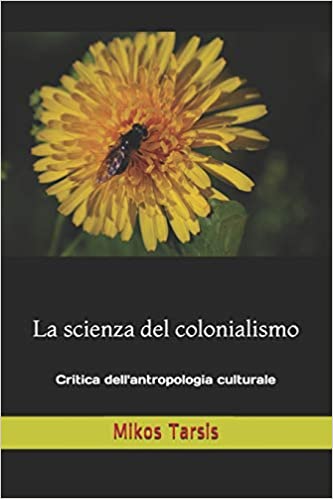
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Stato e Nazione di fronte alle Etnie
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
I gruppi etnici li rispettiamo con malcelata sopportazione o con indifferenza, come una sopravvivenza del passato, destinata, prima o poi, a estinguersi.
Nelle moderne società industriali esistono i singoli e lo Stato. I singoli possono essere sposati o no, avere figli o no; possono essere iscritti a partiti, sindacati, associazioni, cooperative, club, ecc.; possono lavorare alle dipendenze di qualche istituzione pubblica o privatamente (in questo secondo caso possono essere sul libro-paga di qualcuno o in autonomia). Oggi è possibile credere nella religione che si vuole o non credervi affatto, benché in Italia vi sia ancora quell'assurdità chiamata “Concordato” (o Patti Lateranensi) recepita dall'art. 7 della Costituzione. Si possono parlare le lingue che si vogliono, ma la lingua nazionale va conosciuta. Si può votare il partito che si vuole, ma per farlo si deve avere la cittadinanza. Tutti devono avere dei documenti di riconoscimento, soprattutto per guidare un veicolo a motore o per ricevere assistenza sanitaria o aprire un conto in banca o per rapportarsi con uffici pubblici e cose del genere. Le tasse sono obbligatorie per tutti, almeno in teoria, poiché in pratica chi può evaderle, grazie all'aiuto del proprio commercialista, lo fa. L'istruzione è obbligatoria e gratuita fino a una certa età, anche se una famiglia può assicurarla ai propri figli in forma privata. Un tempo il servizio militare era obbligatorio e temporaneo per tutti i maschi, salvo eccezioni previste dalla legge; oggi invece tende a essere fatto, da entrambi i sessi, su base volontaria e professionale, e quindi in maniera permanente. Tutti sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato, soprattutto la sua Costituzione, ma gli avvocati sono in grado di difendere egregiamente le persone più facoltose o autorevoli che pensano di essere superiori alla legge.
Ecco quanto caratterizza l'identità di un cittadino, che, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, ai propri beni patrimoniali, può essere definito “indigente” o “benestante”. Altre varianti sono dovute al fatto che lo Stato di appartenenza può essere di diverse tipologie politiche (in alcuni casi le tipologie possono essere anche ideologiche: si pensi per es. allo Stato del Vaticano, dove la monarchia ha un carattere assolutistico).
Ogni Stato dice di voler rispettare le minoranze (linguistiche, religiose, etniche ecc.) (1), ma in nessun caso le considera come un esempio da imitare; può anche cercare di tutelarle in maniera significativa, ma, in definitiva, ciò che più gli preme è l'unità nazionale. Se la minoranza è numericamente rilevante e pretende poteri particolari, possono sorgere delle tensioni: in tal caso lo Stato dovrà cercare delle intese, dei compromessi ragionevoli, senza venir meno al principio fondamentale dell'unità nazionale, che prevede precisi confini geografici.
Gli Stati nazionali sono intolleranti per definizione, in quanto non amano le identità locali o specifiche. In nome della loro astrazione politica, militare e burocratica pretendono una certa omologazione nello stile di vita, nella mentalità, nei valori culturali fondamentali. Quando nel 1992 scoppiarono a Los Angeles incredibili disordini in seguito all'assoluzione di quattro poliziotti bianchi, colpevoli d'aver pestato l'afroamericano Rodney King, la minoranza nera approfittò di quel sopruso per prendersela anche coi coreani, ritenuti lontani dal sistema generale di valori americani, che include, fra le altre cose, un certo “fair play” (per es. la disponibilità a “sorridere” nei rapporti umani).
L'identità nazionale o l'appartenenza a uno Stato sono concetti astratti, imposti dall'esterno. Anche il concetto di “razza” lo è (o lo è stato): serviva per giustificare il colonialismo europeo, cioè per esportare la civiltà borghese e per conservare quanto si era acquisito con l'uso della forza. Nei casi estremi, quando le popolazioni non volevano essere conquistate, si usava il concetto di “razza” per praticare il genocidio (o etnocidio), al termine del quale i sopravvissuti venivano confinati in appositi luoghi.
Storicamente la borghesia ha voluto uno Stato nazionale, avendo interesse a realizzare un unico mercato interno, con pesi, misure, monete... validi per tutti. Nell'ambito di questo mercato tutti i cittadini sono uguali (almeno all'apparenza), poiché tutti possono comprare o vendere. Non si è cittadini in quanto appartenenti a qualcosa di “specifico”, e quindi di diverso rispetto ad altre realtà, ma lo si è in quanto ci si conforma a una prassi dominante, di tipo economico e finanziario: la compravendita di un bene o di un servizio, di una merce o di un titolo di credito, ecc.
La sfera economica, negli Stati capitalistici, al cospetto della quale si è sostanzialmente degli individui singoli, ha finito col prevalere su tutte le altre sfere sociali e culturali, caratterizzate da un certo senso del collettivo. Tutto ruota attorno al concetto di “proprietà dei mezzi produttivi”. Un cittadino può credere in ciò che vuole, ma nell'ambito di un mercato o è produttore o consumatore: tutto il resto ha un valore molto relativo.
Quando si dice che le etnie sono il prodotto di costruzioni socio-culturali, bisognerebbe aggiungere che, in genere, sono basate su valori umani e naturali. Viceversa, la borghesia, che è anti-etnica per definizione, essendo nazionale e soprattutto internazionale, si basa su valori che di umano e di naturale non hanno nulla. I valori li ha presi dal cristianesimo, stravolgendone completamente il significato (imitando, in questo, l'atteggiamento che le autorità della Chiesa romana avevano tenuto nel corso del Medioevo). I valori della borghesia sono puramente teorici, fittizi, smentiti quotidianamente dalla prassi, che è cinica, volgare, materialistica.
Nell'ambito del capitalismo lo Stato non fa che favorire il più possibile questa esigenza uniformante, omologante della borghesia. Ecco perché diciamo che il superamento dello Stato deve andare di pari passo col superamento del mercato. Chiunque compia una rivoluzione politica per abbattere un governo borghese, non può limitarsi a sostituire uno Stato con un altro (come hanno fatto tutte le esperienze socialistiche del passato), ma deve procedere a smantellare in maniera progressiva qualunque forma di dipendenza da realtà esterne, che limitano enormemente la libertà umana.
Per la borghesia si è tanto più liberi quanto più si possiede qualcosa: la libertà è data dalla proprietà materiale. In tal senso è del tutto riduttivo sostenere che la libertà è data dalla cittadinanza. Sulla citoyenneté i governi francesi han costruito il loro modello assimilazionistico, che però non ha funzionato per niente con l'Algeria e che non ha certo risolto i problemi delle banlieues parigine. I gruppi etnici possono beneficiare, per varie generazioni, di tutti i vantaggi della cittadinanza, e parlare perfettamente la lingua nazionale, senza che si verifichi alcun vero processo di assimilazione.
Anche il multiculturalismo di paesi di forte immigrazione, come Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, non è servito granché a garantire un maggior rispetto della democrazia e dei diritti umani. Nelle società fortemente individualistiche “multiculturalismo” vuol dire soltanto una cosa: ognuno deve stare nel proprio “recinto” (o ghetto o quartiere o riserva), se vuole conservare la propria specificità. In caso contrario, se vuol davvero assimilarsi alla cultura dominante, che è tutta consumistica, deve rinunciare a ciò che più lo caratterizza.
La cultura liberal-democratica, nonostante si sforzi d'essere internazionale, tende a preferire i dirigenti politici dalla pelle chiara, o almeno dai lineamenti europei, di fede protestante (al massimo, cattolica, ma senza fanatismi di sorta, senza “dipendenze politiche” dal papato). Questi leader devono essere capaci di esprimersi in inglese anche quando non è la loro lingua-madre, devono essere preferibilmente di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta, abiti tipicamente occidentali, senza uso di orecchini, peircing e tatuaggi visibili (le cicatrici sono ammesse solo se costituiscono delle ferite da guerra, ma non devono essere sul volto). Devono essere fondamentalmente monogami, possibilmente non divorziati e non troppo prolifici (l'eventuale amante va tenuta ovviamente nascosta). Dieteticamente è meglio che siano onnivori, altrimenti rischiano di apparire “ideologici”, anche se oggi non mangiare carne viene visto in maniera positiva. Devono avere il senso dell'umorismo e dell'autoironia, per soddisfare le esigenze dei mass-media. Devono essere salutisti, esibendo, nel tempo libero, un corpo tenuto in forma, senza adipe: il grasso fa pensare a una mancanza di carattere e a una tendenza a sudare quando si è in pubblico. Oggi è importante apparire anche ambientalisti, quindi vanno bandite le sigarette e persino l'uso della pipa: i denti devono essere molto bianchi e ben allineati. Eventualmente le mogli possono dimostrare sul piano pratico l'amore per l'ecologia. La statura non può essere né troppo alta né troppo bassa, per evitare spiacevoli confronti con altri leader. Anche l'età dovrebbe essere nella media: le persone anziane danno il senso della rassegnazione. Quando parlano devono essere sereni, tranquilli, distaccati: non devono avere il cosiddetto “sguardo da rettile”, quello che punge con gli occhi, mettendo in imbarazzo. Devono essere capaci di parlare in pubblico senza leggere alcunché, salvo i casi in cui si possono usare pochi foglietti come pro-memoria (in televisione si usa il cosiddetto “gobbo”), ma i discorsi troppo lunghi, in una civiltà basata sull'immagine, sugli effetti scenici, sulla spettacolarità dell'azione, sarebbe bene evitarli, a meno che l'uditorio non sia composto di specialisti, cioè di persone abituate ad ascoltare con pazienza. Quando parlano possono mostrare d'essere appassionati di qualcosa, ma non devono far leva su sentimenti di odio o di risentimento nei confronti di qualcuno, tanto meno per motivi personali, a meno che, in un determinato momento, non sappiano di fare un favore a una fetta molto grande di popolazione, che, di tanto in tanto, ha bisogno di trovare un capro espiatorio su cui scaricare le proprie frustrazioni. In tal senso quando dichiarano guerra o una “persecuzione”, devono farlo nella maniera più legale possibile, mostrando che si è fatto di tutto per non arrivare a soluzioni estreme. Devono far vedere di rappresentare anzitutto una “volontà popolare”.
La cultura borghese si è formata in un lasso di tempo molto lungo (i primi Comuni nacquero mille anni fa): non è possibile assimilarla velocemente, neanche se si fosse in presenza di una integrazione non violenta, non imposta con la forza. La borghesia vive rapporti “contro-natura”, sia a livello sociale che ambientale. Per acquisirli si dovrebbe come minimo abbracciare la religione cristiana, che, col suo astratto idealismo, favorisce una grande ipocrisia, separando nettamente il dire dal fare. L'odierna Cina, tanto per fare un esempio eclatante, ha certamente acquisito in tempi molto brevi, lo spirito commerciale del capitalismo, ma, non avendo mai avuto il cristianesimo come religione dominante, continua a restare molto indietro nell'uso ipocrita dei diritti umani. Peraltro il maoismo, che è stato una variante rurale dello stalinismo, ha pensato di poter superare il cristianesimo propagandando l'ateismo, ma non ha capito che per superarlo in maniera mistificata occorre anche un'etica cinica o una certa concezione distorta della morale, che la borghesia ha sviluppato all'interno dello stesso cristianesimo: cosa che il socialismo maoista non ha mai potuto fare, essendo stato soltanto un'ideologia politica autoritaria. Non a caso oggi il partito comunista ha ripristinato i valori del confucianesimo, che è una semplice filosofia di vita favorevole all'obbedienza nei confronti delle istituzioni.
Insomma, anche quando si appartiene a un collettivo (per es. a una etnia), la finalità sociale deve essere sempre quella di accumulare dei beni e di scambiarli usando il denaro. Per sentirsi libero, il cittadino deve vendere qualcosa, o deve essere capace di risparmiare per poter comprare qualcosa. Il valore di un qualunque bene o servizio, materiale o immateriale, coincide col suo prezzo di mercato, che è impossibile quantificare in maniera scientifica, in quanto le varianti che intervengono per formarlo sono innumerevoli. Non basta rifarsi al tempo di lavoro socialmente necessario. Il valore di un qualunque bene o servizio può essere calcolato in mille modi diversi, ma alla fine è il mercato che decide, che è tutto meno che razionale. In un certo senso non è neppure importante che vi siano dei prezzi basati sulla libera concorrenza o sul monopolio: l'importante è che si possa parlare di un prezzo monetario. Là dove non esistono mercati, non esiste neppure moneta circolante. Al massimo esiste il baratto, cioè lo scambio alla pari di beni o servizi, basato sulle proprie eccedenze produttive o sul proprio tempo a disposizione.
Se esiste autoproduzione e quindi autoconsumo, il mercato ha un'importanza molto relativa. Finché si acquista sul mercato ciò che permette la propria esistenza, la libertà non esiste. Essere liberi vuol dire poter compiere delle scelte in autonomia. L'unico vincolo possibile dovrebbe essere quello stabilito dal collettivo di appartenenza, caratterizzato da una preferenza per la dimensione locale. Il che non vuol dire che le comunità autogestite debbano vivere in maniera isolata o separate tra loro, ma soltanto che possono esercitare autonomamente la gestione delle risorse produttive (alimentari, abitative, ecc.) e la democrazia diretta per le decisioni comuni. (2) Le etnie sono sempre state in contatto tra loro, non solo per praticare il baratto, ma anche per esigenze esogamiche. Sposarsi tra parenti indebolisce i geni. Quindi non è vero che un gruppo etnico porta a escludere altri gruppi etnici. Se c'è libero e reciproco consenso, si può far tutto, anche allearsi per combattere e vincere un nemico comune, come per es. fecero alcune tribù indiane al tempo del generale Custer.
L'appartenenza astratta, generica a uno Stato è sempre vissuta come un'imposizione dall'esterno, come una insopportabile burocrazia, come una indebita ingerenza nella propria vita, personale e collettiva che sia.
Quando si appartiene a una comunità locale, si può anche non avvertire una profonda differenza tra vita privata e vita pubblica. Questo perché in un contesto locale ci si conosce tutti, ci si frequenta con una certa assiduità, e quindi si sa ciò che gli altri fanno. Ma quando si vedono dei rappresentanti dello Stato, civili o militari, è impossibile non avvertirli come degli estranei. Costoro infatti pretendono di comandare solo perché sono stati inviati dallo Stato. Ciò è insopportabile, per cui si farà di tutto per ridurre al minimo il peso dei loro poteri, almeno finché queste autorità esterne non capiranno che i loro poteri possono essere esercitati solo dopo aver ottenuto un certo consenso da parte dei cittadini locali.
Questo per dire che in un contesto davvero democratico, ciò che più conta è l'identità del gruppo locale, coi suoi valori di riferimento, con le sue relazioni sociali e di parentela, che nel tempo si sono consolidate e che possono essere tenute sotto controllo, al fine di evitare pericolose tensioni disgreganti. Ecco perché una nazione dovrebbe coincidere con una etnia o un gruppo tribale, come accadeva tra i nativi nordamericani. Ha senso che il territorio dei Tuareg sia diviso tra cinque Paesi: Mali, Niger, Algeria, Burkina Faso e Libia e che migliaia di loro vivano in esilio in Mauritania?
Si è fatto un gran dire in Polonia, al tempo del socialismo statale, quando si pretendeva di considerare la nazione cattolica più autentica dello Stato comunista. Però quando lo Stato è crollato, non si è permesso al mezzo milione di ortodossi di creare un proprio Stato. Probabilmente anche gli ebrei avrebbe voluto fare la stessa cosa. Recentemente ne avrebbero diritto i filo-russi in Ucraina, i catalani e i baschi in Spagna; e che dire degli scozzesi o dei gallesi in Gran Bretagna? O dei bretoni e dei corsi in Francia? In Europa esempi di questo genere si sprecano. Gli Stati, al massimo, concedono una certa autonomia amministrativa (nel migliore dei casi anche finanziaria), ma mai e poi mai una anche politica. L'Italia, per es., diventerebbe un colabrodo, anche se la democrazia ne trarrebbe un gran vantaggio, benché sia ridicolo pensare che l'autonomia politica di una etnia o di una regione sia il massimo della democrazia in presenza del capitalismo. Quando l'Italia era divisa in tanti Principati borghesi, era preda degli appetiti di Stati unificati stranieri. Gli stessi Principati erano perennemente in guerra tra loro, salvo pacificarsi temporaneamente di fronte a un pericolo comune, proveniente dall'esterno della penisola.
La situazione attuale delle etnie e regioni potrebbe essere migliorata nell'ambito del capitalismo, solo se l'autonomia non fosse “concessa” dallo Stato, ma semplicemente “riconosciuta”, o al massimo reciprocamente “concordata”. Se lo Stato fosse intelligente non aspetterebbe la minaccia di attentati o di una guerra civile o di una secessione, prima di riconoscere la legittimità dell'autonomia locale o regionale. Purtroppo però la caratteristica dominante degli Stati borghesi è solo quella di mascherare la propria brutalità, il proprio cinismo con delle belle frasi sui vantaggi dell'unità nazionale, sull'importanza della democrazia parlamentare, sull'equidistanza da parte delle istituzioni e altre amenità del genere. Quando si insiste nel volere un'autonomia regionale, subito si levano le voci di chi vorrebbe una repubblica presidenziale proprio per impedire la paventata “frammentazione” dei poteri, cioè un presidente della repubblica molto autorevole, eletto direttamente dai cittadini, simile a quello statunitense, che in fondo è come un “monarca”.
In poche parole l'autodeterminazione può essere solo conquistata con la forza. Ne sanno qualcosa gli irlandesi o le nazionalità che si sono separate dalla ex-Jugoslavia, finite però nelle braccia del capitalismo europeo. Quello che è accaduto in Cecoslovacchia, in cui la repubblica ceka e quella slovacca si sono separate di comune accordo, può essere considerato un'eccezione. In Italia tutte le etnie e minoranze linguistiche o religiose han vissuto grandi difficoltà di sopravvivenza: Ladini, Occitani, Albanesi, Carnici, Corsi, Ebrei, Friulani, Grecanici, Sloveni, Mocheni, Rom e Sinti e altre ancora, che oggi, peraltro, in seguito ai flussi migratori, sono continuamente in aumento.
A volte si dice che anche il gruppo etnico ha il senso della proprietà, in quanto tende a identificarsi con un territorio specifico, in cui vuole risiedere. Ora, a parte il fatto che tale appartenenza territoriale può anche essere il risultato di un condizionamento storico subìto da forze sociali superiori alla propria, generalmente quello che manca alle etnie (almeno a quelle pre-borghesi) è proprio l'uso aggressivo della proprietà. La condivisione dei beni è relativa alla percezione comune di un certo senso di precarietà delle cose. (3) Poiché la terra, coi suoi frutti, viene considerata come un dono della natura, il senso della proprietà privata è ridotto al minimo, e solitamente coincide con la proprietà personale degli oggetti di uso quotidiano. Peraltro le etnie originarie erano tutte nomadiche: la stanzialità è subentrata quando è stata inventata l'agricoltura, i cui interessi si sono subito scontrati con quelli dell'allevamento del bestiame, che richiede campi non recintati, riforniti di acqua e di pascoli freschi.
È contraddittorio essere nomade e avere il senso della proprietà privata, a meno che dei gruppi etnici nomadici non si coalizzino per togliere di mezzo le comunità che praticano lo schiavismo. Ma in questo caso si dovrebbe parlare di “pirateria”, una cosa molto simile alla gestione “privatistica” della proprietà borghese, legittimata dalla presenza dello Stato, tant'è che il socialismo riformista, per qualificare la proprietà borghese, parla di “furto”.
Là dove le precipitazioni sono scarse o imprevedibili, il trasferimento delle mandrie allevate era inevitabile. Ma là dove erano regolari e abbondanti si praticava in genere l'agricoltura: l'allevamento riguardava quei pochi animali domestici che aiutavano nel lavoro, nei trasporti e che integravano la dieta alimentare con latte, burro, yogurt, formaggi, carne e sangue. Gli allevamenti stanziali e specializzati di tipo industriale, luoghi di tortura per tutti gli animali, sono stati possibili solo sotto il capitalismo.
Note
(1) Oggi, più che da una religione specifica, l'etnicità è definita dalla lingua che si parla, da certe usanze relative ai legami di parentela, da certe abitudini alimentari, dalla partecipazione a talune feste o riti, laici o religiosi.
(2) La futura democrazia diretta non potrà basarsi sui vincoli parentali né su una rappresentatività astratta e impersonale del potere. La stessa divisione del lavoro non potrà dipendere da fattori oggettivi, indipendenti dalla volontà dei soggetti. La democrazia diretta va dimostrata quotidianamente, affrontando esigenze comuni con chi ci sta accanto.
(3) Cfr AA.VV., L'arte della condivisione. Per un'ecologia dei beni comuni, ed. UTET, Novara 2015.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube