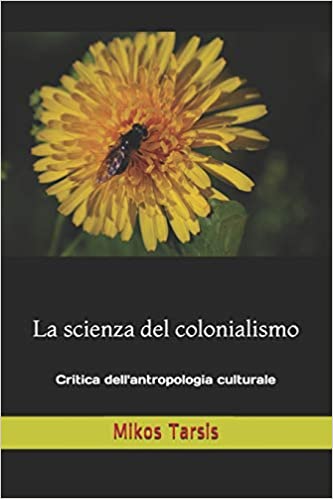
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Salvare il salvabile
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Oggi, in tutto il mondo, gli indigeni rappresentano circa il 6% della popolazione mondiale, cioè circa 370 milioni di persone appartenenti a 5.000 etnie diverse, di cui 150 milioni appartenenti a popoli tribali, distribuiti in 70 Paesi su 5 continenti. I popoli più numerosi sono: i Quechua, 10 milioni di persone che vivono tra il Perù, la Bolivia, l'Ecuador; i Nahuati, 5 milioni di persone che vivono in Messico; gli Aymara, 2 milioni di persone che vivono tra il Perù e la Bolivia. Gli ultimi cacciatori e raccoglitori vivono nelle aree marginali del pianeta, quelle meno sfruttate dal capitale, come i deserti, le foreste pluviali, le regioni circumpolari. Basta però che qualche multinazionale si accorga dell'esistenza di risorse molto richieste sui mercati, come p.es. gli idrocarburi, i diamanti e l'oro, ed ecco che inizia la progressiva spoliazione anche di quei territori estremi. Diventa pericoloso persino il turismo esotico, quello esclusivo delle battute di caccia.
In tutto il mondo i cacciatori-raccoglitori sopravvivono in ambienti che presentano gli ostacoli maggiori alla produzione alimentare: questa è stata la loro fortuna, altrimenti da tempo il progresso tecnologico della borghesia li avrebbe spazzati via. Si sono letteralmente “rifugiati” in queste aree remote del pianeta, cercando di sottrarsi il più possibile al “progresso”, come se sapessero molto bene che i vantaggi di tale sviluppo riguardano solo un'infima minoranza di persone e che non esiste alcun “effetto a cascata” nel promuovere il benessere di pochi a vantaggio di molti (che è l'idea prevalente sostenuta dal liberismo di sempre). Lo svizzero Gilbert Rist ha definito il concetto neoliberista di “sviluppo” una specie di credenza religiosa, in quanto si crede in ciò che non si vede. (1)
Tra i principali nemici delle comunità indigene non vi sono soltanto le multinazionali straniere ma anche gli stessi governi dello Stato in cui risiedono. Facciamo alcuni esempi. Ad Haiti negli anni Ottanta l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti (USAID) inviò milioni di piantine d'albero per rimediare alla drammatica deforestazione in corso: 50 milioni di alberi ogni anno venivano abbattuti per ricavare legname con cui soddisfare le esigenze urbane; inoltre i contadini, nei terreni disboscati, avevano preso a coltivare alcuni prodotti da vendere al mercato o a far pascolare capre e pecore. Ebbene, quando arrivarono le piantine, il governo chiese ai contadini di interrarle, ma loro, sapendo ch'erano destinate a durare molto tempo, le diedero da mangiare ai loro ovini. Solo quando, tramite alcuni antropologi, si capì che i contadini sarebbero stati disposti ad accettare delle piante di breve durata, come per es. gli eucalipti, che crescono velocemente e che dopo quattro anni possono essere tagliati per la vendita del legno sul mercato, il progetto andò in porto. Ma si trattò ovviamente di un rimboschimento molto relativo. Questo per dire che se non si ascoltano le esigenze delle popolazioni locali, i progetti di sviluppo, pensati dagli esperti occidentali conseguono sempre risultati opposti a quelli preventivati. (2)
Nella media valle del fiume Senegal è stata costruita una grande diga che ha tolto agli abitanti della vallata la possibilità di praticare, grazie alle periodiche esondazioni, l'agricoltura, la pesca, la silvicoltura e la pastorizia. Per venire incontro alle loro esigenze, i gestori della diga rilasciavano grandi quantità di acqua che provocavano ulteriori danni alle ultime coltivazioni rimaste. La conseguenza più eclatante di ciò fu l'emigrazione in massa verso le grandi città. Chi invece ha avuto il coraggio di restare, si è ammalato di schistosomiasi, una patologia causata da alcuni parassiti presenti nelle pozze di acqua stagnante che si formano a valle della diga.
Altro esempio. Da molto tempo i governi thailandese e laotiano cercano di convincere gli orticoltori degli altipiani a rimpiazzare la coltura illegale dell'oppio con un'altra o a trasferirsi in pianura, ma non vi sono mai riusciti sia perché la domanda occidentale di eroina è ancora molto forte, per cui la coltivazione resta molto redditizia, sia perché i terreni rimasti liberi a valle hanno una scarsa resa produttiva: infatti chi ha deciso di trasferirsi lì ha peggiorato il proprio tenore di vita. Peraltro le imprese di legname che hanno potuto accedere alle colline, hanno danneggiato le foreste molto di più di quanto hanno fatto gli orticoltori locali.
In America Latina succede la stessa cosa. L'occidente si lamenta della grande produzione di foglie di coca. Ma le società minerarie, i grandi allevatori, le imprese del legname, i cercatori di metalli pregiati (che inquinano i fiumi col mercurio) non offrono molte possibilità di sussistenza alle popolazioni indigene: o si emigra verso le grandi città, o si coltivano merci vietate, o si entra nel mondo della criminalità organizzata, oppure, nel migliore dei casi, si finisce col diventare guerriglieri.
Il destino delle ultime popolazioni indigene presenti nel pianeta pare segnato, a meno che non siano loro stesse a rivendicare con forza i loro diritti. A dispetto di tutte le teorie integrazionistiche del mondo occidentale, i partecipanti al Primo Simposio sulle Popolazioni Indigene Isolate dell'Amazzonia, del 2005, hanno rivendicato il diritto a restare “isolate”, cioè a non avere contatti di alcun genere con gli estranei, con coloro che vogliono entrare nei loro territori per sfruttarli. L'Alleanza Internazionale per la Protezione delle Popolazioni Indigene Isolate, nonché l'Alleanza Internazionale dei Popoli delle foreste (2008) dovrebbero ricevere la massima attenzione da parte di chi dice di voler combattere il capitalismo. Se il socialismo vuole evitare il rischio di porsi come una mera variante del liberismo, non può fare altro che porre all'ordine del giorno le medesime rivendicazioni delle popolazioni indigene, poiché sono le uniche che mettono in discussione non solo l'uso privatistico della tecnologia, ma anche la tecnologia in se stessa, a prescindere dall'uso che se ne fa. Non è forse sintomatico che nei Congressi internazionali dedicati ai mutamenti climatici queste popolazioni non siano mai invitate?
I Nuer, che vivono prevalentemente di allevamento di bestiame, sono sempre stati in conflitto col governo sudanese, che vorrebbe sfruttare i loro territori ricchi di acqua e di petrolio. In Sudan esistono almeno 600 gruppi diversi, ma il potere coloniale decise che Khartoum era il centro del paese e tutto doveva dipendere da lì. Il governo ha cercato d'imporre un'unica identità a queste tribù, quella arabo-islamica, misconoscendo le specificità tribali. L'etnicità è lo strumento più efficace usato dal governo per spingere le popolazioni a scontrarsi tra loro. Le compagnie petrolifere straniere non si sono mai opposte alla politica governativa. Tuttavia nel 2011 è nato il Sud Sudan, la cui indipendenza dalla Repubblica del Sudan è stata sponsorizzata dagli Stati Uniti. Oggi il Sud Sudan ha 12 milioni di abitanti, in gran parte di popoli nilotici (il Dinka è il gruppo più grande, poi vi è il Nuer, l'Azande e il Bari). Possiede il 75% di tutte le riserve petrolifere dell'ex-Sudan, la cui estrazione (che costituisce il 98% delle entrate nel bilancio statale) ha già procurato un devastante inquinamento. Tutto il nuovo Paese è travagliato dalla guerra civile.
I Boscimani, detti anche San, Khwe, Basarwa, sono un popolo di cacciatori-raccoglitori che vive nel Kalahari, che si estende principalmente in Botswana, nella fascia orientale della Namibia e nel nord-ovest del Sudafrica. Con una superficie di circa 930 000 kmq, è il sesto deserto più grande del mondo. Ha una serie di riserve naturali in cui la caccia è proibita. Vi sono numerosi giacimenti di carbone, rame e nichel, e una delle più grandi miniere di diamanti del mondo. I circa 90.000 Boscimani, che ci vivono come cacciatori-raccoglitori da almeno 20.000 anni (come i Pigmei dell'Africa centrale), sono imparentati coi Khoikhoi, coi quali formano il gruppo Khoisan. Sono stati considerati la possibile fonte della linea di discendenza del DNA mitocondriale della Eva vissuta in Africa fra i 99.000 e i 200.000 anni fa.
Il governo del Botswana sta tentando di distruggere la loro cultura attraverso la sedentarizzazione forzata nelle città. Per es. col pretesto di trasformare in una riserva naturale, ottenendo finanziamenti internazionali, la riserva di caccia del Kalahari centrale, il governo, tra il 1997 e il 2002, ha trasferito altrove 3.000 boscimani (Basarwa San), che pur vi vivevano da tempi immemorabili. Li convinse assicurando loro la gratuità di servizi scolastici, sanitari e di formazione professionale: tutte cose di cui nella foresta non avevano alcun bisogno. Il risultato ottenuto fu la trasformazione di una comunità di efficienti cacciatori-raccoglitori in famiglie totalmente dipendenti dallo Stato. Nel 2006 l'Alta Corte del Botswana si rese conto dell'errore madornale e impose al governo di restituire la riserva di caccia. Tuttavia il governo aggirò l'ostacolo giuridico, permettendo solo ai 189 querelanti la possibilità di ritornarvi e solo a condizione di costruire abitazioni temporanee, di usare pochissima acqua (nel 2002 il governo aveva già chiuso il pozzo principale) e di praticare la caccia solo dopo aver ottenuto regolare permesso. Insomma dopo l'inganno la beffa.
Ancora oggi diversi gruppi San sono stati costretti a unirsi per rivendicare il diritto di ricevere una quota dei profitti nella commercializzazione dell'hoodia gordonii, una sostanza che si estrae da piante simili ai cactus, diffuse nella regione del Kalahari, che le multinazionali usano come rimedio per perdere peso, e che gli indigeni invece usano nei periodi di carestia per alleviare i morsi della fame.
“Pigmei” è un nome collettivo indicante molti sottogruppi poco numerosi, ognuno dei quali costituisce un popolo a sé (p.es. i Twa, gli Aka, i Baka, i Mbuti, gli Efe). Vivono prevalentemente come cacciatori-raccoglitori nel bacino del Congo e in altre regioni dell'Africa equatoriale. Il numero totale dei Pigmei africani si stima inferiore a 250.000. La tribù pigmea degli Efe (cacciatori-raccoglitori seminomadi) commercia coi Lese (contadini stanziali in piccoli villaggi). Ebbene, pur esistendo uno scambio equivalente tra prodotti forestali e agricoli, gli uomini Lese possono sposare donne Efe (e i loro figli vengono considerati dei Lese), ma gli uomini Efe non possono sposare donne Lese, proprio perché gli agricoltori si considerano superiori ai cacciatori. A parte questa eccezione, per i matrimoni, che sono di natura esogamica, è previsto che il gruppo che riceve una sposa è tenuto a concedere una donna a quello da cui la sposa proviene.
Pigmei (così come i Boscimani) vivono da migliaia di anni senza aver sviluppato alcuna forma di produzione alimentare, ivi inclusa l'orticoltura. Essi conoscono l'uso del denaro, ma preferiscono praticare il baratto coi vicini agricoltori Bantu, evitando il surplus da vendere sul mercato urbano. Cacciano con arco e frecce avvelenate. Lavorano l'osso e il legno. Le donne si dedicano alla raccolta. Conoscono molto bene le piante velenose, commestibili e curative. Ogni tribù, composta di poche famiglie, si sposta periodicamente da un accampamento all'altro, restando sempre entro un'area circoscritta. I loro diritti territoriali non vengono riconosciuti da alcuno Stato.
I Nativi nordamericani, compresi i “mezzosangue”, sono poco più di 5 milioni. Le tribù riconosciute sono 567. Molti nativi vivono nelle riserve, ma circa il 30% ora abita in città. La più grande concentrazione di indiani urbani (circa 60 mila persone) si trova nell'area di Los Angeles. La riserva più grande è quella dei Navajo (oltre 180 mila abitanti). In Canada vivono circa 300 mila indiani e 25 mila eschimesi. Al momento si parlano ancora più di 100 lingue indiane diverse. In tutto il continente americano ci sono ancora circa 43 milioni di nativi. In Messico gli indios sono approssimativamente il 15% della popolazione totale: sono discendenti diretti di aztechi, maya e altre civiltà antiche.
Negli Stati Uniti non si è mai smesso di lottare contro i Nativi americani. P.es. negli anni 1953-59 il governo federale pose fine a qualunque forma di finanziamento delle riserve indiane, allo scopo di obbligare i Nativi a urbanizzarsi. Il risultato fu spaventoso: si crearono dei “ghetti rossi” dove la vita era peggiore che in quelli “neri”. Ancora oggi le esigenze del capitale non guardano in faccia a nessuno. Si pensi solo alla costruzione di nuovi oleodotti (access pipeline) nel Dakota, che servono a trasportare il petrolio negli stati centrali degli Usa e a collegare lo stato del Montana al Canada, devastando un ambiente ricoperto di boschi e foreste; ma anche all'estrazione dell'uranio da alcune miniere vicino al maestoso Grand Canyon. Nonostante i loro alti tassi di alcolismo e di suicidio, gli indigeni continuano a protestare. Lo fa anche Leonard Peltier, che da oltre 43 anni è rinchiuso in carcere per prove chiaramente falsificate. Il presidente Obama (figlio di un padre keniano e di una madre antropologa, nonché premio Nobel per la Pace “preventivo”) gli negò la libertà con la motivazione che, siccome si era dichiarato innocente dei reati per i quali fu condannato, non si poteva concedergli la grazia.
I primi Papua arrivarono in Nuova Guinea almeno 60.000 anni fa, probabilmente dall'Asia sudoccidentale. Gli europei vi giunsero all'inizio del XVI sec., sfruttando l'olio di palma. Il Paese è politicamente indipendente dal 1973-75. L'84% della popolazione è autoctona, il 13% di origine europea, l'1% di origine indonesiana, il 2% di altra origine. Vi sono centinaia di gruppi etnici indigeni, il più numeroso dei quali è rappresentato dai papuani. La metà occidentale dell'isola (Papua Occidentale), è territorio indonesiano, teatro di decennali scontri tra le autorità e i separatisti che combattono per l'indipendenza. Proprio la repressione del governo indonesiano e le limitazioni imposte alla libera circolazione hanno prodotto la creazione di migliaia di sfollati, abitanti in fuga dalla Papua Occidentale verso la Papua Nuova Guinea, ammassati lungo il fiume Fly e colpiti dalle inondazioni favorite da una scriteriata attività mineraria.
In Australia vi sono circa 500 diversi popoli Aborigeni, ciascuno con la propria identità linguistica e territoriale, e generalmente organizzati in clan distinti. I primi gruppi risalgono a ben 50.000 anni fa. La loro terra è stata invasa dagli europei (soprattutto inglesi) a partire dalla fine del XVIII secolo, con conseguenze disastrose (le epidemie ne sterminarono decine di migliaia, mentre molti altri furono massacrati per mano dei coloni). Nell’arco di un solo secolo dall'arrivo dei colonizzatori, la popolazione si ridusse da un numero presunto di almeno un milione di persone a soli 60.000 individui.
Prima della colonizzazione, la maggior parte degli Aborigeni abitava in comunità semi-stanziali lungo le coste, sostentandosi di agricoltura e dell'allevamento di pesci e animali. Gli Aborigeni che popolavano invece il deserto dell'entroterra vivevano di caccia e di raccolta. Bruciavano le sterpaglie per favorire la crescita delle piante preferite dalle loro prede ed erano molto esperti nella ricerca dell’acqua.
Il principio giuridico che ha permesso agli inglesi di requisire le loro terre era quello della "terra nullius": le terre venivano giudicate libere da qualunque proprietà quando non erano usate secondo i canoni standard del mondo occidentale. Uno di questi canoni è la presenza dell'agricoltura (o comunque di insediamenti stanziali), come volevano Cicerone, Seneca, Ovidio, Virgilio..., ma anche Locke e Adam Smith. Se la terra viene usata da popolazioni nomadi, dedite a caccia e raccolta, giuridicamente è di nessuno. Fu così che si conquistò l'intero continente. In Australia il governo imperiale britannico, nel 1835, riconobbe per la prima volta la proprietà della terra agli aborigeni, ma la dottrina della terra nullius fu ufficialmente abolita solo nel 1992, in occasione di un ricorso, durato dieci anni, che gli abitanti di Mer delle isole dello Stretto di Torres (Murray Island) fecero all'Alta Corte. Oggi gli Aborigeni stanno ancora aspettando la restituzione della maggior parte delle loro terre.
Più della metà di loro risiede nelle città, spesso in condizioni terribili nelle periferie più degradate. Molti lavorano come braccianti in quelle stesse fattorie che hanno occupato le loro terre ancestrali, ma altri, soprattutto nella parte settentrionale del continente, rimangono radicati nelle loro terre e vivono ancora di caccia e raccolta.
Nel corso del Ventesimo secolo, allo sterminio diretto si è sostituita una politica brutale, volta a togliere i bambini aborigeni ai loro genitori, per affidarli alle famiglie dei bianchi o ai collegi dei missionari, con l'obiettivo di sradicare ogni traccia della loro cultura e della loro lingua. Non è certamente un caso che questa popolazione soffra di un elevato tasso di suicidi e di mortalità infantile e che abbia un'aspettativa di vita molto bassa, senza considerare che il numero degli Aborigeni in carcere è altissimo. I giovani aborigeni compaiono in misura sproporzionata a ogni livello del sistema della giustizia minorile: dalla fase dell'arresto alle procedure che precedono il processo, fino all'ultimo grado della sentenza, e alla condanna. Tendono molto più facilmente dei loro coetanei bianchi a ricadere nella categoria degli “inaffidabili”.
Nel 1984, nel Deserto di Gibson (Australia occidentale), è stato individuato un gruppo di Pintupi, considerati gli ultimi aborigeni australiani a non essere mai venuti in contatto con gli occidentali.
Anche la sorte della tribù degli ultimi 35.000 Yanomami è seriamente in pericolo. Vivono nelle foreste pluviali e sulle montagne tra Brasile e Venezuela. I loro villaggi sparsi (patrilineari ed esogami) contano ciascuno da 40 a 250 abitanti. Il capo del villaggio, che pur rappresenta la comunità con gli estranei, non ha diritto a dare ordini: può usare solo l'esempio e la persuasione. Nei conflitti interni può solo dare consigli. Se coltiva un campo più grande, deve essere più generoso degli altri.
Le loro donne sono raccoglitrici e coltivatrici (coltivano circa 60 tipi di piante diverse, che forniscono quasi l'80% del cibo). Gli uomini sono cacciatori di selvaggina come pecari, tapiri, cervi e scimmie, e spesso utilizzano il curaro (estratto da una pianta) per avvelenare la loro preda (alla pesca partecipano anche i bambini). Conoscono 500 tipi diversi di piante selvatiche (solo di miele sanno distinguere 15 tipi differenti), con cui si nutrono, si curano e costruiscono capanne e altri utensili. Si spostano ogni due o tre anni per evitare che il terreno diventi infertile. La gran parte di loro è stata falcidiata dalle malattie portate dagli europei, soprattutto dai cercatori d'oro brasiliani (garimpeiros), che diffondono la malaria nei loro territori e inquinano i fiumi col mercurio. La corsa all'oro sta devastando gli Yanomami da almeno trent'anni. (3)
Le autorità venezuelane e brasiliane non sono interessate a salvaguardare queste comunità. Anzi, i governi liberisti non si fanno scrupoli a concedere licenze per la deforestazione dell'Amazzonia; quello brasiliano è persino arrivato a regalare, posizionandoli lungo alcuni sentieri della foresta, vari oggetti che le tribù avrebbero potuto utilizzare, come pentole di metallo, asce e maceti, amache di stoffa, sale, fiammiferi, ecc. Quando i nativi si convincono a usare questi nuovi oggetti e accettano quindi un contatto, si spiega loro che le offerte non si ripeteranno e che dovranno lavorare, producendo manufatti da vendere, al fine di guadagnare denaro sufficiente per comprare oggetti d'uso domestico. Li si vuole rendere dipendenti da un mercato, stravolgendo i loro ritmi vitali e portandoli ad ammalarsi molto più facilmente. Se prima, p.es., ottenevano lo zucchero dalla frutta selvatica, ora invece, diventati dipendenti dal saccarosio, cominciano a soffrire di carie dentarie, obesità e diabete.
I Beduini sono "nomadi" dediti alla caccia e soprattutto all'allevamento transumante nelle regioni steppose del nord Africa, della Penisola arabica e della Siria. La popolazione è divisa in tribù. La tribù è suddivisa a sua volta in clan composti da grandi famiglie nelle quali vige il patriarcato. Il capo del clan o della tribù è sempre uno sceicco, cioè l'elemento più abile, saggio o ricco del gruppo. Le donne godono di maggior libertà che non quelle di altri popoli nomadi: possono muoversi a piacere, allontanarsi, mangiare con gli uomini e tenere il volto scoperto. Sono loro che raccolgono radici, erbe, bacche e locuste, che vengono essiccate e conservate per i periodi di magra. Nella tradizione islamica i beduini non sono annoverati fra i migliori credenti.
Quelle più discriminate sono le comunità che abitano i territori palestinesi della Cisgiordania, della striscia di Gaza e del deserto del Negev. Rappresentano il 30% della popolazione del Negev, ma hanno diritto a solo il 5,4% del territorio. Circa 90.000 beduini, su un totale di 200.000, vivono in 45 villaggi, dieci dei quali sono in procinto di venire riconosciuti dallo Stato di Israele. Agli altri 35 viene negato l'accesso a servizi quali strade asfaltate, acqua, fognature, elettricità e raccolta rifiuti. I villaggi “non riconosciuti “ hanno i tassi più elevati di povertà in Israele, con oltre il 71,5% di famiglie beduine che, nel 2007, vivevano al di sotto della soglia di povertà, rapportato al 54,5% delle famiglie arabe non beduine e il 16,2% delle famiglie ebree. Solo il 28% dei bambini beduini completa la scuola superiore.
Mentre è impegnato a rimuovere i Beduini, il governo israeliano fornisce incentivi ai cittadini ebrei perché si trasferiscano nel Negev, al fine di spostare in modo rilevante tale popolazione a scapito dei residenti beduini del posto. Nel 2010 il governo ha riconosciuto retroattivamente decine di singole aziende ebraiche, costruite illegalmente senz'alcuna autorizzazione, nel mentre rifiuta di riconoscere i beduini sulle terre delle quali sono legittimi proprietari.
Nel 2017 vari Beduini disarmati e pacifici sono stati espulsi con la forza delle armi israeliane da Umm al-Hiran nel deserto del Negev (il villaggio era stato fondato nel 1956, ma è rimasto uno dei 46 villaggi beduini non riconosciuti da Israele). Due anni prima il villaggio di Al-Araqib nel deserto del Naqab era stato demolito per la 119esima volta in sette anni e ai suoi abitanti erano stati addebitati dal governo i costi della demolizione! La prima distruzione da parte dei bulldozer israeliani risale al luglio 2010: da allora si sono susseguite con frequenza regolare e senza sosta.
A partire dal 2007, cioè da quando Israele ha imposto il blocco economico alla confinante Striscia di Gaza dopo che Hamas aveva preso il potere, le 12 tribù beduine che popolano il Sinai sono state costrette a fare affidamento sul contrabbando di ogni merce possibile come mezzo di sopravvivenza, muovendosi su piste e vecchie rotte carovaniere solo a loro conosciute. D'altra parte dopo la caduta del premier egiziano Mubarak, il Sinai è diventato terra di nessuno.
L'Amministrazione civile israeliana in Cisgiordania da tempo è intenzionata a espellere migliaia di Beduini dalle terre ad est di Gerusalemme e con forza trasferirli in una nuova città nella Valle del Giordano. La città è prevista per circa 12.500 beduini delle tribù Jahalin, Kaabneh e Rashaida. Concentrare i beduini in alcune città permanenti rappresenta il culmine di un processo di 40 anni di limitazione del pascolo, delle loro migrazioni, del rifiuto di far loro costruire case permanenti nei luoghi in cui hanno vissuto per decenni. Questo processo è stato accelerato dopo che gli accordi di Oslo sono stati firmati nel 1993.
Gli Inuit sono uno dei due gruppi principali in cui sono divisi gli Eschimesi. Attualmente vivono per lo più in Alaska (16.500 ab.), in Groenlandia (oltre 51.000) e in Canada (oltre 50.000). Sono monagamici, non possiedono il concetto di proprietà privata (se non quella degli strumenti con cui cacciano foche, trichechi e balene) e non riescono a concepire l'idea di una struttura politica che regoli la loro vita dall'alto. Sono minacciati non solo dai mutamenti climatici causati dalle potenze industrializzate, ma anche dal fatto che tali potenze vogliono sfruttare le risorse dei loro territori. Il progressivo snaturamento della loro cultura e delle abitudini di vita li sta portando al suicidio o all'alcoolismo. Anche la campagna di Greenpeace sul divieto della caccia alle foche, ha tolto loro uno dei principali mezzi di sostentamento.
Note
(1) Cfr G. Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, ed. Bollati Boringhieri, Torino 1997. Ma vedi anche I fantasmi dell'economia, ed. Jaca Book, Milano 2012.
(2) A onor del vero va detto che coltivare eucalipti per venderne il legno quando le loro proprietà principali sono quelle antinfiammatorie, antidolorifiche, balsamiche e decongestionanti, può apparire abbastanza ridicolo.
(3) L'antropologo fisico americano Napoleon Chagnon diffuse di loro, negli anni Sessanta, l'immagine di un popolo molto violento, anche nei confronti delle proprie donne, al punto che non rinunciavano all'infanticidio femminile, salvo poi praticare la razzia delle donne presso altre tribù. Sarebbero insomma particolarmente inclini alla guerra, in quanto le alleanze tra villaggi sono molto fragili. Tuttavia Marvin Harris e Richard Brian Ferguson hanno spiegato che la loro bellicosità è in aumento proprio a causa del fatto che vengono costantemente sottratte porzioni di foresta alla loro sopravvivenza. Inoltre – come scoprì il giornalista Paul Tierney – lo stesso Chagnon li aveva indotti ad assumere comportamenti aggressivi per rendere i suoi film più avvincenti, e aveva loro regalato machete, asce e fucili a gruppi selezionati per sollecitare la loro cooperazione, suscitando gelosie tra le varie tribù. Quando nel 2012 fu eletto alla National Academy of Sciences, Marshall Sahlins per protesta si dimise, in quanto era convinto che le idee di Chagnon avevano contribuito ad atteggiamenti razzistici contro gli Yanomami.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube