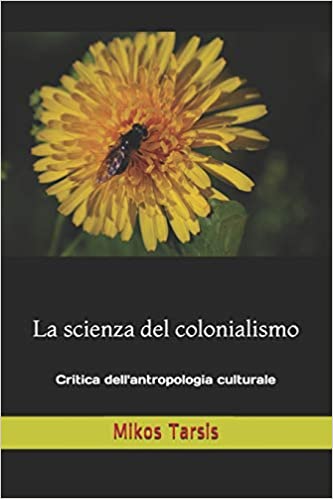
LA SCIENZA DEL COLONIALISMO
Critica dell'antropologia culturale
Victor, un caso emblematico
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Come noto, Jean Itard, medico e pedagogista a Parigi in un Istituto per sordomuti, cercò di studiare assiduamente, nel 1800, il “caso Victor” (1), un ragazzino dall'apparente età di 12 anni, trovato per caso nei boschi dell'Aveyron, nella Francia meridionale, ove vagava nudo con una difficoltosa stazione eretta, nutrendosi di vegetali crudi come ghiande e radici.
Victor, le cui origini non furono mai rintracciate, era stato ricoverato nel suddetto Istituto, in quanto lo psichiatra Philippe Pinel, dopo averlo visitato, lo riteneva affetto da idiozia congenita e pertanto irrecuperabile. Questo perché si strappava le vesti e rifiutava di dormire in un letto, accettando per cibo soltanto patate, noci e castagne crude dopo averle fiutate. Infatti per lui era primario l'olfatto, seguito dal gusto, dall'udito, dalla vista e infine dal tatto.
Non si sapeva dove metterlo, in quanto sembrava comportarsi come un animale, avendo vissuto, probabilmente per buona parte della sua esistenza, nel folto dei boschi. Si diceva fosse stato abbandonato dai genitori perché incapace di parlare, ma si pensò anche, vedendo che aveva un lungo taglio trasversale presso il limite superiore della trachea, all'altezza della glottide, che il ragazzo poteva essere sopravvissuto a un tentato omicidio da parte di chi, forse, l'aveva abbandonato nella foresta.
Itard fece un passo avanti rispetto a Pinel, in quanto aveva a che fare con pazienti non necessariamente problematici sul piano psicologico, i quali, grazie a un certo addestramento, potevano ottenere sensibili miglioramenti. Era convinto che la condizione animalesca di Victor fosse l'effetto non di una malattia mentale, bensì della lunga permanenza nei boschi, ove erano mancate le necessarie sollecitazioni socioculturali.
Partì da un'idea giusta ma seguendo una metodologia che oggi sarebbe stata messa in discussione dagli antropologi più avveduti. Lo portò a casa propria e con l'aiuto della governante si propose di fargli amare la vita sociale, allargare la sfera della sua esperienza sensoriale, ampliare le sue competenze, condurlo all'uso della parola e quindi all'uso della lettura e della scrittura. L'errore stava nel fatto che Itard considerava il contesto sociale borghese come l'unico ambiente di apprendimento.
Egli infatti era convinto che l'uomo “naturale”, che vive a contatto con la sola natura, non ha nulla di “umano”. Il senso di “umanità” è solo il prodotto della “civilizzazione”. Questo perché l'uomo è anzitutto un essere “culturale”. Lasciato a se stesso non impara nulla. Victor, in un quinquennio, fece qualche miglioramento, ma non nell'uso del linguaggio, salvo quello gestuale (non è possibile escludere che soffrisse di ritardo mentale o di autismo). Questo perché, vivendo in mezzo ai boschi, privo della compagnia di qualsiasi essere umano, egli era interessato soltanto ai rumori collegati ai suoi bisogni fisici.
Sostanzialmente Itard non aveva capito che un bambino abbandonato in una foresta non poteva costituire, neanche lontanamente, un esempio di “essere umano naturale”. Semmai era l'esempio di una contraddizione sociale presente nella civiltà borghese, in quanto frutto di un parto indesiderato. (2) Nella foresta la figura umana non era un punto di riferimento: lo erano i lupi, che l'avevano adottato. E, nonostante i suoi limiti “umani” e “sociali” e la sua giovane età, egli era stato in grado di vivere autonomamente nella foresta. (3)
In ogni caso le speranze di recupero di Victor a una vita sociale, coltivate da Itard, finirono quasi del tutto frustrate: i progressi sensoriali, intellettivi e morali erano stati assai limitati, e il ragazzo restava un individuo asociale. Dal 1811 fino alla morte egli visse in una casa privata nei pressi dell'Istituto per sordomuti, ricevendo una pensione statale. Di questo periodo della sua vita praticamente nulla è noto. Morì dimenticato dall'opinione pubblica nell'inverno 1828 e fu sepolto in una fossa comune.
Prendendo spunto da questo caso vediamo ora di fare osservazioni di carattere generale.
Noi guardiamo il diverso da noi come se dovesse diventare uno di noi. Forse è normale che ognuno consideri la propria comunità o addirittura la propria civiltà come metro di misura per comprendere tutte le altre. Questo atteggiamento può apparire un po' provinciale, oltre che presuntuoso. In ogni caso quel che non è normale è il passo successivo, cioè l'esigenza che gli altri diventino come noi, in un modo o nell'altro, con le buone o con le cattive.
Noi occidentali ci sentiamo autorizzati a insegnare agli altri come devono essere. Abbiamo un sapere colonialistico perché abbiamo nel sapere un atteggiamento individualistico di cui non riusciamo a liberarci. Non riusciamo ad accettare l'idea che la storia non può essere vista come un processo evolutivo da uno stadio inferiore a uno superiore. Non riusciamo ad accettarla perché per noi europei il progresso tecnico-scientifico implica, inevitabilmente, una superiorità di tipo etico, giuridico, politico...
In nome del nostro egocentrismo culturale (eurocentrismo cattolico-feudale e protestante-capitalistico) siamo strutturalmente incapaci di comprendere la preistoria o le comunità non antagonistiche. È vero che abbiamo prodotto imponenti opere letterarie, riguardanti ogni campo d'indagine, scandagliando i processi più remoti della psicologia umana, analizzando qualsivoglia situazione sociale; e l'abbiamo fatto offrendo all'umanità una gamma inverosimile di valori umani, civili e politici. Ma tutto ciò è stato possibile proprio perché, in nome del nostro etnocentrismo culturale (che poi è una forma di solipsismo ideologico o di autismo culturale), abbiamo sperimentato un'infinità di orrori, di cui ci siamo solo parzialmente o momentaneamente pentiti. Infatti tutti questi spaventosi abomini non ci hanno mai portato a ripensare radicalmente il nostro antagonismo sociale: siamo solo passati da uno stile di vita a un altro all'interno di un determinato range. L'Europa occidentale (di cui gli Stati Uniti rappresentano la variante più estrema, più “calvinistica”) appare come una propaggine impazzita del grande continente asiatico, un tumore che si è diffuso nel continente americano e successivamente in tutto il pianeta.
Se nella storia esiste una “evoluzione”, essa riguarda unicamente i tentativi che sono stati fatti per superare l'alienazione che ci caratterizza: tutti tentativi rivelatisi, fino ad oggi, fallimentari. Di sicuro da quando è nato lo schiavismo (coi Sumeri nel IV millennio a.C.) non abbiamo mai sperimentato una “ecoluzione”, cioè un progressivo rispetto delle esigenze riproduttive della natura. Il nostro rapporto con l'ambiente naturale è andato sempre più peggiorando, al punto che oggi siamo addirittura in grado di modificare il clima a livello planetario.
Ancora non abbiamo capito che non è la scienza (o meglio la tecnoscienza) a renderci più “umani”, e neppure la cultura, sia essa giuridica, politica o filosofica. È soltanto nei rapporti sociali (che possono essere anche “muti” sul piano scritturistico) e nel rapporto con la natura (quella esistente in maniera indipendente dalla nostra volontà) che possiamo dimostrare d'essere “umani”. Anzi neppure “dimostrare” ma solo “mostrare”, poiché in ciò non vi è alcuna dimostrazione “logica”, alcuna spiegazione razionale. I fatti davvero “umani” dovrebbero parlare da soli, in maniera tautologica, autoevidente, al di là delle specifiche forme che si usano.
Siamo così schiacciati sul nostro presente che abbiamo impedito al passato di potersi confrontare con noi. Noi facciamo riferimento solo a noi stessi, siamo autoreferenziali. Il passato non può dirci nulla di significativo appunto perché non esiste più. Non possono esserci forme completamente diverse dell'esistere in grado d'impedire la priorità, l'unicità della nostra comprensione e interpretazione degli atteggiamenti “umani”. Il nostro presente è autorizzato a giudicare superate tutte le forme del passato appunto perché ha il privilegio d'essere “presente”.
Tuttavia, lo stesso pensiero occidentale è arrivato alla conclusione, in campo fisico-astronomico, che nell'universo il tempo è un concetto molto relativo, non solo a causa della velocità della luce, ma anche a causa del punto di vista dell'osservatore, per non parlare del fatto che in presenza di un universo infinito, cioè illimitato nello spazio ed eterno nel tempo, non è possibile definire alcun centro, alcun punto di partenza, se non appunto in maniera relativa. Tutto il genere umano avrà quindi la possibilità di confrontarsi su quali esperienze ha vissuto sulla Terra. Si dovrà trovare il modo di mettere a confronto delle esperienze che, per quanto riguarda le forme esteriori, sono state molto differenti e hanno provocato effetti molto differenti sull'ambiente sociale e naturale. Non si potrà popolare l'universo scegliendo le forme più pericolose, più devastanti, meno umane e naturali.
I mezzi condizionano lo stile di vita, ma il senso di umanità che alberga in ogni essere umano deve poter avere delle caratteristiche assolutamente comuni, altrimenti il confronto alla pari sarebbe impossibile. Probabilmente l'ultimo tentativo di eliminare in maniera radicale, e quindi in maniera intelligente, cercando di costruire una vera alternativa all'antagonismo sociale (che è il conflitto irriducibile tra opposti interessi), è stato compiuto da Lenin, la cui rivoluzione politica fu tradita subito dopo la sua morte.
I tradimenti sembrano essere una costante dopo quello clamoroso che impedì a Gesù Cristo di compiere l'insurrezione nazionale anti-romana e anti-sadducea. Nel genere umano si è come inoculato un virus refrattario a ogni cura. E siccome non siamo riusciti a debellarlo nel momento iniziale della sua diffusione, ora possiamo aspettarci soltanto conseguenze sempre più catastrofiche, destinate a coinvolgere gran parte della popolazione mondiale. Siamo tutti infettati, e se non troviamo una soluzione condivisa, difficilmente riusciremo a sopravvivere. Ognuno però deve imparare ad assumersi delle responsabilità personali, poiché la fiducia cieca in un leader carismatico non farà che aggravare la situazione.
Note
(1) Jean Itard, Il ragazzo selvaggio, ed. Anabasi, Milano 1995. G. Annacontini, Victor e Itard tra natura e cultura, Adda editore, Bari 2002. M. Bresciani Califano (a cura di), Infanzia e memoria, ed. Olschki, Firenze 2007. V. Brogi – L. Mori (a cura di), II bambino selvaggio, Edizioni ETS, Pisa 2010. G. Genovesi (a cura di), Rileggendo Itard, Pitagora editrice, Bologna 2000. S. Moravia, Il ragazzo selvaggio dell'Aveyron, ed. Laterza, Bari-Roma 1972. Su questo caso si fece anche il film di François Truffaut, Il ragazzo selvaggio (1970).
(2) Il commissario Guiraud, che stese una relazione sul ragazzo, ebbe modo di rilevare la sua strana attitudine a lasciarsi legare porgendo egli stesso le braccia, e ipotizzò che all'origine della sua vita nei boschi stesse una fuga spontanea dai maltrattamenti subiti.
(3) Anche Marie-Angélique-Memmie le Blanc (1712-75) visse per dieci anni nei boschi della Provenza (1721-31), ma dopo che fu ritrovata, riuscì ad apprendere la lettura e la scrittura. Fu l'unica enfant sauvage al mondo a riuscirvi.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube